
Nato ad Albu Kamal, cittadina siriana adagiata sulla sponda occidentale dell’Eufrate, lungo il poroso confine con l’Iraq, dove i jihadisti si contendono reclute, armi e finanziamenti, Hassan Hassan è autore insieme al giornalista Michael Weiss di Isis. Inside the Army of Terror (Simon & Schuster).
Un libro che con un meticoloso lavoro sul campo chiarisce la genesi, il funzionamento, gli obiettivi dello Stato islamico. A partire da un assunto cruciale, spiega all’Espresso Hassan, che lavora come ricercatore all’istituto Delma di Abu Dhabi e che il 18 aprile parteciperà al Festival internazionale del giornalismo di Perugia: per capire le motivazioni e le finalità dell’Isis, più che all’attualità o alla biografia dell’enigmatico al-Baghdadi - l’uomo che dal pulpito della grande moschea al-Nuri di Mosul nel luglio 2014 si è autoproclamato Califfo – è utile guardare altrove. Alla storia recente. In particolare a quella di due uomini: Abu Musab al-Zarqawi, il jihadista giordano fondatore di al-Qaeda in Iraq, e Saddam Hussein, il sanguinario dittatore iracheno.
«Se oggi lo Stato islamico può contare su combattenti più professionali e più brutali di ogni altro gruppo, è grazie a Saddam Hussein. Molti esponenti di peso dell’Isis sono ex membri del regime baathista, con una lunga esperienza nel campo dell’intelligence, della sicurezza, delle operazioni militari». Funzionari che in alcuni casi hanno fatto parte dell’apparato clandestino controrivoluzionario messo in piedi da Saddam Hussein dopo la prima guerra del Golfo «per evitare altre ribellioni tra gli sciiti o i curdi».
Per Hassan, la stessa brutalità dell’Isis andrebbe ricondotta a un’inedita fusione ideologica favorita dal rais iracheno. Quella tra il baathismo, l’ideologia secolare alla base del regime di Saddam, e il salafismo, la corrente teologica dell’Islam sunnita che invoca la purificazione della fede attraverso l’eliminazione dell’idolatria (shirk) e l’affermazione dell’unicità di Dio (tawhid).
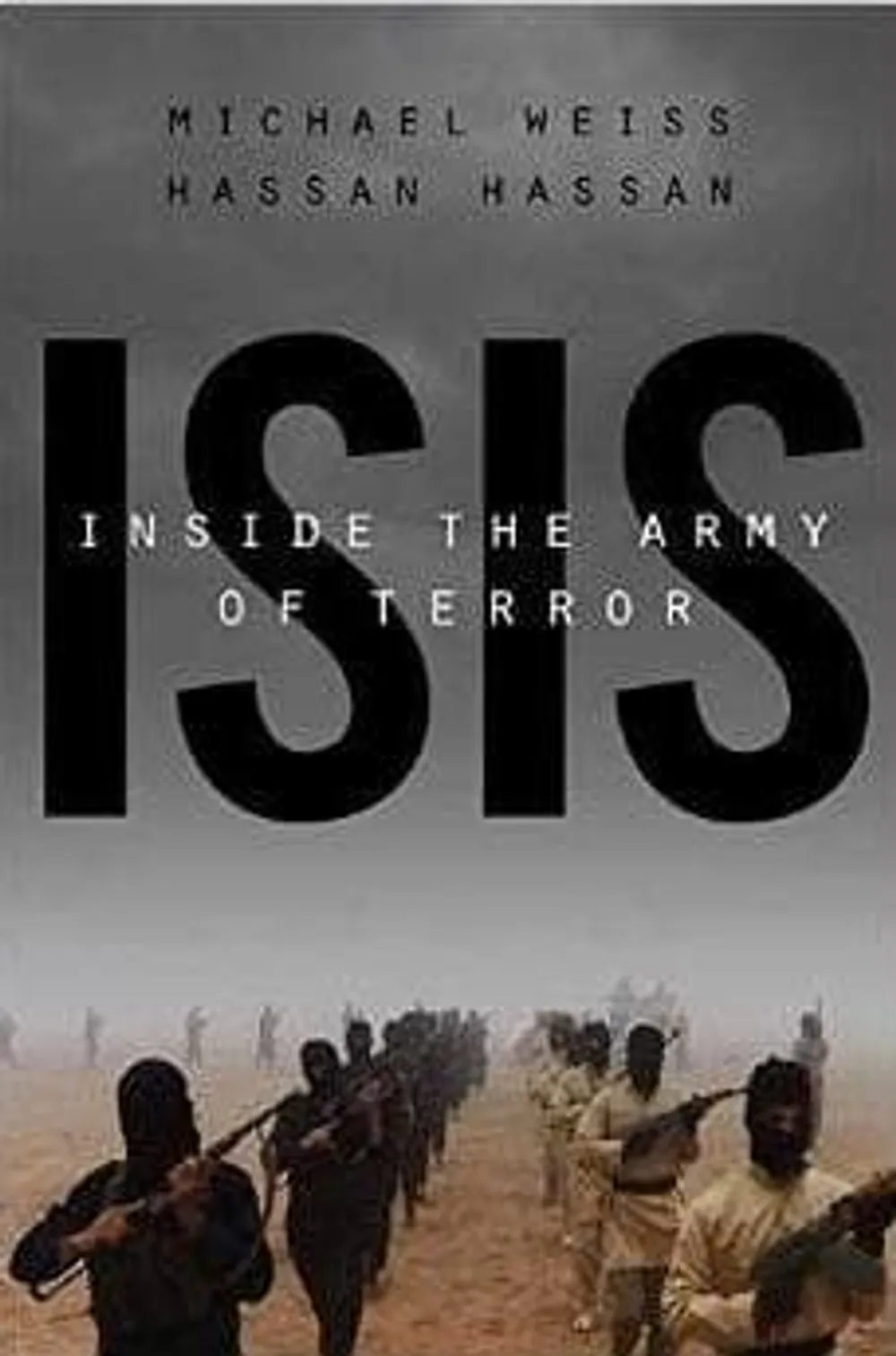
«Negli anni Novanta Saddam ha inaugurato la ‘Campagna per la fede islamica’. Intendeva coniugare il baathismo con l’islamismo. Finanziò viaggi alla Mecca, studi, eventi di propaganda». Ma partorì un mostro. «Molti alti ufficiali finirono con il sentirsi più vicini al salafismo che al baathismo», spiega Hassan. «Furono loro i primi a unirsi alla guerriglia, dopo l’invasione americana dell’Iraq. In seguito, si unirono ai gruppi jihadisti anche gli ufficiali discriminati dal processo di de-baathificazione del governatore americano Paul Bremer III», l’uomo che era a capo della Coalition Provisional Authority, il governo di transizione post-Saddam.
Oggi le coordinate di riferimento dello Stato islamico rimangono le stesse. Baathismo e islamismo radicale. Quest’ultimo nella sua eccezione più deleteria, il “takfirismo”, che fa della scomunica degli altri musulmani, considerati eretici, apostati o complici dei miscredenti occidentali, il motore principale del jihad.
«É la pesante eredità di al-Zarwaqi», continua Hassan. «Il fondatore di al Qaeda in Iraq ha sempre pensato che combattere gli altri gruppi militanti sunniti che si opponevano al suo progetto, e ovviamente gli sciiti, fosse prioritario rispetto alla battaglia contro gli americani. La sua era una guerra interna al mondo musulmano».
Mentre Bin Laden voleva rendere popolare il jihad, persuadere gli altri musulmani a unirsi alla lotta, al-Zarqawi allora e oggi al-Baghdadi ritengono «che il jihad non si faccia con le parole, con la persuasione, ma con la violenza». E che tale violenza vada indirizzata, prima ancora che contro il “nemico lontano”, gli Stati Uniti, contro il “nemico vicino”, gli sciiti e tutti quei musulmani sunniti “compromessi” con i regimi oppressivi del Medio Oriente e non solo. Nemici da combattere con violenza brutale. Da praticare e rivendicare. «Anche le azioni più efferate vengono giustificate con qualche passo tratto dalla letteratura islamica, così ampia da garantire infinite citazioni, oppure con le azioni di autorevoli figure storiche, come Khalid bin al-Walid, il comandante di uno dei primi eserciti musulmani, che si dice bruciasse vivi i prigionieri di guerra».
Tra i comandanti provinciali dello Stato islamico, racconta Hassan Hassan, circola da tempo un libretto redatto nel 2004 da un certo Abu Bakr Naji, La gestione della barbarie (Idarat al-Tawahhush), che è «insieme un manuale di guerriglia e un manifesto per la nascita del Califfato». Una parte del libro «spiega come riempire il vuoto successivo al rovesciamento di uno Stato, alla ritirata degli eserciti occidentali e dei loro alleati ‘apostati’, i governi arabi. Un’altra spiega il significato di jihad, distinguendolo da quello di Islam e chiarendo che non esiste jihad senza violenza, senza terrorismo, senza massacri».
Oltre che come tattica di conquista ed espansione, la violenza brutale ha infatti una valenza strategica. Deve condurre al tashreed, alla “deterrenza”: «La ferocia funziona da deterrente per le popolazioni conquistate. Devono temere di ribellarsi. Va esercitata in modo costante e progressivo: dalle decapitazioni ai roghi, in un crescendo continuo». Eppure, l’Isis – che rispetto ad altri gruppi jihadisti enfatizza la statualità territoriale - prova anche a ridurre i motivi di scontento nei territori che occupa. «La forza bruta si combina a un’efficace governance territoriale. Ecco il trucco. L’Isis fornisce in modo efficiente i servizi di qualunque governo, e allo stesso tempo lascia che le forze locali mantengano un certo ruolo. In Iraq ha conquistato il sostegno delle comunità tribali anche con un sapiente lavoro di divide et impera e di risoluzione delle dispute locali».
Dove la governance non funziona, si ricorre alle azioni dell’esercito dei combattenti. Sempre più numeroso e agguerrito. «C’è chi si arruola per ragioni ideologiche (i combattenti più fedeli e brutali), chi per puro pragmatismo, chi per rivalità con altri gruppi, chi per spirito di rivincita. Le motivazioni sono molteplici». Quella principale sembra essere il revanscismo sunnita. «Tanti sunniti si sentono marginalizzati, sia in Siria sia in Iraq, credono che il Medio Oriente sia stato consegnato nelle mani degli sciiti iraniani. Molte adesioni allo Stato islamico nascono da un senso di alienazione». Anche per questo, sostiene Hassan, seppur tacita, un’alleanza tra Stati Uniti, Siria e Iran contro lo Stato islamico sarebbe controproducente. «Significherebbe alimentare il malcontento tra i sunniti, impedire qualunque eventuale ribellione interna. Quanto più l’Iran acquisisce un ruolo centrale nell’area, tanto più il progetto dell’Isis diventa credibile».
L’urgenza di frenare l’ascesa del Califfo non deve far dimenticare le responsabilità passate e presenti. «Da qualche tempo Bashar al-Assad si presenta come l’ultimo baluardo contro l’Isis. Non dovremmo dimenticare che rimane uno dei principali responsabili della sua affermazione. Subito dopo l’invasione americana dell’Iraq il regime siriano ha facilitato il flusso di jihadisti dalla Siria all’Iraq. Più recentemente, ha permesso che l’Isis agisse indisturbato, anche nelle città siriane di Aleppo e Raqqa, e ha condotto perfino affari sottobanco per il petrolio».
Sdoganare il presidente siriano in funzione anti-Isis sarebbe un tragico, ulteriore errore degli americani. «Si sommerebbe all’invasione dell’Iraq nel 2003, prima causa diretta della nascita dello Stato islamico, e allo sbrigativo ritiro politico dal paese, che ha aperto le porte da una parte alla politica settaria dell’ex premier iracheno Nouri al-Maliki contro i sunniti, dall’altra alla progressiva ascesa di al-Qaeda in Iraq». Senza la volontà politica di affrontare il vero nodo regionale – il conflitto siriano e il futuro ruolo di Bashar al-Assad – anche i cacciabombardieri statunitensi rischiano di risultare inutili. «Nessun dato concreto ci consente di essere ottimisti», conclude l’autore di Isis. Inside the Army of Terror. «Lo Stato islamico rimarrà una minaccia molto a lungo. E proverà a mantenere le promesse: anche colpire Roma, simbolo della cristianità».



