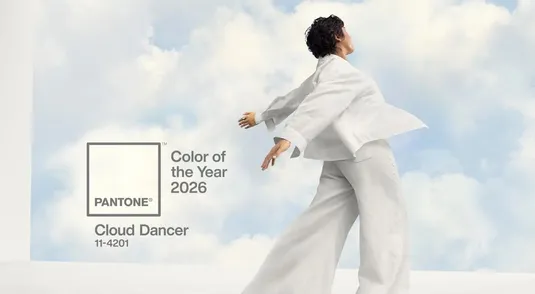Mondo
12 novembre, 2025Memoria della stagione della raccolta in Cisgiordania, alle radici di un rito collettivo parte dell’identità di un popolo. Bersaglio dei raid dei coloni e dell’esercito
Shahr al meshmesh”, il mese delle albicocche. Mia madre mi racconta che veniva chiamata così la stagione della raccolta delle olive in Palestina. Erano così dolci quei momenti, così felici, che a tutti gli abitanti del villaggio pareva di essere circondati dallo zucchero delle albicocche e dal colore aranciato del tramonto, che calava sugli uliveti sorprendendo i contadini ancora impegnati nella raccolta. Pare che mentre raccoglievano le olive, le olive facessero lo stesso con loro. Raccoglievano, univano la famiglia, davano vita al villaggio. Tutto cambiava durante quel mese, i vicoli del villaggio erano una festa, persino le domande che si scambiavano gli abitanti, mutavano. Non ci si chiedeva più “Come stai?”. All’alba o in tarda serata le domande erano: “Quanto olio hai fatto, Abu Mahmud?”, “Quanti kili hai raccolto?” E non si intendeva i kili esatti, ma il peso in barakah. E la barakah fa in modo che una cifra sia sempre in eccesso, perché barakah è la benedizione divina che sta nelle cose, la serenità che anche un piccolo raccolto riesce a donare. Ma soprattutto, l’ulivo stesso è una shajara mubaraka un albero benedetto, come citato nel Corano.
«Non sentivamo la stanchezza – mi racconta mia madre – eppure, se ci penso, era parecchio faticoso. Ce ne stavamo dalla mattina alla sera per un intero mese, a volte anche per due, a raccogliere olive. Chicco dopo chicco. Le braccia tese tutto il giorno, gli occhi rivolti verso l’alto, attenti». Rapita, le chiedo se usasse la scala. Sorride. «Quale scala e scala, mi arrampicavo!». E dentro i suoi occhi scorgo una contentezza fanciullesca. La vedo piccola arrampicarsi sugli alberi, ancorare i piedi sui rami dell’ulivo mentre quello, estendendo le sue radici, si ancorava negli abissi della terra palestinese. «Mentre raccoglievamo, mio padre intonava una canzone e noi lo seguivamo ripetendo le strofe». Erano poesie, canzoni dedicate all’ulivo, la più celebre: Dal’ouna al zaytoun: «Canta, oh usignolo, sull’ulivo della nostra terra», comincia così, e continua rendendo omaggio a un albero che per i palestinesi è un compagno, un alleato, è ricchezza, identità, vita.
«Era così bello quel mese che speravamo non finisse mai. A volte rallentavo, per allungare la bellezza di quei momenti. Quante volte ci è capitato che il cielo ci piovesse addosso! – ride divertita – e se ci capitava di finire la raccolta prima dei parenti o dei vicini di casa, correvamo ad aiutarli, ci univamo a loro». La sento parlare di un senso di comunità e vicinanza che non ho mai assaporato. «Lasciavamo di proposito delle olive sui rami, a volte anche le più belle. Sapevamo che poi sarebbero passate le famiglie più bisognose, che non possedevano campi». Tutti volevano accaparrarsi le olive. Nei suoi ricordi è impressa l’immagine dei rifugiati del ’48: «Sui loro asini trasportavano chili e chili di uva. A loro era stato rubato tutto. Andavano a comperare l’uva al mercato e poi la barattavano con noi. A fronte di un chilo di uva, davamo in cambio un chilo di olive». Non la interrompo mentre parla. Il suo flusso di ricordi mi dona il privilegio di poter vedere mia madre bambina, in un tempo in cui la vita era così semplice, genuina. La vedo correre felice verso il carretto del rifugiato. «Ricordo ancora il gusto di quell’uva. Così croccante, dolce». Si emoziona descrivendo quel gusto ormai così lontano. Le sue lacrime annaffiano il suo amore, la sua nostalgia per la Patria. «In quei giorni si pranzava, si cenava lì: olio appena spremuto, ovviamente, poi zaatar, pomodori, pane caldo che facevamo proprio nel campo, cotto direttamente alla brace. Alcune famiglie piantavano addirittura tende e per intere settimane si radicavano lì».
Più va avanti nel racconto e più mi appare chiaro perché noi palestinesi siamo così legati a questo albero. A ottobre, in Palestina, avviene una magia: quello che di solito è un sostantivo al quale è difficile associare qualcosa di materiale, prende forma: la felicità si materializza in un frutto piccolo, verdognolo o nero, appeso sui rami. Non si raccolgono olive, ma chicchi di felicità.
Da tempo, però, è cambiato tutto. Ottobre arriva in Palestina e non si accende più alcuna festa. Gli agricoltori entrano nei loro campi sgattaiolando come fossero dei ladri, attenti a non fare troppo rumore. Non si canta, non si balla più sotto l’albero. Si raccoglie la felicità in silenzio, il più in fretta possibile. Perché potrebbero arrivare i coloni israeliani che attaccano, picchiano violentemente, uccidono. Aggrediscono per privare il palestinese della stagione culturalmente, socialmente, economicamente più importante di tutte, per indurli ad andarsene, così da avere spazio per costruire altre colonie. Attaccano non solo gli agricoltori e le loro famiglie, ma anche gli ulivi stessi. Secondo i dati in possesso della Wafa, dal 7 ottobre 2023, con lo sguardo del mondo incentrato su Gaza, i coloni hanno effettuato 7.154 attacchi in Cisgiordania, danneggiando 37.237 ulivi, mentre 33 palestinesi sono stati uccisi in incidenti correlati, secondo la Commissione per la Resistenza al Muro e agli insediamenti. Il capo della Commissione, Muayyad Shaaban, ha rivelato che dall’inizio di questa stagione, cominciata il 9 ottobre 2025, le forze di occupazione e i coloni hanno effettuato 158 attacchi contro i raccoglitori di olive nei governatorati della Cisgiordania. Di questi 158 attacchi, Shaaban ha specificato che 17 sono stati perpetrati dall’esercito israeliano, mentre i coloni sono stati responsabili di 141. Le aggressioni comportano violenza fisica, arresti e impedimento agli agricoltori di accedere o muoversi liberamente sui loro terreni, come nel governorato di Tubas.
Un episodio in particolare sta divenendo simbolo di queste violenze. È il 19 ottobre 2025, una domenica mattina, sul presto. L’aria è frizzante e sulle olive posano gocce di rugiada. Afaf Abu Alia, 53 anni, le sta raccogliendo con suo fratello e i suoi figli in un oliveto vicino a Turmus Ayya, una città palestinese a Nord di Ramallah. Una folla di cento coloni scende dal vicino avamposto di Or Nachman. Afaf comincia a scappare, stringendo tra le mani l’unico cesto che è riuscita a riempire. Armati di mazze e pietre, i coloni iniziano ad attaccare raccoglitori e attivisti. Per impedire la fuga dei palestinesi, i soldati israeliani lanciano su di loro lacrimogeni. Soffocata dal gas, Afaf si siede sotto un albero. All’improvviso un colono mascherato la raggiunge e la colpisce alla testa e al braccio con un manganello. La donna, conosciuta ai più come Umm Salah viene trasportata all’ospedale Istishari di Ramallah, dove trascorre una notte in terapia intensiva con un’emorragia cerebrale. «Ho pensato che fosse finita, che sarei morta», racconta a Middle East Eye dal suo letto d’ospedale, dove versa ancora in gravi condizioni. L’episodio ha sollevato indignazione internazionale poiché è stato ripreso dal giornalista statunitense Jasper Nathaniel, che ha poi diffuso le immagini sui social. «È la cosa più scioccante che io abbia mai visto», ha raccontato il reporter. «L’ha colpita una volta, ed è crollata subito. Poi le ha inferto altri due colpi».
Tubas, Turmus Ayya, Sa’ir, Burin, tantissimi, più di 27, i villaggi palestinesi teatri di questi attacchi. In alcuni, i coloni israeliani hanno intensificato la distruzione degli uliveti ancor prima dell’inizio del raccolto di quest’anno. Ayman Ghoneimat, la mattina del 3 ottobre si trovava nella sua casa di Surif, a Nord di Al Khalil-Hebron quando ha visto un gruppo di coloni mascherati scendere da un avamposto vicino. Li ha visti tagliare e spezzare i rami di antichi ulivi e dare fuoco agli alberi, è stato testimone della distruzione di una Storia senza tempo, un testimone che non parlerà di fronte a nessuna aula di tribunale, perchè nessuno intenta un processo contro chi uccide alberi.
«E i vostri ulivi?», chiedo a mia madre. «Sono ancora lì?». «Oh, no», mi risponde. «Più di tre quarti del nostro campo è stato rubato dagli israeliani, per costruire le loro strade».
Non chiedo altro. Nel sibilo della sua voce, il dolore è un grido. Torno a farle domande su quel passato dolce come le albicocche. Le torna il sorriso, mentre dentro di me cresce immensa una voragine nera di malinconia. Dentro, tutti gli ulivi della Palestina. Dieci milioni, per l’esattezza, che ricoprono circa il 45 per cento dei terreni agricoli della Cisgiordania. Li sento in pericolo. Sento in pericolo la mia identità. Alla Palestina intera: un giorno sarai libera. Un giorno, fiorirai.
LEGGI ANCHE
L'E COMMUNITY
Entra nella nostra community Whatsapp
L'edicola
Casa, diritto negato - Cosa c'è nel nuovo numero de L'Espresso
Il settimanale, da venerdì 5 dicembre, è disponibile in edicola e in app