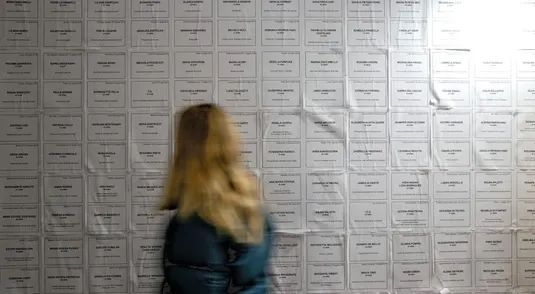«È chi minaccia, non chi viene minacciato, che deve vedere ridotta la sua libertà di movimento». Quando da questa pagina qualche settimana fa avevo lanciato la provocazione di assegnare la scorta alle donne che denunciano per minacce gli ex partner, proprio come avviene per gli imprenditori o i giornalisti minacciati dalla criminalità, le obiezioni che ho ricevuto da parte delle altre femministe vertevano sulla focalizzazione del soggetto dell’eventuale provvedimento. La logica di queste obiezioni è ferrea: vedersi assegnare la scorta non è solo una protezione, ma anche la certificazione di uno stato di pericolo che cambia completamente la qualità della vita di chi la subisce.
Dichiarare alle istituzioni che si è un bersaglio e farsi trattare come tale è indubbiamente utile sul piano della salvezza fisica, come ben sa chi con la scorta ci convive da anni, ma ha anche il non piccolo effetto collaterale di cristallizzare la condizione di potenziale vittima, imponendo l’allerta costante e consentendo l’attivazione di un dispositivo di controllo dei movimenti che agisce sulla vita della persona minacciata, ricordandole in ogni momento, proprio mentre cercava di liberarsi da uno stato di oppressione, che non è più pienamente padrona di sé.
A dispetto dei pochi mitomani che ambiscono alla scorta come status symbol, nessunə sanə di mente può desiderare una cosa simile nella sua esistenza, a meno che l’alternativa non sia la morte. Proporre che la possibilità di una protezione di Stato venga estesa alle donne minacciate non era dunque l’augurio di una prassi di controllo, ma l’invito - rivolto alla ministra della giustizia Marta Cartabia e che qui rinnovo - a prendere sul serio sul piano istituzionale il fenomeno della violenza patriarcale, di cui i femminicidi sono la punta dell’iceberg.
La cultura del possesso che conduce gli uomini a uccidere le donne di cui perdono il controllo va trattata come una criminalità, forse disorganizzata, ma non per questo non sistemica. Lo stato dell’arte è purtroppo opposto: i meccanismi di legge, pur apparentemente presenti, non innescano una reale protezione della vita delle donne che vi ricorrono e in queste condizioni invitare a denunciare a qualunque costo può implicare solo l’aumento del rischio di farsi ammazzare prima. A fronte di svariate decine di omicidi di genere perpetrati con le stesse coordinate di metodo tutti gli anni, indignarsi ogni volta come se l’ultimo fosse il primo appare sempre più ipocrita.
Come ha dimostrato chiaramente il caso Palombelli nei giorni scorsi, il vero punto da affrontare istituzionalmente è che la violenza all’interno delle relazioni tra i generi è ancora percepita e trattata come parte del conflitto di coppia, persino da chi pretende di occuparsene dalla parte delle donne. Non un vero e proprio reato, dunque, ma un attrito affettivo in cui le persone coinvolte partecipano in regime di concorso di colpa. Secondo questa lettura entrambi i partner sono vittime, una di violenza e l’altro di esasperazione, ed è la ragione per cui una donna che oggi si reca ripetutamente dalle forze dell’ordine a denunciare una minaccia rischia a ogni giro di dover ripetere che il suo ex compagno «non ha perso il controllo di sé, ha perso il controllo di me».
Difficile risponderle che lo Stato prende sul serio le violenze di genere, se è vero quello che Antonio Padellaro ha scritto sul Fatto Quotidiano in merito alla riforma della giustizia che porterà il nome della ministra Cartabia. Secondo la sua ricostruzione, nella riforma atti come il revenge porn e la violenza sessuale di gruppo rientreranno nella categoria del reato tenue (con pena minima fino a due anni) e potranno essere risolti con l’istituto del concordato, che permette un accordo tra imputato e pubblica accusa sulla pena da comminare. Si potrebbe obiettare che per l’omicidio la tenuità del reato non esiste, ma significherebbe non aver capito che la questione di genere è culturale, prima che giuridica: la mentalità che considera “concordabile” l’abuso fisico e morale di una donna è la stessa che considera interpretabili le circostanze di un femminicidio, sottovalutando sistematicamente i segnali che lo annunciano.