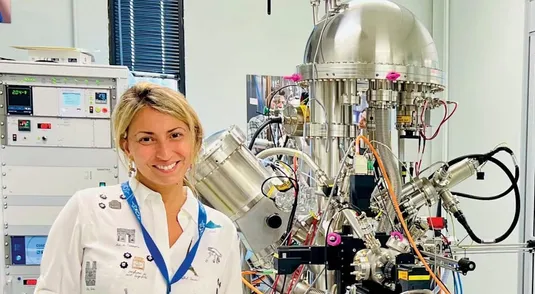Il cinema è morto: lo ha detto Jean Luc Godard. E lo deve aver pensato sul serio, perché lo ha detto a Daniel Cohn Bendit in una ponderosa intervista rilasciata a Cannes. Dunque: "Il cinema, quella piccola società che si è formata cento anni fa nella quale erano rappresentati tutti i rapporti umani, di soldi, di donne è scomparso". "Socialisme"- il film che Godard ha portato a Cannes - ne è il testamento eccellente. Non a caso lui, da genio qual è, la morte del cinema l'ha cantata in 4 minuti e 29 secondi, ovvero il tempo di un trailer che frulla, centrifuga, sintetizza tutte le immagini e l'audio del film e che è stato lanciato in rete per volere dell'Autore in differenti versioni copia-incolla. Da Godard, insomma, costretto a fare i conti con la rappresentazione digitale, si evince che il cinema è morto perché ha perso il suo corpo (la pellicola) e la sua anima (la sala, il rito, il tempo canonico delle due ore di narrazione).
Resta aperta la domanda: chi è l'assassino? Chi ha ucciso o sta uccidendo il cinema? Primo sospettato il 3D, testa d'ariete di una rivoluzione tecnologica che digitalizza tutte le sale e rivoluziona la stessa idea di cinema. Sarà bene o sarà male la perdita delle pizze e del lento scorrere del nastro dentellato? Sarà giusto o sbagliato andare in sala a vedere una partita di calcio con appositi occhialetti o una maratona, lunga un'intera notte, della propria serie tv preferita? Cosa accadrà: crescerà il numero dei fedeli o sono solo i mercanti che entrano nel tempio?
Da "Avatar" in poi sugli effetti collaterali del cinema in 3D la discussione è accesa e violenta. "Newsweek", schierandosi apertamente, ha dedicato una copertina al pericolo "Avatar" col nasuto extraterrestre in inquietante tenuta da guerra: "This is bad for the movies", ha scritto aggiungendo: "Hollywood si sta suicidando, il 3D è adatto solo a raccontare favole a un pubblico infantile o infatilizzato, mentre i grandi cineasti come Scorsese o Herzog fanno film per gente adulta".
Ma di fronte agli incassi Hollywood è ben contenta di rischiare la regressione all'infanzia e, con buona pace degli Autori, sforna come il pane titoli e sequel ad altissimo budget da "Tron Legacy" a "Toy Story" a "Step Up" in nuova versione 3D. Le sale si adeguano, l'epidemia si allarga. Un paio di anni fa in Italia c'erano solo una cinquantina di schermi attrezzati, oggi sono più di 500, mentre in tutta Europa dagli 897 del 2008 siamo passati ai 4693 del 2010. La peste del digitale uccide quel che resta del cinema, il quale seguendo le orme del Decamerone si arrocca in villa a raccontarsi le sue vecchie storie.
Cannes 2010. In un festival che - tra concorso e fuori concorso - brilla per la nutrita e prestigiosa presenza di Maestri in terza età (Abbas Kiarostami, Nikita Mikhalkov, Bertrand Tavernier, Mike Leigh, Woody Allen fino al grande e centenario De Oliveira), scoppia il caso "Carlos".
Una biopic lunga cinque ore e trenta minuti, sulla vita del terrorista di estrema sinistra Ilich Ramirez Sanchez, detto Carlos e in arte "Lo Sciacallo", tra il 1973 e il 1994. Lo ha girato Olivier Assayas, 55 anni, figlio d'arte. Il padre sceneggiatore e assistente di grandi cineasti come Pabst o Ophuls, gli ha trasmesso l'amore per il cinema, quello vero, con la pellicola e l'autore.
Tanto che lui negli anni Ottanta è critico, scrive per i "Cahiers" ( bibbia dei cinefili) e si specializza in cinema asiatico. Poi passa con successo dietro la macchina da presa con un pedigree che sembra portarlo dritto nel Pantheon di quel che resta del cinema. Invece sarà proprio lui a tirare la pietra in mezzo allo stagno: perché mentre il terrorista Carlos, attualmente detenuto in Francia e condannato all'ergastolo, non fa paura a nessuno, il film di Assayas scuote le fondamenta della Croisette e come oggetto ibrido (mezzo cinema e mezzo tv) dimostra che una rivoluzione genetica è in corso e non c'è più confine fra fiction e film.
Anzi in questo caso la prima ha già vinto sull'intero concorso.
Questo è quanto si legge su un giornale come "Le Monde" che non è propriamente una fanzine, ma qui si fa portavoce delle proteste di chi avrebbe voluto "Carlos" in concorso. Proposto, ma rifiutato in quanto serie tv e non prodotto cinematografico. Ma dove è la differenza? Di certo non nella qualità del prodotto (serie come "Wire" sono universalmente considerate dei classici alla stregua di un film di Cassavetes) né nel profilo di registi o produttori. Ridley Scott che ha aperto Cannes con la sua versione di "Robin Hood", sta contemporaneamente producendo una saga tv su famiglie inglesi del XVII secolo. Spielberg, dopo "The Pacific" segue quattro progetti di serie per la stagione 2010- 2011. Kathryn Bigelow dopo l'Oscar sta preparando un pilot per un serie tv centrata su un compositore di Broadway mentre Jonathan Demme si lancia su un boxeur fallito diventato detective. Intanto per la HBO Michael Mann sta lavorando a "Luck": filo rosso Dustin Hoffman anziano detenuto che si ricicla come truffatore con piano ambizioso per truccare le corse dei cavalli. Per non parlare di Martin Scorsese che forse, come afferma " Newsweek" non farà mai un film in 3D, però è pronto a firmare il pilot della nuova serie "Boardwalk Empire" ideata da Terence Winter (creatore dei Sopranos) con Mark Whalberg e debutto annunciato a settembre 2010.
La velocità e la libertà con cui si lavora sul set di un film tv è una tentazione fortissima per i registi, soprattutto di azione. Budget alti ma set agili; la possibilità di girare fino a otto minuti al giorno, quando al cinema già due sono tanti; la libertà di trattamento di soggetti e sceneggiature adrenalinici; uno zoccolo duro di fan fanatici, che dimostrano come la "serifilia" stia soppiantando l'antica cinefilia, facendo nascere una nuova comunità che grazie al web si scambia materiali, informazioni e pensieri tra fanzine, blog e siti dedicati.
"Cannes ha fatto un errore nel non mettere "Carlos" in concorso. Queste barriere non hanno più alcun senso. Anzi non lo hanno mai avuto. Anche "Heimat" di Reitz o "Kingdom" di Von Trier o "Twin Peaks" di Lynch erano pensati come film per la tv ": Alberto Barbera parla sia in qualità di giurato dell'ultimo festival che come direttore di un Museo del Cinema di Torino che non vorrebbe diventare un museo etrusco. Lui, convinto, non si preoccupa: "Non c'è pericolo, non stiamo assistendo a nessuna morte del cinema ma a una sua trasformazione, come fu quella dal muto al sonoro o dal bianco e nero al colore. La verità è che tutti i film, nella loro qualità, sono molto più avanti di noi". Forse. Però la trasformazione in atto è radicale e profonda. Non è solo lo schermo a modificarsi, ma l'intera ritualità di fruizione di quel che nel Novecento abbiamo chiamato Cinema. Tutto cambia: la centralità della sala, le modalità di produzione, la durata del prodotto, la fine della tiratura limitata delle copie e, soprattutto, la percezione dello spettatore.
Perché il 3D non è solo una rivoluzione dello schermo, ma "rappresenta l'esigenza di consumare immaginario in prima persona non più come spettatori ma come attori, o meglio giocatori. L'esperienza del 3D arriva dai videogame e dal bisogno di interattività e dell'illusione di vivere una totale immersione nello spazio della storia. È lo sfondamento del campo visivo, la locomotiva dei Lumière che ti entra in corpo", sostiene Carlo Freccero che sta studiando la materia e tutte le sue possibili applicazioni in tv con meticolosa attenzione. Lui che ha molto amato "Avatar" ("incantevole visivamente, un'esperienza psichedelica, rivoluzionario nello spostare il racconto dalla terza alla prima persona") ne riconosce anche i limiti narrativi. "Per la struttura stessa della nostra percezione visiva, il 3D ha bisogno di una visione frontale e prospettica, dunque di una struttura narrativa semplificata adatta alla favola, ma per niente adatta al ritmo adrenalinico delle serie tv. Che comunque sono ormai molto più belle del loro equivalente cinematografico. Ma quello che credo sarà la vera rivoluzione prossima ventura è l'ologramma, ultima dimensione dell'immaginario in grado di far rivivere i morti e coniugare la potenza visiva e quella narrativa". E sarà forse quello il colpo di grazie di un'arte lunga un secolo, che abbiamo chiamato cinema e a cui presto forse dovremo trovare un altro nome.
Cultura
29 luglio, 2010La seconda vita del cinema
L'invasione del 3D. Le sale multimediali. E soprattutto il boom dei serial televisivi. Quello che è stato il rito in pellicola del Novecento ormai non esiste più. Ma i prodotti di qualità ci sono ancora. Soprattutto se pensati per il piccolo schermo