Phillips e Milner, al cuore del vostro libro c’è il concetto di “ambivalenza”. Ovvero che «le stesse tecnologie che facilitano cooperazione, connessione e senso di comunità possono agevolare discordia, ansia e alienazione» tra chi sta ai margini di un gruppo sociale. Mi chiedo se ciò implichi l’impossibilità di ridurre i rischi della vita in rete senza ridurne allo stesso tempo i benefici o se, invece, sia possibile affrontare separatamente il bene e il male su Internet.
«Il concetto di ambivalenza on line è una matassa che non si può sbrogliare; gli stessi strumenti che possono essere sfruttati per fini di progresso positivo possono anche, almeno in potenza, venire impiegati per scopi distruttivi. Ciò detto, esistono modi per affrontare specifiche piattaforme e comunità in rete separandone i comportamenti positivi e distruttivi. Il trucco sta nel considerare l’unicità di ciascuno strumento e nel comprendere l’impatto di ogni comportamento. Non nell’emettere generiche sentenze sull’intera rete Internet o sui social media nel complesso».
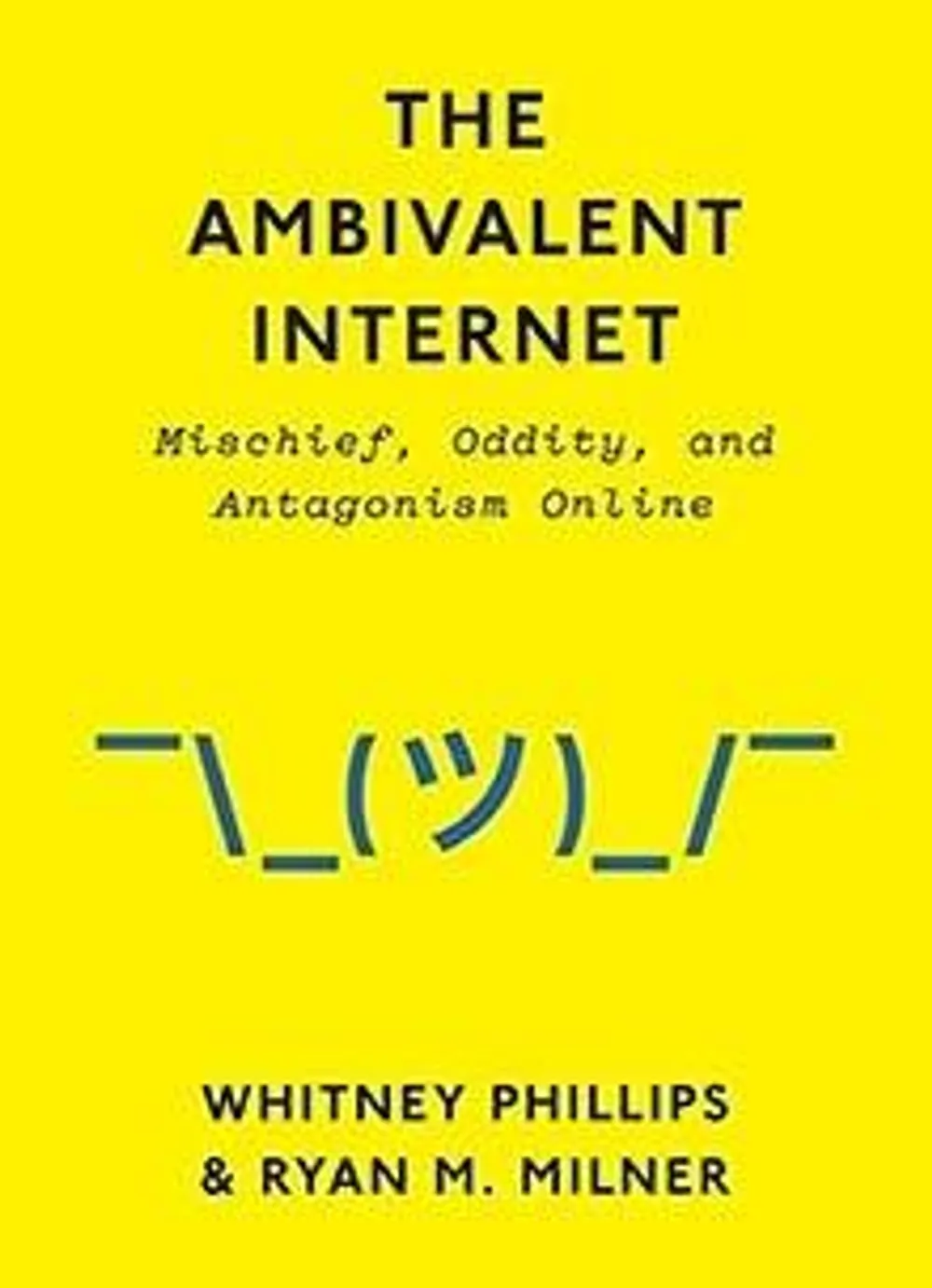
Su una cosa però i leader in tutto il mondo sembrano essere d’accordo: i colossi web devono fare di più contro l’odio on line e la propaganda terroristica, rimuovendone i contenuti più rapidamente. Ha senso chiedere ai gestori dei social media di diventare sceriffi dei contenuti?
«Tentare di affrontare il problema dell’odio on line è ragionevole e necessario. Tuttavia il vero problema è molto più profondo di Internet, e sta nel comprendere perché si prendano posizioni d’odio. È sbagliato pensare che risolvendo in qualche modo la questione della moderazione dei commenti on line si risolva anche quel problema, che in realtà è più ampio. Il che non significa che dovremmo smettere di cercare di rendere Internet un luogo più sicuro, ma che dovremmo renderci conto di quanto sia complesso ciò che stiamo cercando di combattere: gli attriti off line, le intolleranze off line, le ingiustizie off line. Che di certo si riflettono nei comportamenti in rete, ma che non sono di per sé stessi la causa primaria di alcunché».
Ma odio, propaganda, trolling, cyberbullismo e altri esempi negativi di ambivalenza on line sembrano essere un’emergenza, o quantomeno un fenomeno in crescita.
«Sono un problema in rete, ma non l’unico. Altri comportamenti insidiosi sono altrettanto problematici. Per esempio, la tendenza ad appiattire l’intero spettro delle ripercussioni politiche ed emotive di una particolare questione a singoli contenuti decontestualizzati: una sola immagine, o tweet o meme. Non considerare la complessità del contesto di una notizia o di una vita può rendere molto difficile rispondere in modo etico al dolore altrui. Magari questo tipo di reazioni non raggiunge il livello di una molestia razzista premeditata, ma tutte insieme creano un ambiente privo di compassione, in cui la responsabilità collettiva di trattare gli altri con cura e rispetto sfuma ed è più facile abbandonarsi a forme più ovvie di antagonismo».
Il problema, scrivete nel libro, è che non abbiamo una teoria complessiva che ci insegni come rispondere alle molteplici forme di ambivalenza on line. Ed è ancora più problematico se, come aggiungete, i danni prodotti in rete hanno caratteri di immediatezza, persistenza e reperibilità «distinti da qualunque esperienza» negli spazi fisici. La vostra soluzione è «lavorare con, non contro, l’ambivalenza». Che significa?
«Prima di tutto, significa non imporre soluzioni universali a comportamenti e strumenti ambivalenti. Per esempio, chiediamo di giudicare le forme di espressione on line caso per caso, facendo attenzione ai loro effetti tangibili, piuttosto che dichiarare che lo strumento, la piattaforma o il comportamento X, nel complesso, è buono o cattivo. Semplicemente, farlo non aiuta. E ricordiamoci che il bene di uno può essere il male dell’altro. In sostanza, quindi, adottare la prospettiva dell’ambivalenza significa dare per scontato che ogni cosa è complessa, e concentrarsi su ciò che può essere detto, e fatto, all’interno di un particolare contesto».
Parlando di identità in rete, e del gioco di maschere e ruoli che vi si accompagna, scrivete che «vero e falso sono concetti relativi, sia off line che on line». Viviamo nell’era della “post-identità”, più che in quella della “post-verità”?
«Semmai oggi l’identità è sempre più importante, in particolare con l’ascesa di odio e molestie on line che proprio su di essa si basano. Se il mondo fosse davvero “post-identitario”, non ci sarebbero persone bersagliate per il colore della pelle, il sesso o l’affiliazione religiosa da soggetti che si sentono superiori per alcuni aspetti della loro identità. Si pensi poi all’importanza della politica identitaria nel 2017, incluso il suo ruolo nell’elezione di Donald Trump. Ma anche senza considerare queste forme di antagonismo, si può dire che ogni singola cosa una persona faccia in rete, inclusa la scelta di ingannare il prossimo, deriva da ciò in cui crede negli spazi fisici».
«L’ambivalenza ci dice più del centro che della periferia», scrivete. È una professione di metodo: studiare il normale tramite l’anormale, lo strano, l’eccessivo. Come lo sono a volte i memi, e qualunque prodotto di ciò che definite lo “storytelling collettivo” della rete. A vostro dire è un modo di mettere in mostra i valori culturali correnti. Se le cose stanno così, un meme diventa un’epifania, ci svela a noi stessi. Non andrebbero dunque celebrati, invece che deprecati?
«Noi non chiediamo di combattere e contenere l’ambivalenza, ma di riconoscere che tutte le forme dell’espressione folkloristica, on line e off line, riflettono logiche e norme culturali più ampie. Può darsi siano da celebrare, ma anche no; a volte vale la pena combatterle, come quando normalizzano razzismo e misoginia. In fondo ciò che sosteniamo è che sia possibile imparare molto anche da comportamenti che sembrano irrilevanti o palesemente strani. Magari apprenderemo cose sconvolgenti, ma non sono che il segnale che c’è ancora molto altro da imparare. Di nuovo, nel bene e nel male».
Esperti e politici se la prendono con l’anonimato in rete. Nel volume ricordate invece che gli effetti disinibitori dell’anonimato possono anche facilitare compassione e apertura emozionale, almeno quanto l’aggressione, e perfino spingere a comportamenti di esplicito aiuto.
«Le loro accuse spesso ne universalizzano un solo aspetto, senza considerarne altri. Uno è il fatto che individui che vivono in condizioni di oppressione possono sfruttarlo per rivelare segreti scomodi al potere; un altro è consentire loro di esprimersi liberamente senza il timore di subire aggressioni fisiche: basti pensare quanto è importante nella sfera della sessualità. La migliore risposta ai duri e puri dell’anti-anonimato è offrire loro questo tipo di controesempi. Ed enfatizzare il fatto che la risposta più efficace non è mai binaria; ci sono sempre aree grigie da tener presenti».
Una costante del vostro testo è la “legge di Poe”, la difficoltà cioè di distinguere espressioni genuine e satiriche, in mancanza di segnali paralinguistici e, spesso, dell’intero contesto di uno scambio comunicativo. Se il significato è molto più ambivalente in rete, come regolamentare le “fake news” senza moltiplicare il rischio di censurare contenuti legittimi?
«Quando consideriamo le “fake news” è cruciale concentrarci non solo sui sintomi, ma sulle più ampie questioni culturali che li causano. Le false narrazioni si diffondono, prima di tutto, perché ci sono persone che credono, o vogliono credere, a una certa narrazione. La causa, naturalmente, non risiede esclusivamente nella tecnologia, e dunque non può essere risolta dalla tecnologia; come molte altre delle questioni poste dall’on line, il problema si pone prima off line».
Ma nell’era iperconnessa di Trump, l’ambivalenza degli spazi digitali promuove oppure ostacola la democrazia, o nuove forme di democrazia?
«La risposta è sì: gli spazi digitali promuovono e allo stesso tempo ostacolano la democrazia, proprio come il più ampio concetto di “espressione”, formalizzato nel sistema legale del libero pensiero negli Stati Uniti, la promuove e ostacola. La libertà di espressione di alcuni si traduce nello zittire o nell’entrare in conflitto con altri, indipendentemente da dove si realizzi. La questione sottostante, dunque, non è che gli spazi e gli strumenti on line sono ambivalenti, incoraggiando sia elementi pro-Trump sia di resistenza a Trump, ma che il discorso politico è esso stesso ambivalente. E può sparire in qualunque momento, a seconda di quali idee politiche siano espresse, da chi e per quale ragione».
Oggi, tuttavia, c’è un assunto particolarmente pervasivo, a livello sociale: che dovremmo incolpare Internet per i problemi riguardanti il modo in cui ci esprimiamo. Va accettato o combattuto?
«Dovremmo combatterlo con forza. I problemi che riguardano come ci esprimiamo sono indubbiamente profondi e profondamente irritanti on line, in larga parte a causa dell’amplificazione data dalla rete e dalle domande di natura etica sollevate dalla legge di Poe: come rispondere al meglio, se non sai nemmeno cosa stai leggendo davvero? Detto ciò, diffidiamo degli argomenti che suggeriscono che le peggiori forme di abuso online, trolling e “fake news” inclusi, derivino direttamente dagli spazi e le libertà in rete, ovvero che sia “colpa di Internet”. Gli strumenti digitali di certo alzano la posta dell’etica e aumentano la visibilità di forme espressive problematiche, ma forniscono insieme anche dei modi per combatterle. Inoltre, è fondamentale ricordare che quelle questioni sono antecedenti alla rete. Concepire l’ambiente digitale come la causa ultima di tutto rischia di far dimenticare quanto vecchi siano questi problemi. Le soluzioni durevoli vengono unicamente dalla società, non dalla tecnologia».



