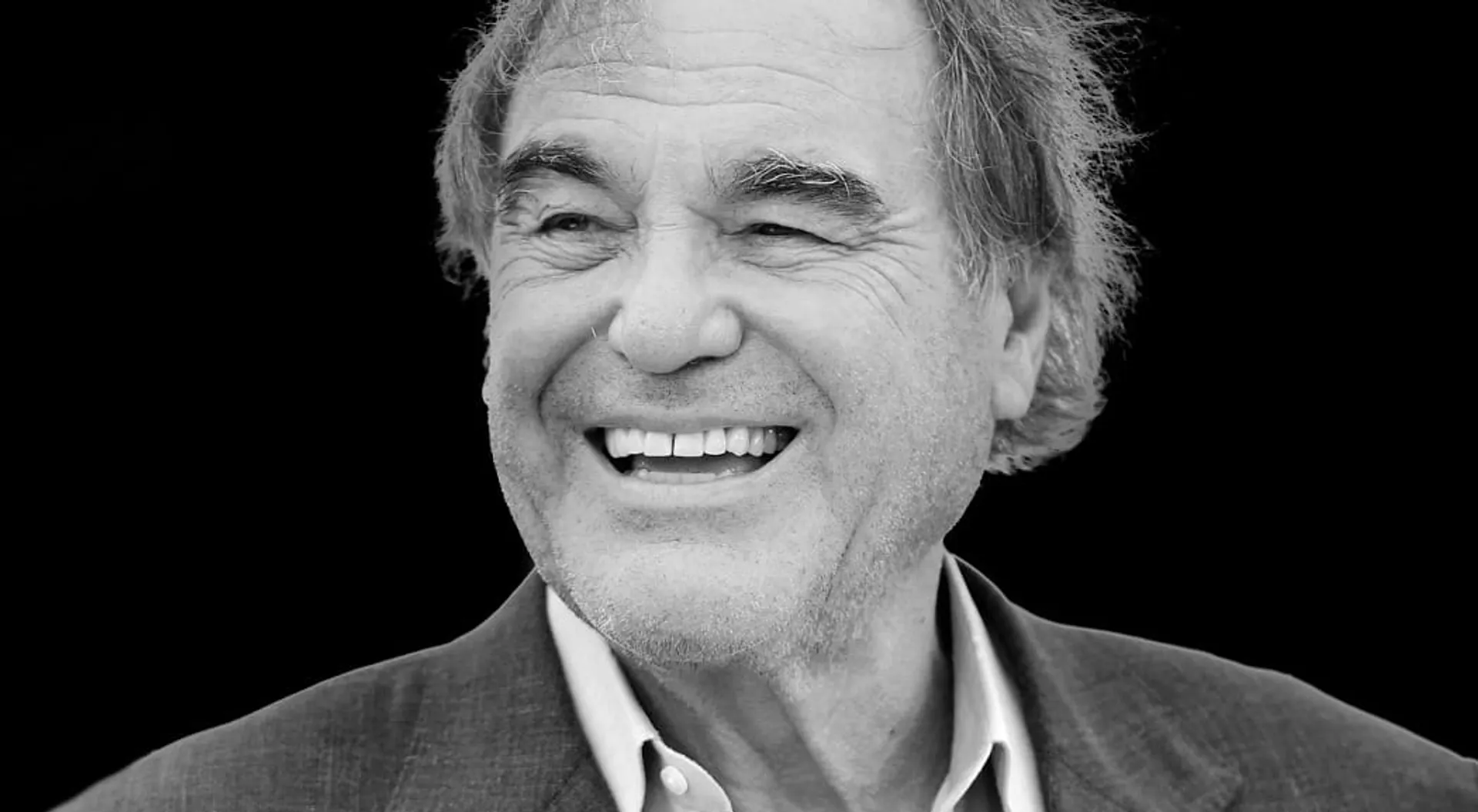Tutto ebbe inizio dal cortometraggio “Last Year in Viet Nam”. Era il 1971, un giovane americano di ritorno dalla guerra in Vietnam con una serie di medaglie sul petto debuttava alla regia con un piccolo documentario. Il suo nome era Oliver Stone. Si era appena laureato alla New York University Film School con un certo Martin Scorsese come professore. La sua carriera da allora è diventata leggenda e il suo cinema, anche quello di finzione per cui è diventato famoso nel mondo con titoli come "Platoon” e “Wall Street”, “Nato il quattro luglio” e “Snowden”, è sempre rimasto fortemente ancorato alla realtà, con un piglio spesso polemico nei confronti degli Stati Uniti. Impossibile dimenticare lo scalpore che fece negli anni Novanta il suo “JFK - Un caso ancora aperto”, per la tesi del complotto tratta dal romanzo “JFK. Sulle tracce degli assassini” del procuratore distrettuale Jim Garrison (nel film Kevin Costner). Un clamore tale da portare all’atto di legge President John F. Kennedy Assassination Records Collection Act of 1992 (il famoso “JFK Act”) e alla formazione della commissione d’inchiesta U.S. Assassination Records Review Board, incaricata di riesaminare l’inchiesta successiva all’omicidio di Kennedy. Stone non ha mai mollato la presa, non ha mai smesso di indagare, approfondire, studiare carte e ascoltare testimoni sull’omicidio di Kennedy, tanto da riproporre trent’anni dopo un altro film, “JFK Revisited: Through the Looking Glass”, e una miniserie in quattro episodi, “JFK - Destiny Betrayed”, in cui riesamina nuovi documenti finora secretati. Presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, andranno in onda rispettivamente su La 7 e su Sky Documentaries il 22 novembre, storica data dell’assassinio nel ‘63.
Perché l’omicidio di Kennedy ha ancora oggi un interesse così centrale nella sua vita e nella sua cinematografia?
«È stato un evento di portata storica a livello mondiale e ha prodotto un effetto a catena su quello che oggi definirei un impero in declino, quello americano. Kennedy era un guerriero della pace, cercava di cambiare il mondo, aveva iniziato una rivoluzione e poteva dar vita a una dinastia di presidenti che chissà come avrebbero cambiato, in meglio, il nostro Paese. Invece, dalla sua morte in poi l’America è come degenerata, tra scontri razziali, guerra civile, sfiducia sempre maggiore nei confronti dei leader politici e dell’informazione. Il mio interesse nasce proprio dalla frustrante delusione nel constatare che i media americani non si sono mai occupati dell’assassinio di Kennedy come avrebbero dovuto. Ovvero indagando, mettendo in discussione, facendo luce sulla verità. O sono stati pigri, oppure, come credo, complici».
Lei ha già firmato un film nel 1991. Come mai sentiva il bisogno di tornare sulla vicenda con un documentario e una docu-miniserie?
«In molti hanno giudicato di pura finzione il mio “JFK - Un caso ancora aperto”, anche se di fatto finzione non era. Mi attenni agli eventi realmente accaduti e ne feci una sorta di drammatizzazione. Allora gli elementi che riguardavano il suo omicidio erano talmente tanti e altrettanto disparati che cercai di condensarli dando loro una struttura narrativa drammatica per riuscire a catturare l’attenzione del pubblico. Questa volta il lavoro è stato totalmente diverso. Si tratta di un documentario puro (la miniserie è la versione originale estesa, il documentario la sintesi, n.d.r.) basato sulle indagini dello scrittore e attivista James DiEugenio che è riuscito a esaminare sessantamila documenti che sono stati desecretati, eppure nessuno ne ha parlato. Il tentativo è stato ancora una volta quello di seppellire il caso, insabbiarlo, non attirarvi attenzione, esattamente com’era successo ai tempi con il rapporto Warren».
Anche Tom Hanks sta producendo un film su Kennedy.
«L’ho saputo. Ogni volta che emergono nuovi fatti viene proposta una nuova forma di finzione che riguarda quegli eventi per cercare di distogliere l’attenzione. Era già accaduto qualcosa di simile nel 2014, con i programmi sulle emittenti pubbliche via cavo, come per spazzare via ogni possibilità di una teoria alternativa. Avviene sistematicamente dal ’64. Tom Hanks crede nel mito americano ed è tuttora convinto che l’America stia andando per il verso giusto, ha sposato la tesi anticomplottista dell’avvocato Vincent Bugliosi, tra l’altro confutato da DiEugenio punto per punto. Potete chiamare quelli come Tom Hanks ottimisti, ma secondo me non sono realisti».
Quando ha smesso di credere al sogno americano?
«Ci credo ancora in parte, sono nato sotto l’influsso del mito americano e non mi sento affatto un rivoluzionario. Sono un “evoluzionario”, semmai. Mio padre era un capitalista, a me piace credere nel socialismo, ma temo non funzionerebbe mai perché in America prevarranno sempre ideali come la libertà di fare, di migliorare, di progredire e di accumulare soldi, sempre più soldi, troppi soldi, uccidendo ogni competizione».
Che cosa risponde a chi da decenni la definisce un outsider?
«Io mi sento americano, ho servito il mio Paese in Vietnam. Solo, avrei voluto un Paese che cercava la pace anziché negoziare conflitti e prepararsi alle guerre come fa di continuo, spendendo miliardi su miliardi. Stringiamo accordi con i contractor basati su corruzione, errori, eccessi di budget e non c’è nessun controllo e nessuna punizione. Continuiamo a prepararci ininterrottamente per la guerra, facendo leva sulla paura della gente: investiamo miliardi nei caccia invisibili senza mai usarli, non sarebbe più utile spendere quei soldi per l’istruzione o per le strade? L’America è ossessionata dalla guerra e dalla difesa, arriverà un giorno in cui potremo usare il nostro potente arsenale, come è già successo in Iran, in Iraq e ora in Afghanistan. Abbiamo testato alcune grandi bombe e non hanno funzionato. La verità è che dopo Kennedy nessun presidente è stato in grado di sfidare militari e intelligence, o di ridurre il budget per la difesa che aumenta in maniera spropositata di anno in anno. Lo stesso Biden, che ha ritirato le truppe dall’Afghanistan, non accenna a ridurre questo budget».
Ha nominato di nuovo Kennedy. Non è che dopo un film di finzione, due documentari e una serie tv, sta pensando di girare un biopic su di lui, come ha fatto ad esempio con “Snowden”?
«Potrei farlo, e potrei sorprendervi. Tra l’altro potrei avere a disposizione ulteriore materiale: Trump promise la pubblicazione dei documenti ancora secretati nel 2017, all’ultimo FBI e CIA lo convinsero che non era possibile e cambiò idea. Confido che il cattolico Joe Biden si ricordi di Kennedy e degli oltre duemila documenti ancora top secret».
Che relazione ha con Hollywood e con i suoi tabù?
«Hollywood è il Cinema della Sicurezza Nazionale. Ti insegnano che non avrai mai successo se fai film politici, eppure io con “JFK. Sulle tracce degli assassini” l’ho avuto, e anche con “Salvador”. Tutto sta nel rendere l’argomento interessante e saper intrattenere senza annoiare. Quanto ai tabù, oggi l’omosessualità non è più un tabù, è stata sdoganata da “Will & Grace” e io stesso l’ho raccontata nel mio “Alexander”. Il vero tabù a Hollywood, semmai, è il sesso: non è un problema vedere due uomini che si baciano, ma due persone che scopano sì, qualunque sia il loro genere e la loro età. Siamo ancora un Paese puritano e moralista».
Si parla molto di inclusione nello star system americano e non solo, ma c’è una reale inclusione di chi è “diverso” anche a livello di schieramento politico?
«Ci sono film conservatori che vanno molto bene al botteghino, perché la gente ama le idee preconcette e adora vederle riproposte sullo schermo. Il pubblico ama la ripetizione, vedere volti sempre uguali, film spesso simili tra loro, è un modo per mantenere intatto e identico a se stesso il sistema “cinema americano”. Per fortuna c’è anche un cinema evolutivo, sperimentale, in cui si cercano nuove cose e c’è spazio per il cambiamento. Sono film che hanno un percorso molto difficile, incontrano mille ostacoli per essere finanziati, per circolare ed essere distribuiti, visti, accettati. Ci vuole tempo».
È capitato persino a lei di avere difficoltà a reperire finanziamenti per i suoi progetti?
«Mi sono trovato più volte a vivere questa situazione di “avanguardia”, chiamiamola così. Il nome non conta niente se hai tra le mani un progetto che giudicano in qualche modo scomodo. Mi è capitato con “JFK - Un caso ancora aperto”, con “Natural Born Killers”, persino con il mio documentario lungo dodici ore “U.S.A. - La storia mai raccontata”, che dovrebbe essere mostrato nelle scuole per dare loro un’idea chiara, meno propagandistica e più radicale, della nostra storia».
Il suo è un cinema che sa parlare alle nuove generazioni. C’entrano i suoi figli in questo, li coinvolge nei suoi progetti?
«Ormai i miei figli (Sean, Tara e Michael Jack Stone, n.d.r.) sono adulti e hanno la loro vita, non li costringo certo a vedere i miei film. Magari li vedono pure, ma non sono obbligati a farne parte o a dirmi cosa ne pensano. Mi piace però avere un dialogo aperto con le nuove generazioni. Non amando quelli che si spacciano per giovani non sarò io a farlo, cerco solo di mantenere alta e viva la curiosità per quello che accade. E resto un idealista: mi auguro che chi condivide le mie idee continui a seguirmi».