Nel 2017 la Palma d’oro del Festival di Cannes viene assegnata al film “The Square” di Ruben Östlund. Il protagonista è Christian, curatore di un museo di arte contemporanea di Stoccolma. Östlund mostra con acume e ironia le contraddizioni del mondo dell’arte e i molti equivoci dell’arte impegnata. «“The Square“ mette in scena l’idea dell’arte come spazio all’interno del quale il pubblico si sente partecipe di alcuni drammi della nostra epoca», scrive Vincenzo Trione nel suo nuovo saggio, “Artivismo. Arte, politica, impegno” (Einaudi). Trione, accademico, storico dell’arte e critico d’arte contemporanea, individua con grande precisione l’affermarsi di una tendenza tra i frammentari scenari dell’arte del nostro tempo. Ne sono protagonisti gli artivisti: artisti che mirano a combinare estetica ed etica; che si interrogano su alcune emergenze del nostro tempo; che, con una nuova responsabilità dello sguardo, si applicano in atti concreti, coraggiosi, visionari. E ci aiutano a immaginare un altro presente.

Artivismo. Che origine ha questo neologismo?
«Agli inizi del 2000 ci sono state alcune artiste come Regina José Galindo e Tania Bruguera che si sono definite artiviste: un neologismo che metteva insieme arte e attivismo. Io sono partito da questo riferimento per fare una riflessione più ampia, cercando di usare questa categoria per leggere quello che a parer mio è il grande fenomeno artistico rilevante dell’arte dal 2000 ai giorni nostri: la linea politica dell’arte contemporanea».
È una definizione critica o un’urgenza ideologica?
«Nasce come urgenza, senza un vero programma. C’è stato un momento a partire dal quale alcuni artisti hanno deciso di abbandonare l’idea che l’arte fosse riflessione su sé stessa da un lato e gioco citazionista dell’altro. Hanno recuperato quella linea politica dell’arte che va da Goya e Géricault fino a Picasso, Dix, Fautrier, Guttuso… con l’idea che l’artista - come diceva Tabucchi – non dovesse guardare le stelle, ma il pozzo che ha sotto i suoi piedi; l’arte, cioè, dovesse farsi testimonianza e interrogazione sul mondo. Questa urgenza si è fatta istanza poetica che ha attraversato in maniera costante le grandi esposizioni e fiere internazionali. Il mio tentativo è stato quello di ricondurre dentro una visione unitaria quello che fino ad ora è stato un po’ frammentato».
Possiamo individuare in Pasolini e Camus i padri intellettuali dell’artivismo?
«Assolutamente sì. Non a caso una delle opere che cito è “Intellettuale”, che Fabio Mauri dedica a Pasolini. Oltre a Pasolini, c’è Camus: sia il Camus che pensa l’artista come grande testimone del suo tempo, sia quello che invita gli artisti a prendere posizione rispetto a ciò che sta succedendo intorno a loro. A essere in rivolta».
Lei cita le valigie di Fabio Mauri (“Il Muro Occidentale”), gli zainetti di Weiwei (“Remembering”), la guerrilla intellettuale di Hito Steyerl… in che modo l’arte diventa atto insurrezionale?
«Ci sono due strade prevalenti che provo a individuare nel libro. Da un lato l’arte che prende atto del proprio valore testimoniale. Dalla nube mediatica che ci consegna di continuo immagini di drammi, pandemie, immigrazioni… questi artisti elaborano esteticamente alcune suggestioni e le sottopongono all’attenzione del pubblico. Poi c’è un’altra strada, forse la più ambiziosa, che porta gli artisti a non voler essere solo testimoni. Sono artisti che si vogliono prendere cura del mondo e cambiare la realtà attraverso l’arte. Che è una grandissima utopia. Tra gli esempi più significativi c’è il Global Activism: sono artisti che intervengono all’interno di piccole realtà con l’intento di cambiare il destino di quelle comunità attraverso l’arte. L’arte si fa vita. Thomas Hirschhorn, per esempio, lavora con le periferie. Ha realizzato quattro monumenti di arte pubblica (“Monuments”) ciascuno dedicato a un grande pensatore del passato: Spinoza, Gilles Deleuze, Georges Bataille, Antonio Gramsci. A New York ha creato insieme agli abitanti di una periferia urbana un piccolo villaggio – una città alternativa con teatro, libreria, cinema, sala lettura, sala dibattiti – dedicato e ispirato a Gramsci. La comunità ha sentito e vissuto il monumento come parte di una nuova quotidianità. Quelle di Hirschhorn sono performance d’arte e di democrazia».
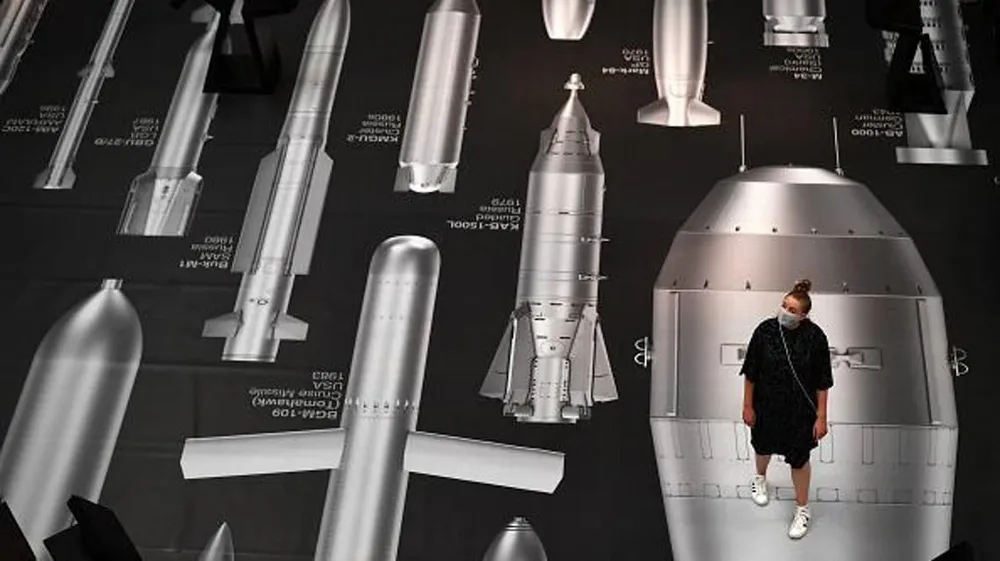
Nel libro si descrive un interessante cambio di sguardo, che da interiore si fa esteriore. È come se gli artisti avessero d’un tratto bisogno della realtà esterna, di ciò che si vede. Questo però è un fenomeno diffuso che ha caratterizzato anche altre forme artistiche come la letteratura, il cinema, la graphic novel. Olga Tokarczuk nel discorso di accettazione del Nobel ha messo in evidenza l’esigenza di porsi in ascolto del mondo.
«Questo è il grande vero tema: la linea politica dell’arte contemporanea non è un fenomeno isolato. È un fenomeno in accordo con quello che sta succedendo in altri ambiti linguistici, con alcune caratteristiche costanti: il soggetto conta di più della forma, l’immagine deve essere riconoscibile e realistica, c’è un rapporto diretto con la cronaca. L’arte guarda il mondo, viene dal mondo e vuole farsi sguardo sul mondo. Citando Pasolini, l’arte diventa lingua scritta della realtà».
Quali sono i temi dell’arte politica?
«I temi principali sono le migrazioni, la questione della razza, l’ecologia e la sostenibilità, il tema delle periferie urbane. Nella maggior parte di queste opere si offre una visione non positiva del reale; in molte si respira una sorta di incubo apocalittico. È come se l’apocalisse si fosse insediata nel nostro tempo e fosse una dimensione che incombe sul nostro quotidiano».
Lei cita le performance molto incisive di Regina José Galindo. Il corpo è un modo per fare politica?
«Ci sono alcune artiste che definisco “mistiche”. Le mistiche sono quelle artiste che, recuperando la grande tradizione della body art, usano il proprio corpo come strumento di opera d’arte. Il corpo è sudario e strumento politico. Sia Regina José Galindo che Tania Bruguera vanno in questa direzione».
Per essere artisti militanti oggi bisogna essere artisti totali? Essere presente sui social? Esprimere la propria opinione su tutti i mezzi possibili?
«È un tema che si pone soprattutto per la street art. Banksy è probabilmente il caso più esemplare: è l’artista più invisibile e più mediatico al tempo stesso. L’anonimato per lui è una sorta di scelta estetica (se dovessi dire l’opera più importante realizzata da Banksy, direi l’anonimato, ancor più dei suoi lavori). Però è interessante vedere come Banksy opera con i media: non li usa come vetrine, ma come luoghi creativi. Per esempio il lavoro che Banksy fa su Twitter: si tratta di vere opere d’arte realizzate per quel social specifico».
Come si connette l’artivismo al movimento Black Lives Matter?
«Art Review lo scorso anno ha posto in cima alla classifica delle personalità più influenti nell’art system il Black Lives Matter. I suoi fondatori sono artisti? No. Tuttavia sono portatori di un’esperienza trasversale; sono personalità diverse che hanno provato a mettersi insieme per raccontare un’emergenza e, dunque, indicano un certo bisogno di collettivismo. Molti artivisti oggi sentono quest’esigenza: quella di fare arte insieme. La prossima Documenta di Kassel verrà affidata a un collettivo indonesiano di artivisti che si chiama ruangrupa. I ruangrupa non sono artisti in senso tradizionale: sono gruppi mobili con un nucleo fisso che per ogni progetto collabora con altre figure. Ci può essere l’artista visivo, ma anche il sociologo, l’urbanista, l’antropologo… Il tema delicato è che non realizzano opere, ma gesti, provocazioni, collaborazioni con comunità. In un certo senso l’arte da museo non esiste più».
In che modo l’artivismo si fa azione politica e civile nella mente del suo fruitore?
«Il primo è quando lo spettatore è invitato a guardare un determinato fenomeno da un’angolazione diversa. Se guardo “Hope”, un’opera di Adel Abdessemed, in cui una grande barca è invasa da giganteschi sacchetti dell’immondizia, sono invitato a pensare al fenomeno delle migrazioni come non avevo mai fatto. C’è poi il dispositivo dell’empatia, come accade per Carne y Arena, opera eccezionale del regista Iñárritu, in cui la fruizione mi porta all’immedesimazione con i migranti tra Messico e Stati Uniti. Infine c’è una terza via che è quella in cui l’arte è espressione di un dialogo tra artista e cittadini, strumento di rigenerazione (e rinascita) urbana, come spesso accade per molte opere della street art».
Cos’è la responsabilità dello sguardo?
«È una suggestione che arriva da Amitav Ghosh. Molti intellettuali pensano che lo sguardo non possa più essere distratto. L’obiettivo dell’artista è quello di assumersi una responsabilità rispetto a quello che sta succedendo e farsi figura politica».
La rivoluzione siamo noi, diceva Joseph Beuys.
«Beuys è stato un Pasolini dell’arte. Nella sua visione il pubblico non è più spettatore ma protagonista, e l’arte può determinare delle azioni, degli atti nella vita reale. La missione ultima dell’artista è quella di offrirti le chiavi per immaginare diversamente il mondo che abiti».



