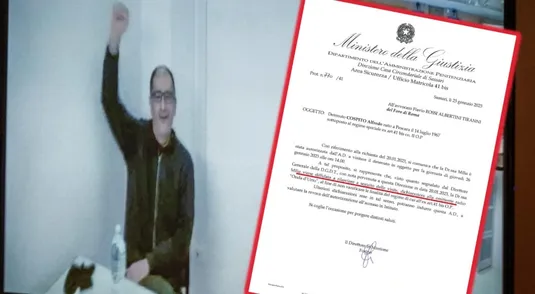Il primo ristorante al mondo aperto dentro un carcere si chiama InGalera e assume detenuti: dallo chef ai camerieri. Citato dal New York Times nel 2016 e diventato un esempio in tutto il mondo, è nato dalla determinazione e dalla visione di Silvia Polleri, nota anche con il soprannome Nonna Galeotta, imprenditrice nel settore del catering che il quotidiano statunitense ha definito «visionary». InGalera venne aperto nel 2015, con il direttore Massimo Parisi che non temporeggiò, ma disse immediatamente a Polleri: «Perché no?». E lei ammette: «È stato coraggioso. Io sono cambiata tanto in questi anni, ho iniziato a vedere il mondo in modo trasversale».
I dipendenti hanno un contratto regolare, pagano le tasse, rispettano le regole del carcere e non usano questo impegno per ottenere sconti o aggirare ostacoli. Superano un colloquio di lavoro in cui non sono determinanti il reato che hai commesso o il fine pena, ma l’esperienza e la voglia di impegnarsi in un’esperienza totalizzante, con le fatiche e le lotte che conosce bene chi sceglie questo settore.
«Un ristorante in carcere è una provocazione, perché un altro carcere è possibile. La recidiva in Italia è, in media, del 70 per cento, ma il carcere di Bollate ha un tasso del 17 per cento. È quel 70 per cento a essere una vergogna della società. Bisogna riuscire ad andare oltre il muro: ci si può elevare grazie al lavoro. L’opportunità di riscattarsi deve essere concessa ed è interesse collettivo che questo avvenga. Ho fatto di tutto per evitare che la prenotazione di un tavolo avvenisse solo per la curiosità morbosa». Così racconta Silvia nel documentario di Michele Rho, suo figlio, prodotto in modo indipendente. Il fine non è quello di prenotare un pranzo o una cena per osservare da vicino coloro che hanno commesso un reato, «come fossero scimmiette» o fenomeni. Il cibo è un ponte, ma è anche il simbolo del raggiungimento di un diritto. È speranza, libertà.
«Ho girato il documentario utilizzando il bianco e il nero, perché per me voleva dire dare dignità alle storie; quando giri in galera, infatti, c’è sempre un linguaggio quasi smorto, slavato, si vedono colori squallidi. Non abbiamo nemmeno raccontato i reati commessi, non era questo l’obiettivo», spiega Michele che l’ha realizzato seguendo gli ultimi tre anni di InGalera e prendendo esempio dal trasporto e dalla concretezza di sua madre, ma soprattutto da quella dei detenuti: «Sentire queste storie è una cosa, ma conoscere, entrare in quelle stanze, dove il tempo si ferma, è dilatato, non ti può più lasciare indifferente».
Senza reinserimento lavorativo non c’è riabilitazione, ma il tema della seconda occasione nella vita è molto difficile da trattare. Esistono le vittime, le loro famiglie e questo non potrà mai essere secondario, come conclude Silvia: «Quando faccio i colloqui ai detenuti che cercano lavoro al ristorante, torno a casa con un male alle spalle. Ho imparato in questi anni a mantenere un equilibrio: con una gamba porto avanti il percorso di speranza delle persone con cui lavoro, con l’altra il rispetto per le vittime. L’uno non esclude l’altro, ma che male alle spalle avrò per sempre!».