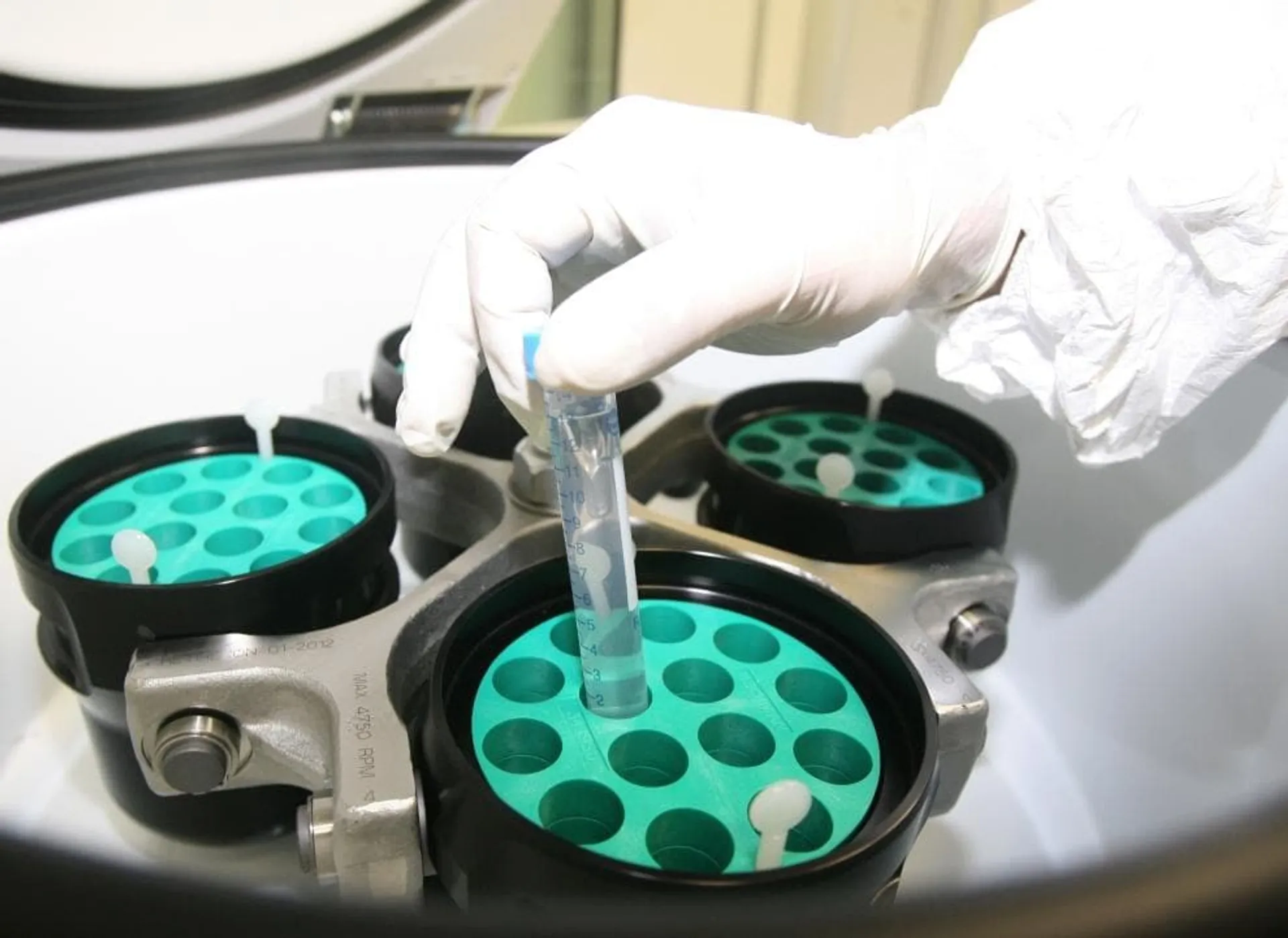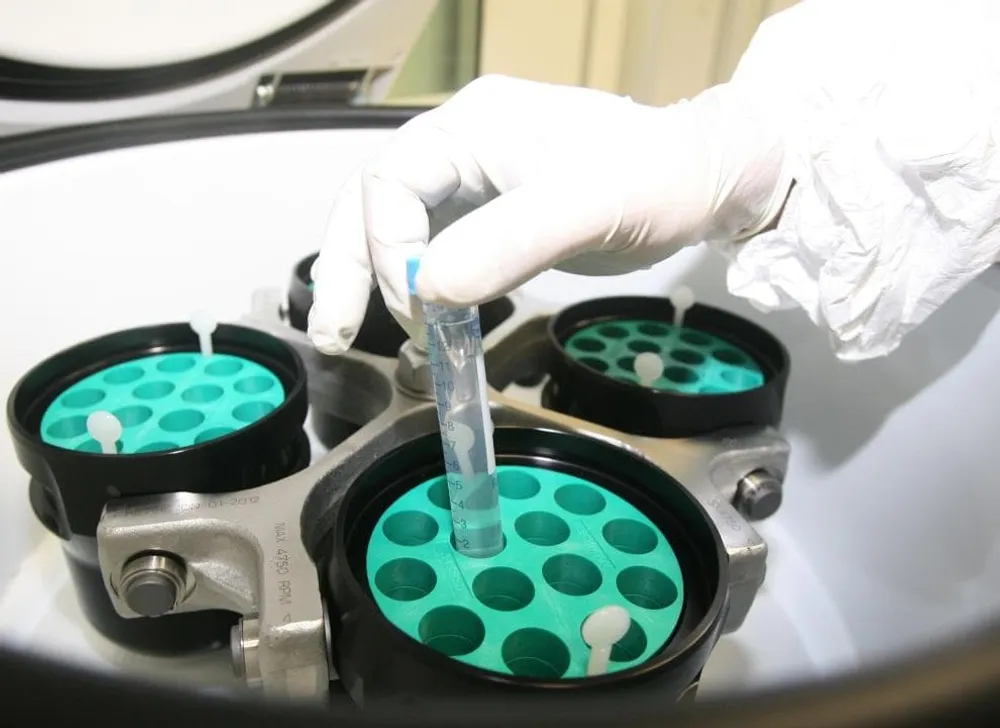
Ma l’Imi, questa partnership pubblico-privata nata all’indomani della Grande crisi del 2008 per potenziare la ricerca sanitaria europea e offrire soluzioni lì dove per i big del farmaco non fosse abbastanza conveniente, ha affrontato l’emergenza epidemica con colpevole ritardo.
Nel marzo del 2018 la Commissione aveva proposto all’Iniziativa di fare della “preparazione biologica”, ovvero di investire sulla cura del nuove epidemie, un importante settore della propria attività. In particolare aveva suggerito che l’Imi si concentrasse sulle modalità per facilitare lo sviluppo e l’approvazione di vaccini contro i patogeni prima che un’epidemia scoppiasse. L’Imi gentilmente declinò. Nei verbali della riunione del 20 marzo si legge che «il tema normativo proposto dalla Commissione non è stato sostenuto dalle industrie dell’Efpia» (ndr: la lobby europea delle aziende farmaceutiche), anche se «il tema della modernizzazione della regolamentazione è considerato molto importante dalle industrie e sarà ulteriormente discusso». E mentre prosegue «l’interazione con la Coalizione per le innovazioni in materia di preparazione alle epidemie (Cepi), non si prevede alcun co-investimento immediato». Ovvero: l’Imi non intende finanziare né progetti propri, né il Cepi, la coalizione che si concentra sulle nuove malattie infettive. Ma è l’Imi ad avere in mano i cordoni della borsa della ricerca farmaceutica europea: la cosiddetta partnership, in scadenza quest’anno ma pronta per un secondo rinnovo a partire dal 2021, è stata finanziata per metà in contanti dall’Unione europea (1,64 miliardi per il secondo mandato) mentre Big Pharma (un terzo dei 39 membri di Efpia sono multinazionali americane e gli altri big europei come Bayer, Sanofi e la svizzera Novartis) non ci ha messo un euro. In 12 anni e due mandati ha versato contributi esclusivamente sotto forma di tempo-lavoro di ricercatori e laboratori, pur essendosi riservata la facoltà di ritenere diritti esclusivi sui risultati delle ricerche.
Avanti due anni, siamo nel 2020, e le epidemie sono diventate il fulcro della ricerca medica contemporanea: emergenza ma anche business miliardario. Ora l’Imi è in prima linea con investimenti e impegni: sono oltre 120 i progetti finanziati con i soldi della Commissione su cui le grandi aziende farmaceutiche stanno lavorando. Ma con un caveat, si legge nel rapporto “Più privato che pubblico” del Corporate Europe Observatory, una delle maggiori ong europee in materia di trasparenza, ottenuto in esclusiva per l’Italia dall’Espresso: le risorse versate all’Imi non hanno condizioni, e dunque non è chiaro se trattamenti o strumenti diagnostici di successo eventualmente sviluppati saranno mai resi accessibili, logisticamente ed economicamente, a coloro che ne avranno davvero bisogno. Gli autori del rapporto accusano l’Imi, tra le altre cose, anche di non contribuire a rendere le medicine più accessibili, come sarebbe parte del mandato, ma di rafforzare un sistema che pone l’onere di prezzi sempre più alti sui budget nazionali.
I precedenti certo non sono incoraggianti. I 30 mila morti per Ebola del 2014 si sarebbero potuti evitare se l’Imi avesse dedicato parte delle sue risorse a studiare un vaccino per una malattia a mortalità elevata ma che fino ad oggi ha colpito solo Paesi poveri. E invece le indicazioni di svilupparlo da parte della Commissione europea, che pur ha cinque dei dieci membri nel Cda di Imi (tra cui l’italiano Carlo Pettinelli che si occupa di salute e ambiente), sono partite solo nel 2014. Però nemmeno nel 2016 o nel 2018, quest’ultimo l’anno in cui l’epidemia rischiava di andare fuori controllo, si sono tradotte in un aiuto reale ai malati. Nonostante il successo delle prove di laboratorio ottenute tra il 2014 e il 2016 per un vaccino, Merck & Co., (operante oggi in Italia come MSD Italia Srl) non ha portato avanti le procedure per la commercializzazione, tanto che nel 2018 non aveva ancora ottenuto il via libera per l’utilizzo. Risultato: il vaccino ci sarebbe ma può essere utilizzato solo con pesanti restrizioni che non consentono l’immunizzazione della popolazione. Resta il dato di fatto: perfino l’uso di fondi pubblici europei non riesce a spezzare la logica di profitto estremo di Big Pharma e intervenire con successo in aree considerate “non redditizie”. Il problema e il dilemma etico che ne conseguono sono talmente gravi che alcuni scienziati hanno fatto notare che «l’unica speranza di un investimento serio per ridurre l’incidenza e l’impatto di malattie come Ebola (o malaria) è diffonderle nei Paesi sviluppati».
Un altro esempio di come l’Europa abbia delegato a Big Pharma la sua ricerca sanitaria senza preoccuparsi a sufficienza di conseguenze e implicazioni coinvolge Sanofi, l’azienda farmaceutica francese che avrebbe voluto vendere l’eventuale vaccino contro il coronavirus in maniera prioritaria agli Stati Uniti, nonostante 18 dei suoi 30 siti produttivi siano in Francia e goda di aiuti statali. Solo l’intervento del presidente Emmanuel Macron ha costretto l’amministratore delegato Paul Hudson a fare marcia indietro pochi giorno dopo le sue dichiarazioni di metà maggio.
Nel 2017 il colosso francese stava lavorando con fondi dell’Imi su un progetto (il CHEM21) per ridurre i costi di produzione di un farmaco anti-Hiv. L’idea era che se fosse costato di meno sarebbe potuto essere distribuito in Africa a un prezzo inferiore. Il presupposto era che il prezzo della flucitosina, il farmaco anti-meningite, una delle cause principali di morte per i malati di Hiv, dipendesse dagli alti costi di produzione. In realtà, non sembra essere il caso, visto che il farmaco è in circolazione da 60 anni ma il prezzo è passato dai 6 dollari al giorno di dieci anni fa ai duemila dollari odierni. In ogni caso, il nuovo processo, grazie all’intervento dell’università inglese di Durham, è stato trovato. Ma né Sanofi, che ne detiene i diritti di utilizzo (e in parte anche Durham), né un’altra società hanno mai cominciato ad utilizzarlo per produrre. La cosa si è fermata a livello di “trattative” con un’azienda sudafricana. Intanto i cittadini africani continuano a morire di meningite esattamente come prima (ma milioni di euro dopo) dell’intervento dell’Imi. Che, va ricordato, non ha mai specificato come i guadagni di efficienza del costo di produzione si sarebbero trasformati in prezzi più bassi per pazienti e sistemi sanitari.
Ed è proprio il peso sproporzionato che Big Pharma ha nella partnership con la Commissione, accusata da più parti di non avere assunto un vero ruolo guida nell’utilizzo dei fondi e dei progetti a rendere lo strumento, in sé cruciale, di fatto poco utile per il pubblico che lo finanzia e molto strumentale invece per i dividendi dell’industria farmaceutica. D’altronde fin dall’inizio Big Pharma ha controllato agenda e priorità dell’iniziativa. Nell’ottobre 2009, il commissario per la Ricerca Janez Potocnik, in un discorso davanti ai membri di BusinessEurope, la più grande lobby industriale europea, spiegava che «gli investimenti privati europei sono troppo bassi» e che dunque la Commissione sarebbe intervenuta per aumentarne la competitività internazionale e creare eccellenze industriali. Ma di aumentata competitività industriale della farmaceutica europea non c’è evidenza. In compenso molte Pmi hanno lasciato il programma dell’Imi a causa del comportamento predatorio delle aziende più grandi.
La vera Cenerentola in questi 12 anni di Imi è stata la ricerca nei settori in cui c’è un urgente bisogno pubblico ma pochi soldi, dalle malattie tropicali, all’Aids, per arrivare alla resistenza agli antibiotici, a favore invece delle malattie dei Paesi ricchi: cancro, Alzheimer e diabete.
Secondo l’economista Mariana Mazzucato, ex consigliere tra il 2014 e il 2019 del commissario alla Ricerca Carlos Moedas, le zone del mondo potenzialmente non remunerative sono ignorate: tra il 2000 e il 2011 solo il 4 per cento dei nuovi prodotti farmaceutici sono stati per malattie che toccano Paesi a medio-basso reddito. D’altronde Efpia l’aveva addirittura scritto (e poi cancellato) sul suo sito nel 2011: «I grandi della farmaceutica trarranno vantaggio (dall’Iniziativa) perché le scoperte valgono molte volte il contributo di una singola azienda. In alcuni casi, offrono incredibili risparmi di costo visto che i progetti Imi replicano il lavoro che le singole società avrebbero dovuto fare comunque».
Lo strapotere di Big Pharma è stato sperimentato direttamente dall’Istituto di ricerca italiano Mario Negri nel 2013. «Siamo stati invitati a fare parte di un Consorzio per sviluppare un antibiotico con GSK (GlaxoSmithKline)», racconta al telefono da Milano Vittorio Bertelé, allora ricercatore dell’Istituto e segretario scientifico di Ecrin, una struttura che coordina la ricerca clinica tra Stati membri: «Mi sembrava un progetto a servizio non solo dell’industria ma anche dei servizi sanitari nazionali, molto lodevole, e lo raccomandai». Il problema arrivò non alla lettura del protocollo ma alla visione del contratto. «GSK voleva mantenere non solo i diritti sull’iniziativa, e va bene, noi siamo non profit, non chiediamo mai brevetti, ma voleva anche impedire che le istituzioni accademiche avessero libero accesso ai dati del progetto, e che potessero controllarne il risultato prima della pubblicazione, nonostante il tutto fosse finanziato da fondi pubblici». E aggiunge: «La rinuncia ci costò molti soldi e noi ne siamo sempre in cerca ma non potevamo abdicare ai nostri principi etici. Anche se ci chiamarono “naive”». Si ricorda di mesi di trattativa e teleconferenze, di una «Commissione sempre silente che invece avrebbe dovuto sostenerci». In una modalità in cui i confini tra il fare lobby e collaborare sono fluidi. In una contraddizione senza soluzione tra aumento della competitività industriale di pochi e l’interesse generale della popolazione.