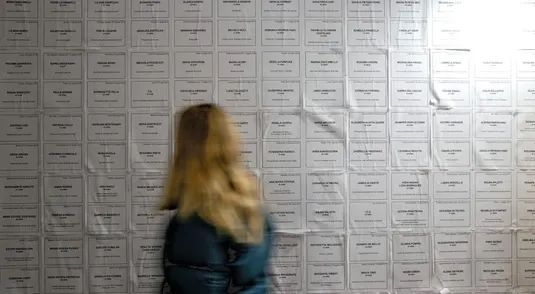Parto da Saman, premettendo che guardo alla sua tragedia come a un esempio, svincolandolo da polemiche, analisi, incriminazioni, retorica, perché merita rispetto, non strumentalizzazioni e il suo nome deve restare limpido, così la lascio riposare. Vorrei, invece, che finalmente venisse il momento in cui si prende in mano il coraggio e si ammette il colossale errore che ha portato a non puntare il dito contro quella che è, lo è sempre stata e l’abbiamo sempre saputo, una forma di inciviltà giustificata e protetta in nome di un abbaglio: non c’è identità tra sbarchi di immigrati e la denuncia di orrori; si è temuto che tale denuncia fosse strumentalizzata dagli xenofobi e motivatamente, ma non si può cedere a un ricatto tanto osceno se a farne le spese sono le vittime di soprusi continui, violenze, omicidi contro i quali ci pregiamo di lottare.
Non sono meno donne le ragazzine che, da quando insegno, vedo arrivare in classe stremate per un digiuno prolungato e imposto da padri che le ritengono oggetti di loro proprietà; non valgono meno le piccole donne che mi raccontano, sotto il giuramento di non parlarne con nessuno, di vivere da schiave in casa, destinate a servire il genitore prima e il fratello dopo; il terrore nei loro occhi quando ricevono un voto insufficiente o una nota, la più insignificante, sul registro dovrebbe farci sussultare e difenderle, aiutarle a non sentirsi sole, a ribellarsi sicure. Tutto ti rema contro: le situazioni sono note, ma la ragazzina non denuncia, non vuole allontanarsi dalla madre e dalle sorelle, dicono che sia mitomane, falsa e, alla fine, queste son cose che riguardano la famiglia, chiuso.
Poi arriva, tra gli altri orrori, Miriam, sorride sempre, ti dice che è felice ed è vero; ma, dopo cinque mesi, si lascia scappare che suo fratello l’ha presa per i capelli, picchiata con rabbia lucida in posti non visibili perché non gli ha portato il bicchiere con l’acqua a tavola, come dovuto. Riesce ad aggiungere che questa è la sua quotidianità e che, per sopravvivere, si taglia di nascosto, poi nega tutto e si rifiuta di parlarne ancora. Fingi di disinteressarti e aspetti, il preside ha convocato la famiglia e tu sai che questo è ciò che Miriam più temeva. L’accarezzi ogni giorno con lo sguardo e aspetti.
Finché, nel tuo giorno libero, non ti chiamano a casa: Miriam si è chiusa in bagno, ha un lametta, grida che vuole ammazzarsi, vuole parlare solo con te, e scappi da lei. E stavolta il preside non potrà dirti niente, hai chiamato l’ambulanza, arrivano i carabinieri, Miriam ora denuncia, e pensi che, per un maledetta volta almeno, la giustizia è giusta: i genitori e il fratello sono sotto sorveglianza, la piccola è trattata con il rispetto che merita, solo non se la sente di proseguire, vivere in un comunità, quella famiglia in galera, non ce la fa, i sensi di colpa la divorano, accetta questo compromesso che per lei è già l’eden e tu ci vuoi credere insieme a lei. Finisce la scuola, ti scrive una compagna: Miriam ha seguito la famiglia in Francia, non ha più un cellulare, nessuno sa più niente di lei.
Trascorrono gli anni, ognuno porta con sé nuove storie dell’orrore, qualcuna riesce a scappare, la maggior parte rimanda la ribellione ai diciotto anni, poi a quando conquisterà l’indipendenza economica, e intanto ripete la vita della propria madre, sulla via della rassegnazione. È una lotta impari, con armi spuntate, indifferenza, omertà dovuta a ragioni politiche, nessuna solidarietà alle vittime per opposte ragioni politiche (che son torti, non ragioni, i più miseri e beceri: non si salvino ragazze che qui potrebbero finalmente vivere, rimandiamo indietro tutti, accomunati vittime e carnefici) e loro in mezzo, sole. E io che non so dove sia Miriam. Davvero nessuno riesce a sentirsi un po’ responsabile?