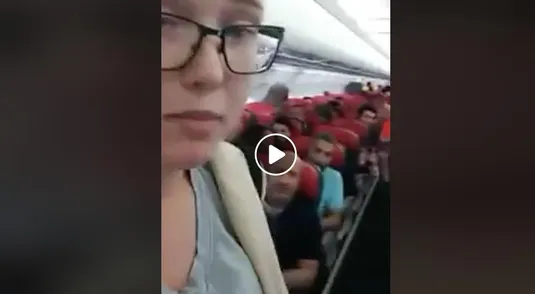È lui ad averci scritto. Una mail con l’oggetto in stampatello: vorrei raccontarvi la storia mia e di mio fratello, diceva. «Cordialement, Walid».
L’appuntamento è al centro d’accoglienza in cui lavora, un ex residence addossato alle colline pavesi. Ha portato una cartellina gialla che contiene foto, documenti, lettere: i frammenti degli eventi di cui parlerà. «Può sembrare facile, ora, una storia, così. È che il dolore non si riesce mai a spiegare veramente».

«Sono cresciuto in un villaggio di cui non posso dire il nome», dice: «Mia mamma abita ancora lì». La sua provincia ha visto ?il maggior numero di bambini uccisi dai combattimenti del 2016, secondo le Nazioni Unite. «Mio padre era medico. Viaggiava, parlava russo e francese. È stato ucciso quand’ero piccolo perché predicava che non era giusto sopprimere qualcuno solo perché non si faceva crescere la barba. Era considerato ?un infedele».
«Poi gli americani venivano a pattugliare ?il villaggio una volta a settimana. Se ne stavano chiusi nei carrarmati. Io mi avvicinavo, cercavo di parlare con loro. Ma avrebbero potuto spararmi. Sono andato così dal comandante dell’esercito afgano di distretto. Volevo aprire una scuola di inglese. Avevo 14 anni. Mia madre era contraria. Gli americani entusiasti: io li criticavo, dicevo che la guerra era colpa loro; ridevano. E mi aiutarono».
«L’imam si rifiutò, invece. Gridava che volevo convertirli. Che lavoravo per gli americani. Mi ha cacciato dalla moschea». Riescono a costruire il centro. «Un texano mi diede dei libri e arrivai ad avere fino a 50 alunni». Ha conservato due foto: sono tutti maschi, seduti per terra a gambe incrociate, in prima fila i più grandi, in mezzo i piccoli. «Era bellissimo. Parlavamo di inglese, d’arte, di libertà. Ero felice».
Un giorno però le forze statunitensi attaccano un centro d’addestramento vicino al villaggio, uccidendo cinque talebani. Walid riceve una prima lettera ?di minacce. Viene accusato di delazione: deve smetterla o sarebbe stato ucciso, scrivono. «Non mentivano. Sapevo quello che era successo a mio padre. E avevo visto i cadaveri esposti in strada. Per alcuni giorni mia madre mi obbligò a stare in casa. Quando doveva cucinare mi chiudeva nella gabbia per le galline».?«Finita la punizione, mi allontanai ?dagli americani».
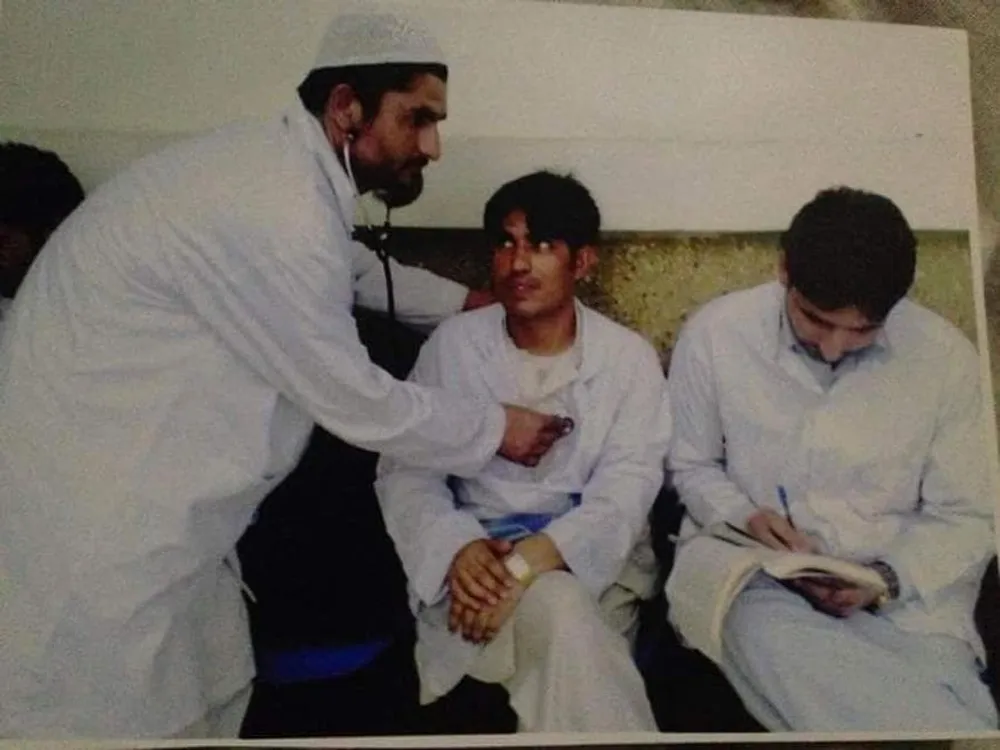
Walid ha una sorella più grande, analfabeta, «che ora però sta studiando come infermiera in città, grazie all’aiuto ?del patrigno». Un suo fratellastro è sbarcato a Crotone quest’anno, dopo esser stato torturato in Afghanistan. ?Del fratellastro conserva le pagelle: alla superiori aveva voti altissimi in fisica, biologia, chimica, trigonometria. Ma sono materie in fondo all’elenco. In cima: interpretazione del Sacro Corano, teologia, tradizione, pensiero islamico.
In quell’aprile del 2012 le minacce diventano più pesanti per Walid. Fino alla notte in cui sente saltare il cancello. «Me lo aspettavo. Dormivo apposta sul retro, accanto all’uscita. Sono scappato di corsa». I talebani bruciano il centro. Distruggono mura, manifesti. Incendiano i libri del padre. Prendono a calci la madre. «Ero riuscito ad arrivare dal mio amico», l’amico il cui papà aveva ricevuto il video che mostrava le torture al primogenito, «solo perché aveva lavorato per l’esercito ed era tornato a casa in vacanza». Lo porta in città. Il giorno dopo riesce a parlare al cellulare con la madre. «Avevo dei risparmi. L’esercito nazionale mi pagava ogni mese per le lezioni. Mia madre decise di vendere parte dell’eredità. Un detto del mio Paese recita: “finché c’è la testa ci saranno i cappelli”. ?È quello che mi disse lei quel giorno».
L’amico arrangia il prezzo con dei trafficanti. Come vuole la procedura della tratta, i soldi vengono dati a un fiduciario: sarebbero stati sbloccati all’arrivo, quando lui avesse chiamato. L’appuntamento è in Grecia. «Ad aprile sono partito da Herat. Sono arrivato in pullman fino all’ultima città afgana. Quindi in gruppo ci hanno portati sui pick-up su per le montagne.
«La prima volta la polizia ci ha intercettati e siamo stati rimpatriati subito. Al secondo tentativo abbiamo raggiunto Teheran. Dopo poco però siamo stati fermati. Mi hanno tenuto in carcere tre mesi». Era in cella con due iraniani, racconta: «Da loro ho imparato molto». È stato peggio fuori: «Ho un problema alle guance per via ?di un acido con cui sono stato colpito ?a un controllo. Anche la ferita di coltello alla schiena viene dall’Iran».
È ora di pranzo, a Pavia. Mangiamo insieme ai richiedenti asilo. Hanno cucinato riso, carne, verdure, frittelle. ?Fa parte dello sforzo di Walid e dei suoi colleghi per rendere occasione l’emergenza. Sembrano riuscirci: nonostante gli steccati alzati da alcuni vicini, ora dei ragazzi hanno trovato lavoro in un’azienda agricola; un altro cuce vestiti. «Molti però una volta usciti ci telefonano da Rosarno. Quando accade, fa male», commenta Matteo Vairo, responsabile della struttura.
Uscito di prigione, Walid ritrova il trafficante: in queste testimonianze sono una costanza carsica su cui non dubitare mai. Altro confine. «Abbiamo camminato per giorni. Non potevamo lamentarci». Istanbul. Poi attraversano ?la frontiera sull’Evros. A Patrasso entra ?nel tour dei fantasmi che gravitano intorno ai porti, quegli adolescenti dell’Adriatico fotografati da Alessandro Penso. «Come ?gli altri, ho provato molte volte prima di riuscire a schiacciarmi sotto un tir». Il viaggio dura un giorno intero. A volte, all’arrivo, i finanzieri trovano quei ragazzi, senza vita. «Non potevo muovermi. Mi sono svegliato quando ho sentito il motore ripartire». Il tir riprende la marcia. E non ?si ferma. «Ero disperato. Continuava a guidare, guidare. Non ce la facevo più. Così ho bucato il tubo della benzina. Ancora adesso ho l’abitudine di riempirmi le tasche di strumenti. I miei colleghi mi prendono in giro». «Quando ho realizzato di essere arrivato in Italia, la felicità mi stava strozzando». Incontra un’anziana che gli ?dà acqua, una maglia, delle scarpe: ?«Avevo le stesse da oltre un mese. ?Erano piene d’acqua».
La storia si fa italiana. Questura di Lecce, poi un centro per minori, quindi il Cara di Foggia. Lì cerca contatto con gli operatori, ma sono evanescenti. Riesce a incontrare, però, un avvocato, Costantino Nardella. ?«È stato fondamentale». Un altro angelo. ?A Borgo Mezzanone altri afgani cercano ?di distruggere una sua scultura blasfema. Viene mandato a uno Sprar gestito dall’ Arci. Lì conosce la Lia, l’associazione fondata nel 2015 per cui adesso lavora. Conosce sei lingue, collabora con le commissioni territoriali, ascolta le canzoni di Alessandra Amoroso. Ha urgenza di parlare: ha scritto una lettera a MeltingPot, si è fatto intervistare su alcune testate locali. E intanto insiste a spiegare come «nel mio Paese ci sia da 15 anni una coalizione di 49 Stati che in nessun angolo ha portato la pace». E come la stima delle vittime civili del conflitto in Afghanistan abbia superato le 31 mila.