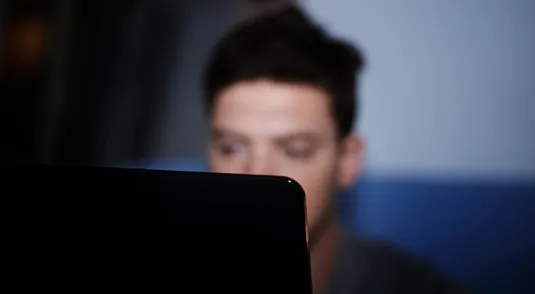È stata la loro prima macchina capace di muoversi su tre assi, conquistando la profondità per etichettare milioni di evidenziatori gialli e mettere loghi rosa fucsia su cofanetti di pongo. Per cui le è un po’ affezionato, Andrea, «oggi però è lenta, perde mezzo secondo a sequenza, vediamo che ha». Mentre il robot trascina cocciuto i suoi cuscinetti nelle guide ad aria compressa, così, l’operaio cerca sul monitor dove potrebbe annidarsi la causa di quella stanchezza. Vicina invece trema senza intoppi una macchinotta grigia e corpulenta: «è cartesiana, una tecnologia ormai arci-consolidata, a livello industriale, quindi molto affidabile», spiega l’operaio indicando i bracci d’acciaio che si incrociano continui: «qui l’innovazione è stata nel dialogo: l’elettronica permette a un hardware semplicissimo di muoversi con una precisione prima impensabile».
Rufina, borgo di vitigni, Chianti e colline a venti chilometri da Firenze. Qui si trova la produzione italiana di Fila, la fabbrica dei pennarelli Giotto (il pittore nato a pochi chilometri da qui), del Tratto-Pen, del Das da modellare o della paste farinose che migliaia di bambini impastrocchiano al nome di didò. Lo stabilimento di Rufina è un’ottima porta d’ingresso per capire nel concreto il nuovo standard della manifattura italiana. O meglio, della robofattura italiana. Perché nel secondario fattosi “4.0”, nel lavoro minacciato dalla sostituzione tecnologica, la norma della catena di montaggio innovativa assomiglia da vicino alla vita quotidiana di questi reparti. Dove, come racconta Michele Guidi, il direttore dello stabilimento, «qualsiasi attività di trasformazione è compiuta dalla macchina».
Ogni mutazione, torsione, composizione, della materia, è cioè realizzata dalla macchina. Il lavoratore non trasforma più; quello, lo fa la macchina. Le persone? «Controllano». Gli operai assumono così un ruolo di sussidio, di supporto, nel processo di produzione. Non stanno più sulla merce, ma sul robot: da tenere pulito, oliato, efficiente; da monitorare costantemente per capire se sta andando fuori rotta, conoscendone i congegni, per intervenire a risolvere eventuali problemi attraverso l’interfaccia che fa comunicare con gli automi. Nella nuova robofattura non più avveniristica, ma normale, appunto, i manovali si fanno badanti, insomma, controllori di robot. «È un processo che porta a un cambiamento culturale e organizzativo enorme», osserva Guidi. Come lui, sottolineano il definitivo mutamento della produzione tutti i principali i studi sul futuro dell’economia. Nel suo ultimo rapporto, McKinsey stima un rimpiazzo da parte della tecnologia di circa il 25 per cento delle attività, in Italia, entro il 2030. A esser colpiti saranno soprattutto i lavoratori fra i 45 e i 50 anni e gli impieghi definiti “manuali e prevedibili”. Ovvero in catena. Il settore secondario, quello dell’industria che due secoli fa ha cambiato il mondo, rischia di svuotarsi d’uomini. La sostituzione può monopolizzare fino al 65 per cento delle mansioni. Sono fra i 400 e gli 800 milioni di contratti in meno nel mondo; a persone, ovviamente. Per i robot invece è primavera.
Il dibattito è aperto, e continuo; agli ecatombisti ribattono quotidianamente quanti ricordano che ogni innovazione crea nuovi spazi più di quanti ne sottragga. Ma mentre fra think tank e bureau ancora si cerca di capire quale sia la strada giusta da seguire per dare un futuro al reddito, a Rufina si lavora. In modo completamente diverso da prima. Il settore dove vengono stampate le forme di plastica è storico ormai, nello stabile. Una lunga fila di apparecchi compatti consegna in media 4,8 milioni di pezzi al giorno: tappi, flaconi, porta-acquarelli, fino a un milione e mezzo di penne e pennarelli ogni 24 ore. Merci che nascono e si completano qui, per essere spedite poi immediatamente al centro logistico Dhl, nella nuova Ivrea del facchinaggio a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Il rapporto uomo-macchina in questo reparto è di 1 a 8. Un operaio ogni otto robot, che vengono svegliati al lunedì mattina e procedono metallici fino al sabato. Sono tutti targati Arburg, colosso tedesco fondato nel 1923 che fattura oggi 698 milioni di euro.
Arburg produce tutto in Germania, dove ha 2.500 dipendenti. L’impianto di Lossburg, controllata dalle famiglie Hehl e Keinath, esporta il 70 per cento delle sue creature; e oltre alla parte meccanica e a quella elettronica, vende anche un programma, Selogica, che è il linguaggio con cui le tute blu parlano alle macchine e viceversa, attraverso parametri che si imparano in corsi di formazione forniti dall’Arburg stessa. Sull’albo fornitori della rivoluzione tecnologica la Germania è certamente sul podio delle posizioni di forza. Anche l’Italia però si difende: all’ultima fiera europea sui robot industriali c’erano 274 aziende italiane; e l’unione dei produttori segnala ordini in crescita anche nel secondo trimestre del 2018, soprattutto verso l’estero (Cina, Polonia, Spagna, Messico e Russia i Paesi che ne richiedono di più); nel 2017, spiegano i costruttori, c’era invece stato l’exploit della domanda interna, grazie agli incentivi per l’innovazione messi in campo dall’ex ministro Carlo Calenda, ora in discussione per il rinnovo con Luigi di Maio che li ha concentrati soprattutto alle piccole imprese.
Anche fra gli stampa-colori della fabbrica toscana di pennarelli c’è una firma italiana: quella di Piovan, multinazionale capitalizzata da poco in borsa a 423 milioni di euro, testa a Santa Maria di Sala, a Venezia; era nata a Padova come officina meccanica nel 1934. Sono veneti pure i nastri che trasferiscono scatole di pennarelli e panetti di Das fra una corsia e l’altra, prodotti ad Arzignano, in provincia di Vicenza, da Domenico Virginio e i suoi 30 dipendenti. Dentro lo stabilimento toscano tutto il trasporto interno è automatizzato: navette nere e silenziose, made in Germany, scivolano rasoterra portando rifornimenti e pacchi da una parte all’altra dei capannoni, muovendosi grazie a sensori automatici e antenne wireless a seconda del bisogno. Ogni volta che si fermano vicino a un impianto per svolgere la loro commessa, caricano dati ed energia. Pure loro, come gli operai, fanno però anche una pausa pranzo. Quando le tutte blu vanno in mensa le navette si dirigono insieme nella stazione di «biberonaggio», nome tecnico, reale, della ristorazione robot, dove placche di metallo inserite nel pavimento forniscono loro l’energia che servirà nel pomeriggio.
«Perché si è bloccata in quel punto?». Anna nota un inceppamento a un braccio che sposta i pennarelli per metterli in fila. Il robot fa tutto da solo, ma può sbagliare. «C’è una misurazione che indica l’efficienza della macchina, l’Oee (overall equipment effectivness)», spiega il direttore dello stabilimento: «Perché la macchina è un organismo vivo, non ha solo due stati, “on” e “off”; è fatta anche lei di materia e come tale si consuma e si può guastare». È un po’ umana. «L’Oee “cento”, la perfezione, non esiste. È solo un concetto teorico. È la direzione a cui tendere», conclude, e sembra quasi stia parlando di morale. A Rufina lavorano 160 persone, compresi i chimici che si occupano della ricerca e gli impiegati alla gestione. Nello stabilimento operano 100 addetti, su tre turni. Per circa 100 macchinari, senza turni. “Fila” vanta giustamente il fatto che l’occupazione è rimasta costante negli ultimi 10 anni, nonostante la crisi, i costi, i mercati. Nel frattempo però la produzione è raddoppiata. I robot non hanno sostituito l’uomo, «almeno per ora», commenta ridendo (un po’) un operaio che sta controllando uno dei impastatori d’acqua e farina del Das: ogni giorno da Rufina escono 20 tonnellate di paste modellanti; la richiesta è in crescita, tanto una linea di produzione dei panetti morbidi e profumati di pongo o didò è in corso di rinnovamento, per cambiare più velocemente prodotto a seconda dei consumi, comunicando meglio con il sistema centrale che permette di prevedere ritmi e manutenzione.
Quanto spazio resterà di fianco a automi sempre più autonomi e indipendenti? Stefano Firpo, direttore generale per la competitività del ministero dello Sviluppo, lo ribadisce spesso: o l’Italia inizia a investire in formazione, tecnica (ma non solo) per giovani e adulti, o perderà l’unica via a un futuro anche umano dell’occupazione industriale. E quindi a un futuro di stipendi possibili. Perché alla sostituzione dei robot ai colletti blu come ai broker di borsa, o agli autisti, corrisponde l’altra ferita del nostro tempo: la disuguaglianza. Perché è, e sarà sempre più difficile, a queste condizioni, creare ricchezza partendo dalle proprie mani. Mentre sarà sempre più facile produrne partendo dai grossi capitali. Così, in attesa di politiche che provino almeno a affrontare l’accumulo sterminato di quei patrimoni, offrire una formazione adeguata alla sfida, a ogni grado della piramide, sarebbe già un passo fondamentale. Certo non è facile immaginare quali competenze siano più urgenti da trasmettere, ma ora l’intervento dello Stato è al minimo. E questo mentre nelle fabbriche la domanda è già cogente. «È appena andata in pensione una signora che ha lavorato sempre e solo in Fila», racconta Guidi, il direttore dello stabilimento di Rufina: «Presto ci troveremo ad affrontare un grande cambio generazionale. Ma come sarà la produzione nel 2030? Non posso certo sostituire i nostri attuali lavoratori con persone che hanno lo stesso percorso. Servono nuove capacità». Il futuro avanza veloce e mangia tempo, rende effimere alcune conoscenze, valide invece altre.
Ed eccolo, infine, il presente già futuro. Si muove a scatti rettilei dietro una gabbia, un cartello vicino ricorda che «gli organi meccanici in movimento non possono entrare in contatto con gli uomini». Rotea la sua mano-pinza, prende un secchiello di plastica, lo porta su uno scaffale, e poi sempre da solo, scattando o rallentando a seconda di quello che il suo motore “brushless” percepisce, pesca formine, penne, panetti di pasta di farina verde acqua, procedendo a comporre un gioco per bambini. Il suo corpo è fatto d’acciaio. Il suo programma sa far tutto da solo: dalla produzione alla confezione. «È il nostro primo antropomorfo», racconta un operaio. Antropomorfo non nelle fattezze (è un braccio meccanico) ma nelle capacità: si muove infatti tutti i punti dello spazio circostante, può roteare, ribaltarsi, cambiandogli pinza sa gestire qualsiasi tipo di oggetto piccolo o grande. Le sue radici stanno ai piedi del monte Fuji, in Giappone, nell’industria-città di Fanuc, uno dei colossi globali della produzione di automi. Ogni mese circa 400mila macchine escono dai capannoni gialli di Fanuc, estesi per 1,5 milioni di metri quadri di superficie. Una città, appunto, con 6mila dipendenti per 6,8 miliardi di dollari di vendite nette: la produzione è a sua volta, in gran parte, portata avanti dai robot.
Anna lavora in Fila da 12 anni, ora si occupa di rifornire astucci e inscatolare pennarelli su una linea che fa scatole di colori per tutte le classi di età. È felice, dice, perché in azienda ci si ascolta e si migliora, e perché si ricorda di com’era prima, quando doveva infilare 1.600 pennarelli in una tramoggia ogni ora; «era dura», ricorda. Adesso è più leggero il suo compito e più stimolante l’incontro coi pari: segue le fasi di assemblaggio e di confezionamento, tutte automatiche, e nelle riunioni propone soluzioni per rendere più efficiente la “sua” macchina. Vive vicina, tanto che ci potrebbe venire a piedi, in azienda, ha due figli.
L’antropomorfo più recente che Fanuc porta alle fiere internazionali non sta più in gabbia. I suoi sensori sono più sensibili, il suo sistema operativo meglio delineato, i suoi motori precisi al millimetro. Per cui, spiega l’azienda, può perfettamente collaborare con l’uomo. Nei video di promozione un operaio gli passa una ruota, o una scatola, e l’antropomorfo finisce il lavoro. Sarà questo il futuro? O piuttosto la fabbrica al buio, composta di soli organi meccanici, che sognava Roger Smith per la General Motors negli anni ’80?
A Rufina il pallet con i secchielli di didò colorati intanto è pronto alla spedizione.
Attualità
10 gennaio, 2019Visita allo stabilimento dove il destino dei lavoratori è assistere i robot che rubano loro il posto (Illustrazione di Maurizio Ceccato)
LEGGI ANCHE
L'E COMMUNITY