
Voglio arrivare in piazza della Scala, penetro la città serrata, dove è l’assedio e dove l’assediante?, voglio toccare con mano le pietre parlanti del teatro e del municipio, la galleria che porta verso il Duomo, le pietre mute perché nessuno ascolta più il loro insegnamento. Questo è un tempo incapace di concepire la pietra, cioè la statua, di scolpirla e di esporla ovunque, è un tempo senza statue. Noi, i viventi di adesso, ci muoviamo ormai troppo lenti, siamo noi le statue: di carne. Chi ci scolpisce?
La messaggistica istantanea e l’elettricità pervasiva contraggono il tempo, noi ci muoviamo pachidermici e biologici in un tempo che scarta l’organismo a favore della macchina e delle sue dimensioni. Milano è la capitale di questo stato evolutivo, l’umano sempre più veloce è troppo lento. L’elettricità è lo spirito. Milano esercita un mesmerismo. Ipnotizza dieci milioni di turisti l’anno, con il suo skyline instabile, quattro grattacieli velleitari che stanno scrivendo la storia mondiale e surclassano la maestosità silente e meditabonda di una cattedrale che osserva con gravità l’umano da sei secoli. Entro come un fantasma nella cerchia della città fantasma. Al ventesimo giorno del contagio la nazione ha chiuso, ma la metropoli aveva chiuso ben prima. Il silenzio era andato solidificandosi di giorno in giorno. Gli umani, in giro, sempre più rari. Ci sentivamo grossi bacilli in fila per predare il supermercato i primi giorni dell’emergenza. Bisogna raccontare gli scaffali svuotati. Nessuno di noi aveva mai visto prima il fondo della scaffalatura al supermercato, era un segreto che detenevano soltanto gli addetti a riempirli. Gli scaffalisti dei supermercati, questi stipatori per conto terzi, pallidi e trasandati sotto i loro camici bianchi e verdi semiaperti sul davanti, si distinguono dai commessi, turnano, accumulano. Cosa sappiamo delle loro vite private, delle loro perversioni?...
Ruoto solitario nella piazza della Scala, non c’è anima viva, non ci sono neanche le anime morte. È un capogiro, ruotare a trecentosessanta gradi nel vuoto smisurato, la piazza metafisica, De Chirico diventato reale, io come un manichino minato dalla bronchite acuta e dall’insufficienza morale: dove sono i miei concittadini? Murati nelle case, ridotte a catacombe vivibili, hanno maturato il sentimento di colpa verso il mondo e se stessi? Hanno compreso che stavamo tutti correndo troppo?...
E quindi punto all’ospedale centrale. Il contatto è un infermiere di chirurgia toracica. Sta fumando con un’indolenza da sonnambulo, da fantasma... Mi fa strada. Mi porta al centro occulto del contagio. Dove rianimano. Dove li perdono.
«Ieri ne è scappato uno.» Emette una voce calda, meridionale, ha il polso largo e irsuto, piccole escrescenze di pelle sulla faccia gonfia, l’occhio cirrotico, una stazza da maschio del Sud più retrivo e umbratile. Parla secondo una calma meridiana, ritratto nell’ombra delle stanze più interne in quelle case per cui si indebitano i miei parenti siculi, coprono di cellophane i divani e ci sistemano sopra bambole a grandezza umana. Quest’uomo viene fuori da Balzac, non da Kafka. È l’errore del tempo, di questo tempo: servirebbe Kafka, il cruccio del padre di famiglia davanti a un rocchetto di filo vivente che gli sopravvivrà, la talpa che racconta, il cane che indaga, i topi che cantano l’opera lirica, la scimmia che conciona all’accademia, il macchinario che invade il corpo prolungando l’attesa del decesso, l’agrimensore che non misura nulla, la condanna alla morte per acqua sancita contro il figlio dal genitore moribondo. E non ciò che conosciamo già. L’umano deve stupirci, deve non confermare il giudizio che da sempre abbiamo desunto dalla sua vicenda sul pianeta, fin troppo credibile. L’infrazione alla storia, non l’estrazione dalla storia.
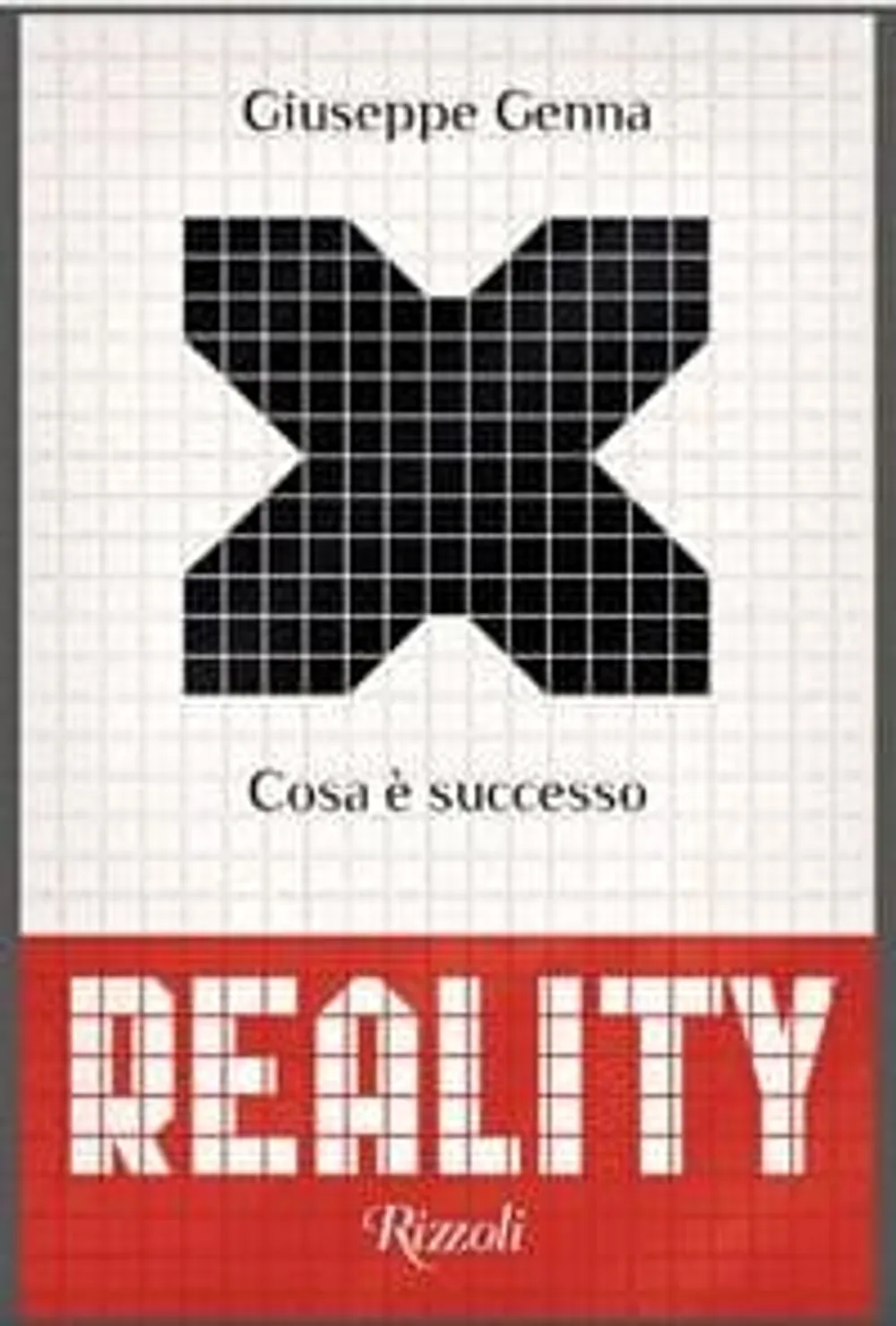
«È scappato. Uno positivo. Era in reparto Covid» risponde mentre zoccola tra i sotterranei. Pare di essere in The Kingdom di Lars von Trier. Le mattonelle in cotto sono viscose, una fanghiglia che sa di candeggina, qualcuno ha passato lo straccio imbevuto di un’acqua sporca, senza asciugare.
«Ma dove è andato?»
«È uscito in pigiama, a piedi nudi. Nella confusione del triage non se ne è accorto nessuno. Un uomo. Cinquant’anni. Non del tutto asintomatico, aveva le energie per correre. È uscito dall’ospedale, ha attraversato Francesco Sforza, è passato oltre l’università, verso il Verziere, piazza Fontana, poi piazza Duomo. È sceso nella metropolitana. In pigiama, nessuno lo ha fermato, ha passato i tornelli, si è precipitato sulla banchina e si è lanciato sui binari mentre arrivava un treno. Il conducente è riuscito a frenare. Il paziente Covid è rimasto lì, col treno a un metro, il suicidio fallito, la gente che tentava di tirarlo su ed era un positivo.»
«Ma perché è scappato così?»
«Una crisi di angoscia. Ha derealizzato. È un imprenditore. Due anni fa a distanza di un mese pare che gli siano morti il padre e la madre. La moglie lo ha mollato, hanno due figli, la maggiore è stata sottoposta a sette interventi per un difetto cardiaco, un martirio, poi hanno cominciato a operargli il figlio minore, era andato in peritonite. Ha dovuto chiudere l’azienda settimane fa, per il virus, è sul lastrico. In reparto ha cortocircuitato.»
«E adesso?»
«Adesso lo hanno messo in reparto psichiatrico, che non è attrezzato per pazienti positivi. Hanno tirato su un muro in cartongesso in due ore, per isolarlo, sedandolo, lo hanno asfaltato di antipsicotici, ma è positivo, rischia di contagiare tutti. Hanno tirato su il muro, ma il bagno è in comune, non hanno la ventilazione.»
Risaliamo le scale lerce di lana di polvere, bigi, dal sotterraneo in superficie, proprio sotto il reparto dei contagiati...Aspetto il presidio. Attendo per un tempo che mi sfinisce... Come una scimmia lenta, brachicardica, fuoriesce dal reparto il mio contatto. Mi dà le disposizioni. Non so cosa faccio. Devo muovermi secondo standard inconsulti. Compio gesti non familiari. Mi slogo. Agisco a specchio con chi mi sta davanti e mi istruisce. Mi sento ridicolo e tragico. Sanifico le mani con il gel alcolico, con lentezza e vigore incrocio le dita, sanifico il pollice, la punta delle dita contro il centro della mano, dobbiamo canticchiare per due volte Tanti auguri a te, quello è il tempo giusto per una sanificazione soddisfacente, biascichiamo la canzoncina del compleanno, ostentando i movimenti a braccia tese in avanti. Indosso il primo paio di guanti. Infilo il sovracamice, cartaceo, verdino, annodo i legacci dietro il collo e alla vita, i polsini devono sovrapporsi ai guanti. Devo sistemarmi la cuffia con precisione, lasciare dentro tutti i capelli, fasciare il collo, annodare sul retro. Preparo il filtrante facciale ffp3, è la mascherina professionale, devo modellare lo spazio per il naso, vanno posizionati gli elastici sulla nuca e sul collo, gli elastici non devono incrociarsi, bisogna eseguire la prova di tenuta, gonfiare con il fiato la mascherina, lasciarla aderire alla perfezione, plasmare ancora la zona del naso. Sulla fronte sistemare la fascia della visiera protettiva, la plastica rimanda il calore del volto, è il principio di una sauna biologica.

Il secondo paio di guanti, devono coprire i polsini. Impieghiamo un quarto d’ora. Sono inesperto, la goffaggine significa contaminazione, allerta, l’attenzione allo spasimo. Tutto il tatto è rivoluzionato. Sono isolato. Non sento niente. Entro...Le stanze della terapia subintensiva: decine di umani sotto caschi da palombaro della regia marina, sono i caschi cpap, in queste ore gli acronimi dominano la lingua tra la vita e la morte, la lingua penultima, c’è un piacere suppletivo a parlare per acronimi, ci si sente tecnici, iniziati. Producono la ventilazione a pressione positiva continua, per le insufficienze respiratorie. I pazienti sono chiamati così: “le insufficienze”....Cosmonauti ottocenteschi. Teche di formalina per teste attaccate ai tronchi... Ognuno è uguale a ognuno. Ogni storia individuale è ammutolita, non è dato conoscerla, compressa nello stordimento dello spasmo. Le parole sono dismesse. Più ci si avvicina alla fine del respiro e più le parole si rarefanno, sono disabilitate. Parole, antiche sorelle: addio. E oltre quella porta più avanti, oltre le infermiere che vorticano come api, la terapia intensiva: gli “intensivi” che non mostrano da nessuna parte, rari lacerti video e nessuna foto. I corpi prossimi all’estinzione, l’avanguardia di noi tutti. Il monito silenzioso, il silenzio da penetrare. Nessuno parla. Eccoci. Otto umani sospesi. Sono intubati. Li hanno messi proni. La pronazione aiuta a respirare, all’ultimo. In coma farmacologico, sedati. Rilasciano le braccia lungo il corpo, i palmi delle mani verso il soffitto. Nudi, coperti da un lenzuolo minimo. Il caldo qua è tropicale e si annusa il sudore acido nell’aria cattiva, i camici e gli scafandri impediscono la traspirazione, medici e infermieri non possono pisciare, per sei, dieci ore, vanno avanti trattenendo la vescica e puzzando come selvaggina, come homeless, sono homeless, non hanno casa...La febbre arde i corpi. È un olocausto. Il fuoco è l’estremo rimedio, l’estrema linea di confine. I cadaveri viventi sono gonfi, proni, nudi con il tubo tracheale. Fatico a trattenere la tosse, il catarro si muove al ritmo del mio respiro corto. Le infermiere hanno i lividi da mascherina, quando la tolgono, la pelle in ecchimosi dove i lacci stringono: sono spaventose, come se avessero evitato i femminicidi...
Chi si sveglia dalla sedazione o dal coma farmacologico è in stato confusionale, capisce male, sta nel capogiro, nella vertigine, non può parlare. Gli infermieri comunicano con i risvegliati mostrando fogli scritti a mano con il pennarello, “Buongiorno”, “È ricoverato in terapia intensiva”, “Non c’è libero accesso ai parenti”, “Siamo in stretto contatto”.
E non è vero. E non sentiranno più una parola umana, una fonazione, gli intubati che con lentezza muoiono a spasmi...Io sono tra i loro corpi instabili, tra le loro anime acuite, che tremano, nel sisma delle macchine....
Fratelli miei, sorelle mie, sono qui a guardarvi per la prima volta, per l’ultima volta. Voi siete per me pericolosi. Ogni sguardo su di voi è un lascito, un’oscenità.
Appoggio il dito indice nella mano rilasciata di un anziano. Per riflesso nervoso me lo stringe, risponde come un neonato vecchio, artiglia il dito, le unghie lunghe, ingiallite, le dita catramate di chi fu un fumatore, il caldo infetto della sua pelle attraverso i doppi guanti si percepisce bene che lo consuma, che lo finisce. Per intubarlo gli hanno tolto la protesi dentaria, il volto gli è collassato dentro, il volto di tutta la terza età avanzata. Come vorrei fargli scivolare via dalla gola il tubo duro, stringerlo al petto, allattarlo al capezzolo con la mastite, dargli vita, baciare la sua fronte, liberarlo dalla fleboclisi, portarlo insieme a me fuori, nell’aria pericolosa di questa primavera che stenta a crescere, caricarmelo sulle spalle, nella città deserta, come un Anchise, per piazze e svolte sentirmelo sulla schiena, povere ossa e pelle rilasciata, la pelle di cartapecora, di papiro, e deporlo sul sagrato della cattedrale e recitare un peana, una lode, per colui che muore al posto nostro e ci rappresenta in questa avanguardia, muore per noi...
Vorrei carezzarli uno per uno, questi corpi, carezzare i loro respiri minuscoli, la fatica di morire sempre un poco di più, un poco di più ancora...
Scusatemi tutti.
Pubblicato per Rizzoli ©?2020 Giuseppe Genna.
Estratto pubblicato per gentile concessione dell’autore in accordo con Piergiorgio Nicolazzini Literary Agency (PNLA)



