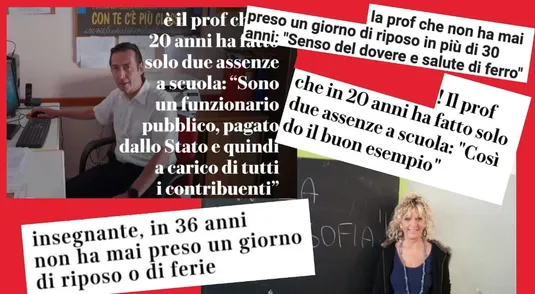La seconda tappa del Gran Premio 2022 è arrivato a Gedda, in Arabia Saudita, il 27 marzo. Definito il “più veloce tracciato cittadino nella storia della Formula 1”, è stato inaugurato il 3 dicembre 2021, dopo una corsa contro il tempo per concludere i lavori: per finire il circuito migliaia di operai hanno lavorato giorno e notte. Diverse voci raccontano a L’Espresso la frenesia di quei giorni. «Assegnare all’Arabia Saudita i riflettori del Gran Premio di Formula 1 significa assumersi tutte le responsabilità in materia di diritti umani che ne derivano», dice Ambet E. Yuson, segretario generale del sindacato internazionale dei lavoratori del legno e delle costruzioni (Bwi): «Se la Formula 1 prende sul serio le Convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro e i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni unite, allora dovrebbe esercitare concretamente i suoi obblighi di diligenza. Gli impegni di carattere generale, purtroppo, rischiano di restare lettera morta. Gli organizzatori dell’evento dovrebbero garantire un lavoro dignitoso a tutti coloro che sono impegnati nella catena di approvvigionamento per la costruzione delle infrastrutture.

E domandare ai Paesi ospitanti di includere il rispetto dei diritti dei lavoratori come disposizione vincolante. Sfortunatamente non molto di tutto ciò viene realizzato».
Negli ultimi tempi il sindacato internazionale ha rivolto grande attenzione al Qatar, dove dopo molti anni di campagne, l’autorità preposta alla realizzazione delle infrastrutture per la Coppa del Mondo (Supreme Committee for Delivery and Legacy) ha iniziato a collaborare con il Bwi attraverso un accordo che permette i controlli sui cantieri. «In cinque anni sono state effettuate 21 ispezioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, condotte da ispettori sindacali del Bwi di tutto il mondo», continua il segretario: «Abbiamo assistito a reali miglioramenti e progressi, formato rappresentanti dei lavoratori che ora possono parlare direttamente ed essere ascoltati. I casi di non conformità sono stati risolti. Ora la sfida è che questo progresso si radichi in tutto il Paese, attraverso l’attuazione delle riforme del lavoro».
Ma non in Arabia Saudita: nazione in cui per le organizzazioni sindacali è praticamente impossibile entrare. «Non possiamo essere presenti nel Paese per mobilitare i soccorsi all’interno delle comunità di migranti o per organizzare ispezioni per garantire che i diritti internazionali del lavoro e le disposizioni in materia di salute e sicurezza siano rispettati. O, ancora, per organizzare e formare gli operai», conclude il segretario: «È quasi impossibile stimare l’entità degli abusi sui lavoratori migranti, compreso il lavoro forzato o le vittime non registrate».
Anche sul cantiere del Gran Premio erano moltissimi i lavoratori stranieri. Capire quali siano state le reali condizioni di lavoro per la costruzione del circuito non è stato facile: accedere al cantiere era poco meno che impossibile. Mohammad (nome di fantasia), ha 25 anni ed è arrivato dal Pakistan per lavorare a Gedda nel settore delle costruzioni quattro mesi prima dell’apertura dei cantieri. Dice di essere arrivato in Arabia tramite passaparola, ovvero attraverso le molte agenzie che reclutano manodopera per realizzare grandi opere. Mohammad, così come i suoi colleghi, racconta di aver lavorato circa 12 ore al giorno con una paga che si aggira attorno ai 100 ryal (24 euro) giornalieri.

Degli spiragli però ci sono. L’Arabia Saudita ha avviato una serie (seppur molto blanda) di riforme del lavoro. Queste sembrano includere anche il sistema della “kafala”, pratica che regola il mondo del lavoro in molti Paesi arabi che è stata a più riprese nel mirino di sindacati e associazioni internazionali come una forma a tutti gli effetti di schiavismo. Nella “kafala” il lavoratore deve legarsi a uno “sponsor” che può essere un’agenzia di lavoro, un’impresa o direttamente un cittadino. Sulla carta lo sponsor ha il compito di garantire per il lavoratore, ma nella realtà conferisce un potere nei fatti assoluto al datore di lavoro. Come è noto, spesso al lavoratore viene requisito il passaporto e deve ottenere il permesso del suo sponsor per dare le dimissioni.
Per il sindacato internazionale degli edili ad oggi l’Arabia Saudita ha abolito solo in teoria la “kafala”, visto che molti elementi del sistema che rendono possibili gli abusi sono tuttora in piedi. Secondo quanto riportato da organizzazioni per i diritti umani e attivisti, l’Arabia Saudita ha più di 11 milioni di lavoratori migranti che vivono sotto il sistema della “kafala”, oltre alla maggiore popolazione migrante della regione, la quarta più grande al mondo. Tra questi si trovano anche circa 4 milioni di lavoratrici domestiche migranti. Il Regno è inoltre uno degli Stati che continua a richiedere a tutti i lavoratori migranti di ottenere un permesso di uscita per poter lasciare il Paese. Altre poi le pratiche discriminatorie, denunciate da più organizzazioni, che raccontano di arresti e campagne di vera e propria deportazione di migranti, accusati di aver violato i regolamenti e le leggi del Regno.
Negli ultimi anni l’Arabia Saudita ha fatto parlare di sé anche per le timide riforme sociali messe in campo, che hanno coinvolto principalmente le donne. Dal 2015 il principe ereditario Moḥammad bin Salmān ha avviato una stagione di progressiva liberalizzazione dei diritti femminili, accanto al progetto di “Vision 2030”, un piano che mira a trasformare la struttura dell’economia del Paese per diversificare le rendite e ridurre la dipendenza dal petrolio. Nel 2021 il settore degli idrocarburi ha rappresentato il 70 per cento delle esportazioni, nonostante il peso dell’oro nero nell’economia saudita sia in progressiva discesa da più di un decennio.

Capire se e come le riforme abbiano avuto un impatto reale nella vita delle saudite è tutt’altro che semplice. «È molto difficile stabilire quanto la situazione sia effettivamente migliorata. Comunicare con i sauditi è quasi impossibile, sappiamo però che le riforme sono arrivate con un’intensità diversa nelle città rispetto alle aree rurali», dice Hashem Hashem, ricercatore di Amnesty International per l’Arabia Saudita: «Nei centri più piccoli e isolati le donne non hanno beneficiato delle riforme e tuttora non hanno modo di viaggiare, educarsi e tanto meno guidare un’auto. A seconda di dove si vive la disparità è davvero forte».
Per alcune, però, le conquiste ci sono state. Per Fatima (nome di fantasia), 35 anni, la possibilità di guidare ha rivoluzionato la sua vita. «Questa concessione mi ha portato ad essere più indipendente, le cose per noi donne sono migliorate. Sento che riusciamo in qualche modo ad avere più potere, a conquistare più ruoli di leadership e che anche alcuni uomini sono più aperti ad avere donne al loro fianco», dice.
Altro nodo cruciale quello dei prigionieri tuttora nelle carceri saudite. «Non abbiamo un’idea esatta di quanti siano gli attivisti e le persone incarcerate per reati d’opinione, anche solo per aver pubblicato sui social media post non graditi al regime», prosegue il ricercatore di Amnesty: «La nostra organizzazione sta sostenendo al momento dieci attivisti, ma sono sicuramente molti di più. Recentemente sono avvenuti alcuni rilasci, ma anche per quei casi la nostra attenzione alla protezione resta altissima. Chi viene rilasciato resta sotto stretta osservazione: gli è impedito viaggiare e rilasciare interviste. Lo stesso vale per i loro parenti, a loro volta controllati. La paura per gli attivisti, dopo l’omicidio del giornalista Jamal Ahmad Khashoggi (assassinato e fatto a pezzi nell’ambasciata saudita in Turchia nel 2019, ndr) resta fortissima».
Per le organizzazioni dei diritti umani resta molto da fare in Arabia Saudita. «La strada verso la democrazia è davvero lunga. Si dovrebbe intervenire sulla libertà di espressione, sulla possibilità di formare partiti, associazioni, sindacati, sull’uguaglianza totale tra uomo e donna», conclude Hashem: «Per non parlare di come dovrebbe essere riorganizzato tutto il sistema, a partire dall’indipendenza del potere giudiziario, abolendo la tortura e la pena di morte, non solo per i minorenni». Obiettivo ancora lontano: lo scorso 13 marzo, infatti, in Arabia Saudita ha avuto luogo l’esecuzione capitale di 81 detenuti. Dall’inizio dell’anno, le condanne a morte eseguite sono già 92, in aumento rispetto al 2021.
Il programma di democratizzazione trova spazio anche nel documento che un gruppo di ventitré attivisti, accademici e intellettuali sauditi ha recentemente diffuso. Al suo interno si delinea «una visione popolare fondamentale per la riforma in Arabia Saudita, incentrata sui diritti umani e sulla giustizia sociale come parametri di riferimento più importanti».
Nel documento, in cui vengono riportati per punti i nodi più critici del sistema saudita, si legge: «Crediamo fermamente che l’Arabia Saudita non possa raggiungere i suoi obiettivi della Vision 2030, di una società vivace e di un’economia fiorente, senza la reale partecipazione della popolazione saudita».