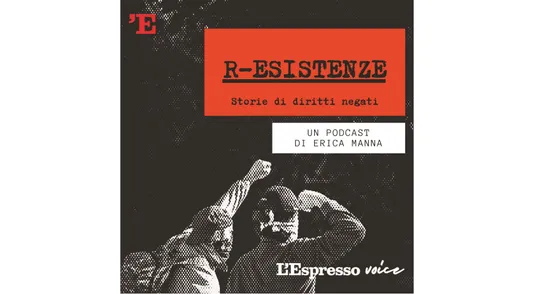Se ancora qualcuno aveva dei dubbi, ci ha pensato il presidente della Banca Mondiale, Ajay Banga, il 24 ottobre: «La crisi in Medio Oriente può avere effetti devastanti per l’economia mondiale». Il giorno prima il numero uno della Federal Reserve, Jay Powell, aveva avvertito: «Ci saranno contagi a catena sui mercati finanziari e un’eventuale escalation comprometterà la lotta all’inflazione». Insomma, non è solo una questione di prezzi petroliferi, che si impennano a ogni crisi in Medio Oriente (stavolta sono già saliti del 10%, il che equivale a un -0,15% di crescita mondiale secondo il Fmi, che già l’aveva abbassata al 2,9%). Così, gli uffici studi economici tracciano scenari per offrire – in questo spaventoso turbinio di violenza, bombe, morti – una bussola per orientarsi.
Gregorio De Felice, capo economista di Intesa Sanpaolo, invita a mantenere la mente fredda: «Per il momento non attribuiamo più del 5% delle possibilità allo scenario peggiore, quello di guerra totale con il coinvolgimento di una lunga serie di altri Paesi, petrolio a 150 dollari al barile (oggi è sugli 85) e inflazione che raddoppia nell’Eurozona rispetto all’attuale previsione del 2,7% nel 2024». A oggi, aggiunge De Felice, «lo scenario di base, con il 75% di probabilità, vede un conflitto solo fra Hamas e Israele, con un periodo breve di alta intensità e una coda lunga di persistenti tensioni. In questo caso è basso, se non nullo, l’impatto sulla zona euro, dove la crescita resta allo 0,8% nel 2024 e il petrolio si mantiene sui 90 dollari. Quanto allo scenario intermedio, con il 20% di possibilità e il coinvolgimento di Siria e Libano, l’inflazione si alzerebbe dal 2,7 al 3,5%, la crescita e il commercio mondiali subirebbero riflessi contenuti e il petrolio toccherebbe i 110 dollari».
Mai come in questo caso, a operazioni in corso, è difficile formulare ipotesi. «Un sicuro problema riguarda Israele, che ha dovuto fermare la sua economia con il richiamo al fronte di 400 mila operai, professionisti, artigiani», spiega Angelo Baglioni, economista della Cattolica. Già negli ultimi mesi con il clima interno arroventato dalle contestazioni a Benjamin Netanyahu, calcola il centro studi Valdai Club, gli investimenti stranieri erano scesi del 60% e il costo delle startup vendute a multinazionali, processo tipico dell’hi-tech, dell’80%. Ma l’incognita maggiore, malgrado le rassicurazioni della ministra del Tesoro, Janet Yellen, riguarda la capacità degli Usa di finanziare anche questo fronte di guerra.
Negli stessi giorni dell’attacco di Hamas, alle riunioni del Fmi a Marrakech è stata evocata per la prima volta la possibile insolvenza degli Stati Uniti nel rimborsare i buoni del Tesoro che diffondono in tutto il pianeta – Cina, Giappone e perfino Russia compresi – per finanziare il gigantesco budget, composto per il 15% da spese militari (900 miliardi su 6.500 di uscite complessive). Il deficit federale è triplicato in un anno fino a 1.700 miliardi (l’8% del Pil) e il debito è arrivato a 32 mila miliardi (il 130% del Pil, che a sua volta è di 22 mila miliardi): pesano i maxi-piani di incentivi per la ripresa post Covid, quasi tremila miliardi di dollari da qui a fine decennio, oltre alle operazioni in Ucraina, il cui costo sfiora ormai i 100 miliardi, la metà dei quali per forniture militari, nonché la preparazione al peggio per Taiwan. Alla crisi israeliana gli Usa hanno per ora dedicato 10 miliardi, destinati a lievitare se la situazione peggiora. Oggi, ricorda Brunello Rosa, docente alla London School of Economics, «l’America deve fronteggiare il declino di quello che Valéry Giscard d’Estaing definì “privilegio esorbitante”, la possibilità di finanziarsi all’infinito perché il dollaro è la moneta di riserva del mondo». Gli sforzi di “de-dollarizzazione”, con la creazione di zone economiche alternative e l’utilizzo di monete diverse dal dollaro nelle transazioni internazionali, sono in accelerazione. «Ci sono poi – aggiunge Rosa – le questioni interne come la faida fra repubblicani che ha provocato l’estromissione dello speaker della Camera, Kevin McCarthy, mentre è in corso la discussione sulla legge finanziaria da approvare entro il 17 novembre e non è fugato il pericolo dello shutdown con il blocco di qualsiasi spesa pubblica». Non a caso, ricorda Ben Laidler, economista della community finanziaria eToro, «il tasso sui Treasury Bond decennali ha superato il 5% per la prima volta in 17 anni». L’agenzia di rating Fitch ha tolto la tripla A agli Usa – mai successo nel Dopoguerra – con la motivazione che «c’è un continuo deterioramento negli standard di governance sulle questioni fiscali e debitorie».
C’è poi l’eterna incognita dell’Iran. Gli Stati Uniti stavano cercando di ricomporre i rapporti riavviando il sofferto accordo sulle forniture di componenti e combustibili per l’energia nucleare a Teheran. Una storia annosa che si è intersecata con le sanzioni attivate per le collusioni con i vari terrorismi mediorientali. Nel 2015 fu firmato l’accordo Jcpoa (Joint Comprehensive Plan of Action) per la riduzione del programma nucleare e un monitoraggio capillare in cambio della fine delle sanzioni. Senonché, nel 2018, Donald Trump riaprì le ostilità stracciando l’intesa e avallando l’uccisione nel 2020 del numero due del regime, Qasem Soleimani. Fast-forward al settembre 2023, quando Joe Bidenha proposto all’Iran di seppellire l’ascia di guerra e di tornare alle condizioni del Jcpoa, offrendo di nuovo la riduzione delle sanzioni e 6 miliardi di dollari di aiuti. Tutto dissolto la mattina dello scorso 7 ottobre.