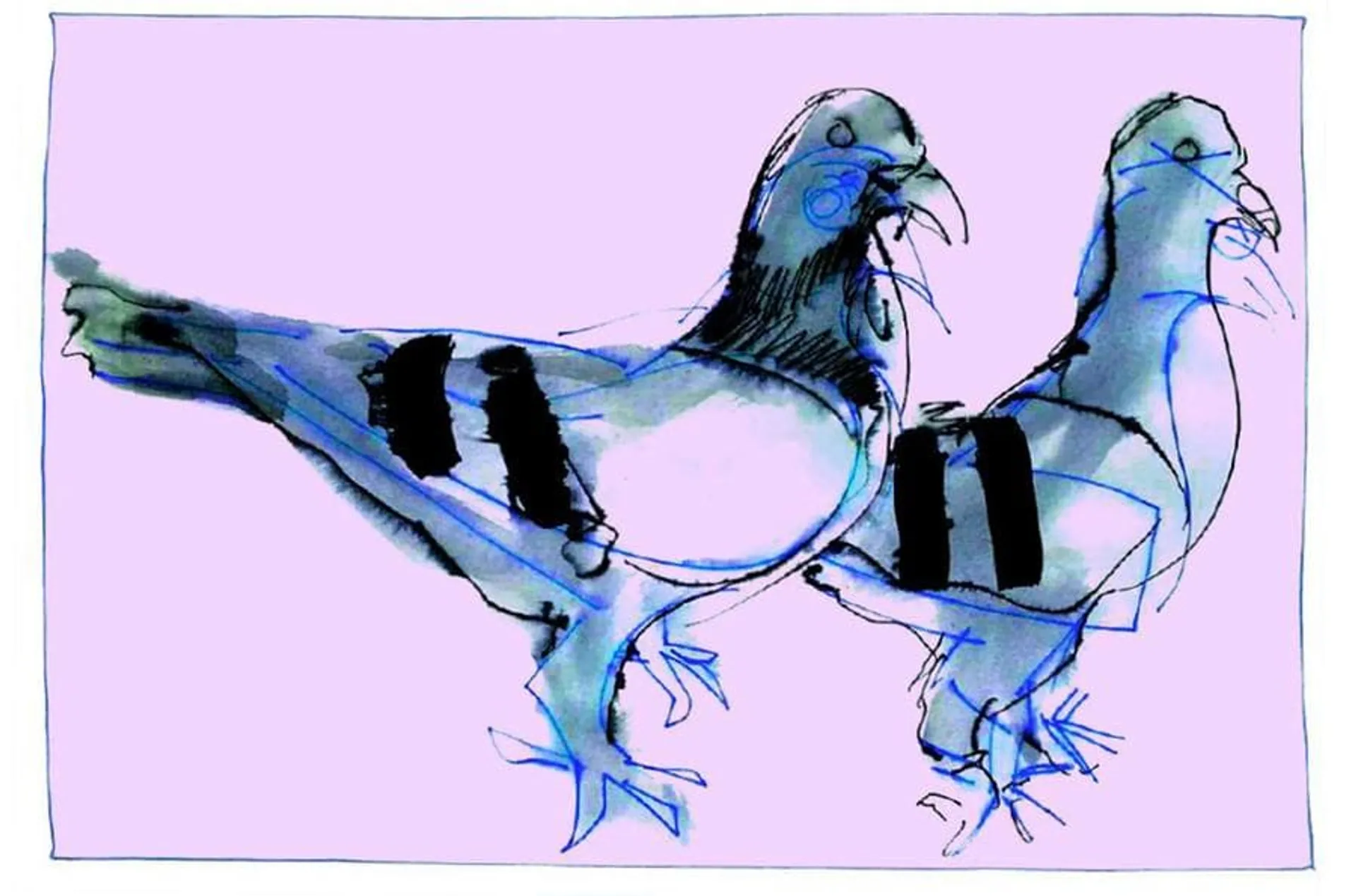Non era la prima volta che andavo a Donec’k: ai tempi della mia infanzia capitavo spesso da quelle parti, però con gli anni la situazione era cambiata talmente tanto che ora mi sembrava di avere accesso alla memoria di una vita precedente. Era come se facendo quel viaggio mi trovassi in contatto con qualcosa che era successo in un’epoca passata, talmente lontano nel tempo da diventare un ricordo irraggiungibile, labile e deprimente come quella canzone alla radio.
La prima volta che avevo visto quella città ero ancora un bambino. Frequentavo la sezione sportiva del poligono di tiro: sparavo con la pistola e con la carabina, e avevo vinto parecchie gare tanto che la mia scuola aveva deciso di iscrivermi a una competizione interregionale di tiro con il fucile. La sede più vicina del campionato si teneva proprio a Donec’k.

Dopo un’ulteriore selezione, rimanemmo solo in dieci. I giudici ci separarono in modo che non potessimo interferire l’uno con l’altro, e mentre mi spostavo verso la corsia che mi era stata assegnata notai fra i ragazzi in gara un ucraino con un fucile tedesco nuovo di zecca: era un Walther olimpico, un’arma che in quegli anni nemmeno i campioni potevano permettersi.
Ora eravamo in due.
Vidi il mio insegnante venirmi incontro, sollevarmi leggermente le cuffie da tiro e dirmi all’orecchio: «Stai calmo, continua come hai fatto finora e porteremo a casa il premio. Ti ricordo che milleduecento rubli sono una bella cifra». Parlava con un tono sereno e rilassato, come se avesse appena concluso una lunga seduta di meditazione yoga.
«Come si chiama?» chiesi con voce nervosa.
«Chi?» mi domandò lui senza capire.
«Il ragazzo con il Walther».
«Non pensare a lui, concentrati sul bersaglio. Lui non esiste, non esiste nient’altro a questo mondo. Ci sei solo tu, il tuo fucile e quel brutto pezzo di merda di un talebano che si nasconde fra le montagne. Ora voglio che tu lo centri: gli fai saltare le cervella e noi torneremo a casa vittoriosi». Il veterano di guerra come al solito non riuscì a trattenersi: doveva sempre insaporire i suoi discorsi con reminiscenze del passato che io, per quanto un po’ infastidito, cercavo di ignorare. «Comunque si chiama Konstantin, se ti può aiutare», aggiunse lui.

Facemmo un’altra sessione di tiro, alla fine della quale entrambi eravamo «rimasti nel centro». I giudici a quel punto ci ordinarono di eseguire una breve serie da tre colpi. Nessuno dei due mancò il bersaglio nemmeno una volta, eravamo di nuovo allo stesso punto. I giudici si riunirono, e alla fine dichiararono che stando al regolamento avremmo dovuto spartirci il premio. Il mio insegnante inizialmente non era molto d’accordo, ma poi quando mi consegnarono una busta con seicento rubli e dividemmo subito la metà dei soldi tra noi due, si calmò. Quella sera, il capo del club sportivo che ospitava la gara insistette per invitarci a cena, e io e Konstantin ci sedemmo vicini. Chiacchierammo di varie cose per tutta la serata, e scoprimmo di avere molte passioni in comune. A quell’età per me era incredibilmente eccitante rendermi conto che esisteva qualcuno che vedeva il mondo così come lo vedevo io, e che si comportava più o meno come me. Tra noi nacque una rispettosa simpatia che si trasformò ben presto in una sincera amicizia. I nostri insegnanti, dopo quella gara, strinsero un accordo di collaborazione tra i rispettivi club. Konstantin e il suo maestro presero a venire spesso nella nostra cittadina per allenarsi, e una volta al mese io e Gennadij Vladimirovi? andavamo a Donec’k per fare altrettanto. Passavo molto tempo con Konstantin, e un po’ alla volta gli feci vedere il nostro fiume, dove io e gli altri ragazzi ci riunivamo, e gli feci conoscere i miei amici del quartiere.
Una volta l’avevo portato con me sulla riva, in un boschetto dal quale si apriva una visuale perfetta su un campo di grano. C’erano sempre gruppi di piccioni che beccavano i chicchi caduti a terra, era un posto ideale per allenarsi con il fucile. Me l’aveva fatto conoscere il mio maestro diversi anni prima, commentando a modo suo: «Immagina che quei piccioni siano dei muj?hid?n, i nostri nemici. Sterminali più che puoi». Di solito con il rumore del primo colpo che rimbombava sul campo come un tuono i piccioni cominciavano ad agitarsi e volavano via, quindi tentavo di abbatterne il maggior numero possibile mentre erano in volo.
Era un esercizio che migliorava molto l’equilibrio tra la velocità e la precisione di tiro. Avevo detto a Konstantin di portare il suo fucile, credendo si sarebbe divertito, ma quando ci siamo messi in posizione e gli ho spiegato che dovevamo sparare ai piccioni, lui ci è rimasto male: «Scusa, ma questa mattanza non è divertente. Siamo degli sportivi, tiriamo con il fucile per bucare i bersagli di carta, non per ammazzare. Io non ho mai ucciso nessuna bestia, e non intendo iniziare ora. Neanche tu dovresti farlo. I piccioni non sono nostri nemici, e non hanno alcun legame con i muj?hid?n. Questi poveri volatili non sanno neanche che gli uomini hanno diviso il pianeta in tanti Paesi e si odiano tanto da ammazzarsi gli uni con gli altri. Queste creature sono libere da ogni pensiero malvagio, quello che fanno è volare tutto il giorno dove gli pare. Non starò qui con te ad abbatterli».

Fino alla sera della telefonata che ha dato inizio a tutto. Quando ho risposto dall’altro capo del telefono ho sentito una voce femminile che all’inizio non riconoscevo, tanto tremava: «Konstantin è partito per la sua città due mesi fa, e da allora non ho più le sue notizie». La sua fidanzata non riusciva a trattenere le lacrime. «Mi ha chiamato una sola volta, era molto freddo, lo sentivo lontano... Dovevamo sposarci tra tre mesi, abbiamo già fatto tutte le richieste necessarie per ottenere la sua cittadinanza italiana... Ma questo maledetto caos in Ucraina ha cancellato tutti i nostri piani».

Stepan ha rifiutato di portarmi lì. «Perdonami buon uomo, io ho una famiglia, non posso rimetterci la pelle, è troppo pericoloso…» Si è fatto il segno della croce e mi ha regalato l’icona della Madonna appesa allo specchietto della sua macchina: «Non la lasciare, ti salverà la vita».
Ho capito che dovevo agire da solo. Ho chiesto a uno dei guerriglieri di farmi vedere sulla mappa dove si trovavano le posizioni del gruppo in cui militava Konstantin, poi ho scarabocchiato la mappa sul mio taccuino appuntandomi i punti di riferimento più importanti. Masticando un pezzo di pane fatto in casa, che mi hanno gentilmente offerto i difensori della città, mi sono incamminato verso il fronte.
Le strade erano semivuote, ovunque c’erano evidenti segni di bombardamento compiuti dall’artiglieria pesante e dai sistemi missilistici. In molti palazzi mancavano i vetri alle finestre, i buchi neri che si aprivano nei muri di cemento indicavano i punti d’impatto. Però la città non dava per niente l’impressione di essere abbandonata o disperata. La gente aveva reagito, cercando di sistemare come poteva i danni causati da ogni bombardamento con un senso civile pieno di dignità.
Improvvisamente davanti a me, a circa duecento metri di distanza, hanno cominciato a cadere le bombe di un mortaio. Dovevo essere ormai molto vicino al fronte, perché il raggio d’azione di quell’arma non è molto ampio. Un uomo che portava in braccio la propria figlioletta mi ha indicato la direzione di una cantina: lì avremmo trovato riparo. Abbiamo corso entrambi, là sotto la gente attendeva in silenzio e con pazienza la fine del bombardamento. Mi hanno offerto dell’acqua, del cibo e mi hanno chiesto chi ero e dove stavo andando. Quando le esplosioni sono finite, è successa una cosa incredibile: la gente è uscita fuori armata di scope, secchi e rastrelli e ha cominciato a ripulire la zona, portando via i pezzi di un albero spezzato, sistemando i mattoni caduti dal muro di una casa e riempiendo le buche che si erano formate sulla strada. Mi hanno detto che durante i bombardamenti i mezzi di trasporto pubblico funzionano rigorosamente, i negozi non chiudono, restano aperti persino la biblioteca, il teatro e un cinema.
Verso sera ho raggiunto Konstantin. Era al riposo dopo un pattugliamento, stava bene. Era felice di vedermi, ma era esausto. Abbiamo preso un tè. Per parecchi minuti siamo rimasti in silenzio. Vicino alla sua sedia c’era un fucile di precisione, simile a quello che usavo io in guerra contro i terroristi islamici. Lui ha interrotto il silenzio, rispondendo alla domanda che non ho avuto tempo di fargli.
«Non tornerò in Italia, il mio posto è qui, lo capisco proprio ora... Questa terra, questa gente ha bisogno di me, dobbiamo fermare gli assassini dell’esercito ucraino».
«La tua fidanzata ti aspetta, le hai detto che la sposerai tra tre mesi», ho cercato di giocare la carta del matrimonio.
Lui non ha mostrato nessun cedimento a quel facile sentimentalismo. «Ero un’altra persona, avevo una madre, un padre, una sorella. Ora nessuno di loro c’è più, sono stati cancellati dalla terra durante un bombardamento dei golpisti. Adesso sono un altro individuo, e il matrimonio, così come la vita serena in Italia, non è tra le mie priorità. Sono diventato orfano ma allo stesso tempo ho scoperto di essere figlio di questa terra, di questa città, parente di questa gente. Non vado da nessuna parte, rimango qua finché non vinceremo questa guerra, finché non ci libereremo dagli oppressori».
Dopo gli anni di vita in Occidente i miei ricordi di guerra si erano offuscati, sembravano le ombre di un’altra vita, di un’esistenza passata. Le parole di Konstantin mi hanno però riportato in quella dimensione: «Quindi se quando eravamo ragazzi l’avessi pensata come la pensi ora, avresti sparato a quei piccioni?».
Lui ha abbassato gli occhi, ci ha pensato su un po’, poi ha detto con un sorriso nostalgico: «No, nemmeno ora avrei sparato a quei piccioni, fratello mio».
Ci siamo abbracciati, e quello è stato l’abbraccio più lungo della mia vita.
Sono ripartito da Donec’k quella stessa notte con l’icona della Madonna in tasca e il cuore pieno di sofferenza. Lasciavo una città che amavo, che ho visto colpita ma non distrutta, violata ma non privata della propria dignità.
Nicolai Lilin è nato nel 1980 a Bender,in Transnistria, proclamatasi indipendente dalla Repubblica Moldava nel 1990. Il suo romanzo d’esordio, “Educazione siberiana” (Einaudi), è stato un clamoroso successo. Scrittore e autore televisivo, il suo ultimo libro è “Favole fuorilegge” (Einaudi).