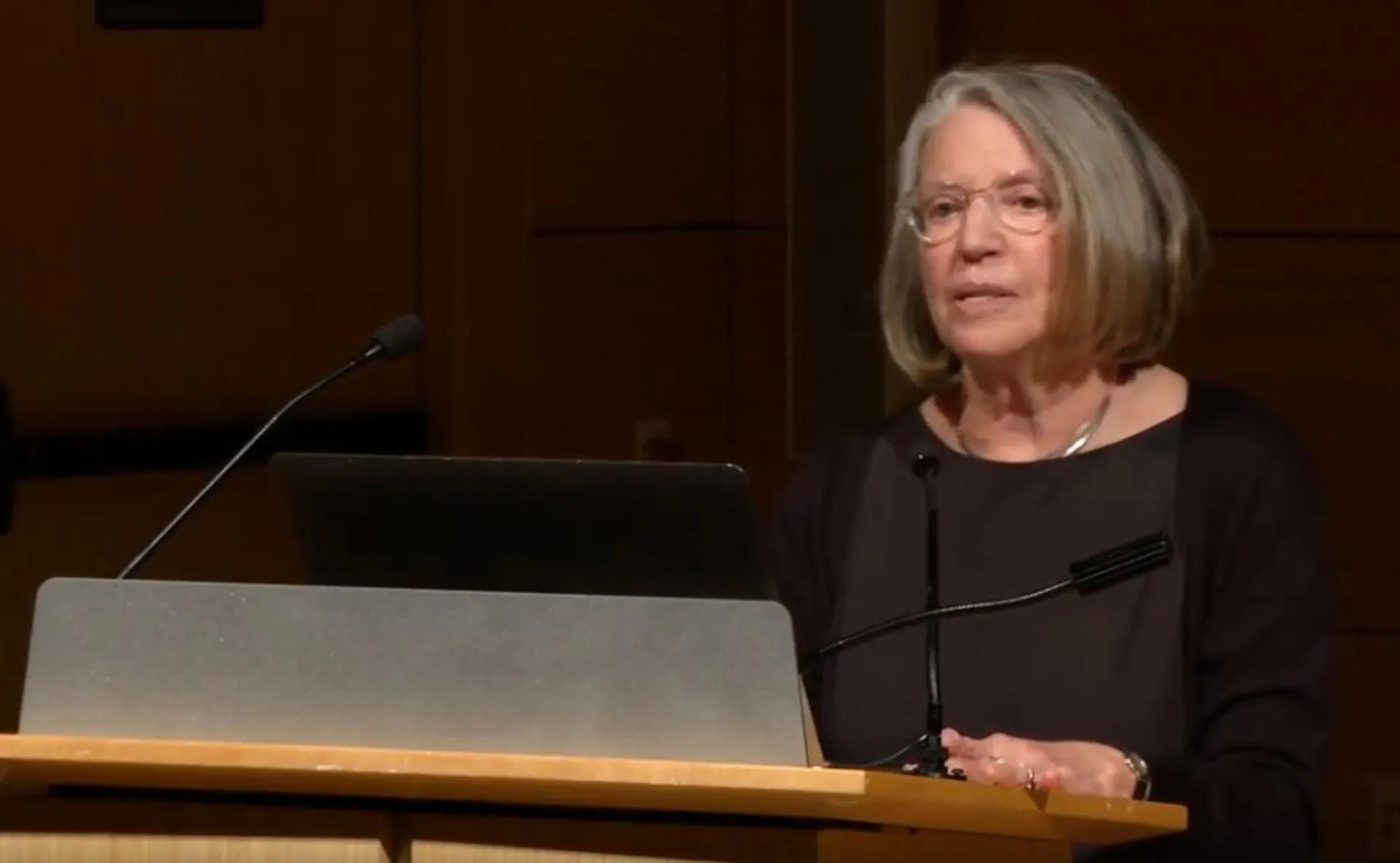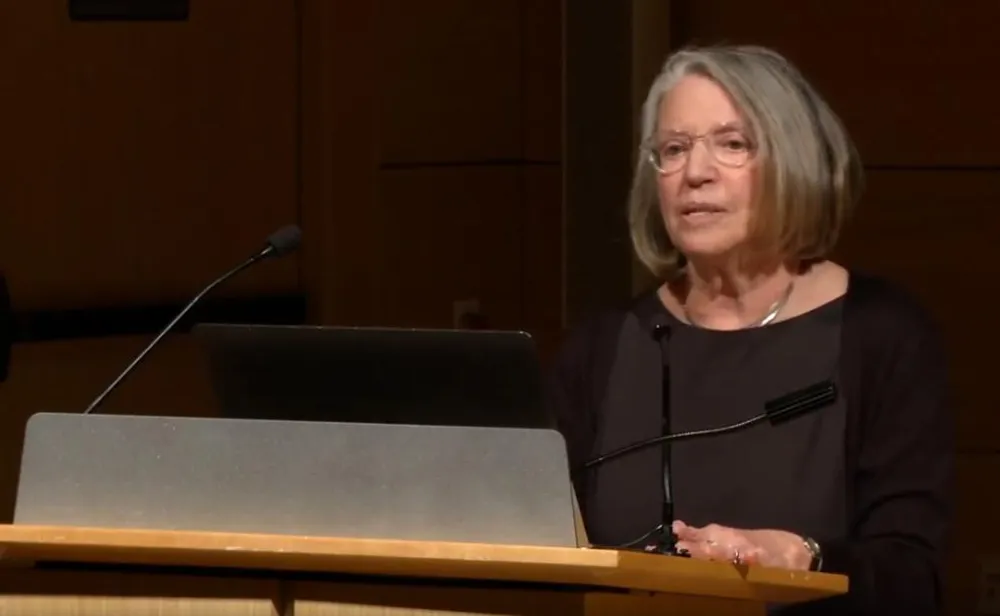
In uno dei suoi ultimi libri, “Il vecchio muore e il nuovo non può nascere. Dal neoliberismo progressista a Trump e oltre” (Ombre corte 2019), lei adotta la categoria gramsciana di “interregnum” per analizzare la crisi attuale, che definisce multipla. Ci spiega meglio cosa intende?
«C’è un ambito della crisi che è economico, uno finanziario, uno ecologico, poi una dimensione politica e sociale. Si tratta dunque di una crisi multipla. Ogni settore è in crisi e si interseca con gli altri convergendo in un sentimento diffuso: così non si può andare avanti. È la rottura del senso egemonico. Gramsci però ci insegna che una crisi non diventa storicamente generativa fino a quando non viene vissuta come tale e si decide di agire per cambiare l’ordine sociale. Per ora le reazioni vengono perlopiù da destra, dai movimenti populisti reazionari, ma non è troppo tardi per una risposta progressista. A condizione che si riconosca che la crisi del capitalismo finanziarizzato è anche la crisi sistemica di un particolare ordine sociale. La finanziarizzazione dell’economia ha cambiato la relazione tra il mercato e lo Stato, ha esasperato la crisi climatica e distrugge l’energia necessaria alla vita famigliare, alla solidarietà sociale, alla produzione e riproduzione dei legami sociali».
Questo è un punto centrale per lei: nelle società capitalistiche ci sarebbe una tendenza inevitabile alla crisi del lavoro di cura, a dissipare la capacità di forgiare e mantenere i legami sociali. Cosa le fa credere che “il capitalismo è come una tigre che si morde la coda”?
«Se smettiamo di pensare al capitalismo solo come a una forma di economia e teniamo conto della più ampia società che lo rende possibile, ci accorgiamo che le relazioni di solidarietà e affetto, i legami personali, anche sessuali, sono condizioni preliminari: i lavoratori vanno “creati”, chi produce valore per il capitale va protetto e curato. Il capitalismo ha diviso lo spazio della produzione economica - fabbriche o uffici - dallo spazio intimo dove si svolge il lavoro di cura e di riproduzione sociale. Si affida a quegli input ma ne disconosce il valore. Da qui la crisi della riproduzione sociale, che oggi ricorda l’inizio del capitalismo industriale. La risposta allora fu il capitalismo socialdemocratico, che tassava il capitale e affidava allo Stato le politiche per un miglior equilibrio tra produzione e riproduzione, così da evitare che il capitale si mangiasse la coda. Il capitalismo finanziarizzato ha cancellato molte di quelle politiche. E si morde la coda».
La divisione tra produzione economica e riproduzione sociale ha funzionato anche come base istituzionale per la subordinazione delle donne...
«La produzione è maschile, la riproduzione femminile. Così racconta una certa interpretazione culturale e ideologica. La realtà è diversa, ma rimane il fatto che quella divisione è stata cruciale nella disuguaglianza di genere, perché ha assicurato la dominazione maschile e la subordinazione femminile nella società capitalistica».
In “Femminismo per il 99%. Un manifesto”, scritto con Cinzia Arruzza e Tithi Bhattacharya (Laterza 2019), sostenete che l’obiettivo politico del libro è una “operazione salvataggio” del femminismo liberale, divenuto un ostacolo all’emancipazione e un alibi per il neoliberismo. Perché lo rigettate?
«Il femminismo liberale è una sorta di partner progressista di Wall Street, della finanza, del capitalismo digitale. Si limita a voler condurre le donne nelle posizioni di potere. È rappresentato in modo esemplare da Hillary Clinton o Christine Lagarde. Pensa all’1 per cento, ma non fa nulla per il 99 per cento delle donne, sempre più schiacciate dalla crisi. Il femminismo del 99 per cento è invece l’ala femminista del populismo progressista. Se vogliamo creare un blocco controegemonico, un’alternativa alla falsa scelta tra populismo reazionario e neoliberismo progressista, occorre un femminismo diverso. E una rinascita delle campagne sindacali per tenere insieme lavoratori organizzati e non organizzati, inclusi i lavoratori domestici, quanti svolgono lavori di cura».
Secondo la sua lettura, le condizioni per l’affermazione del populismo di destra sono state poste da quello che definisce come “neoliberismo progressista”. Di cosa si tratta?
«È la combinazione tra politiche economiche regressive e predatorie e politiche del riconoscimento dei diritti delle minoranze in chiave liberal-meritocratica. In apparenza progressiste, servono in realtà da alibi all’economia estrattiva. Negli Stati Uniti il blocco egemonico del neoliberismo progressista si è consolidato sotto la presidenza di Bill Clinton; in Europa, sotto i governi socialdemocratici. Clinton voleva un nuovo Partito Democratico, che archiviasse il “New Deal” di Roosevelt e le politiche keynesiane, appoggiandosi non più al settore manifatturiero, ma all’economia digitale, a Wall Street, alla Silicon Valley, etc. Settori con un ethos cosmopolita e globale, considerati l’avanguardia del capitalismo, che andavano collegati con i movimenti sociali con un ethos simile, dai gruppi femministi agli anti-razzisti, dagli ambientalisti ai gruppi LGBT. L’alleanza ha avuto successo, ma sul versante dell’economia politica ha coinciso con liberalizzazione, finanziarizzazione, deindustrializzazione del “Nord globale” e capitali liberi».
I risultati sono stati drammatici. Per la sinistra e per la classe operaia...
«Dopo circa 30 anni di egemonia di questo blocco, la classe operaia tradizionale è stata duramente colpita, i sindacati distrutti o indeboliti, i salari ridotti, l’impiego reso precario. Anziché il posto fisso c’è stata una straordinaria espansione del debito da consumo, debito da carta di credito, debito studentesco, debito del mutuo sulle case. Il vecchio New Deal si basava sull’assunto che i lavoratori dell’economia industriale avrebbero potuto godere di una vita decente, mandare i propri figli all’università, assicurargli una vita migliore. Oggi queste promesse sono in frantumi. E la classe lavoratrice è in rivolta».
Colonizzata dal neoliberismo, la sinistra avrebbe rinunciato all’egalitarismo e all’idea di abolire o modificare la gerarchia sociale in favore della meritocrazia, che avalla lo status quo. Ci spiega meglio?
«Nell’era socialdemocratica, l’idea di uguaglianza includeva l’idea di un lavoro sicuro, della piena occupazione, dell’essere a pieno titolo membri della società. Oggi non c’è più l’idea dell’uguaglianza come piena inclusione e partecipazione, ma l’idea che i membri delle minoranze possano godere, a titolo individuale, dell’opportunità di ottenere posizioni ai vertici della gerarchia sociale, che rimane immutata, non va abolita. È una parità senza uguaglianza. I movimenti nati all’interno della “New Left” americana sono gravitati sempre più verso il neoliberismo, adottandone la postura meritocratica. Dagli anni Settanta non c’è stato alcun ampio movimento di sinistra nella politica americana fino al 2011, grazie a Occupy Wall Street, e poi nel 2016 con la campagna elettorale di Bernie Sanders, che ha proposto un’alternativa populista progressista».
Lei invoca da tempo un populismo di sinistra, perché ritiene che combattere il populismo di destra da posizioni liberali equivalga alla sconfitta. Ma spesso ha anche auspicato la nascita di movimenti progressisti transnazionali. Non c’è contraddizione tra le due cose? Anche se di sinistra, il populismo non tende al nazionalismo esclusivo?
«Il problema c’è. Ma populismi di destra e populismi di sinistra vanno distinti. Per il populismo di destra la società è composta da tre parti. Una classe di élite, il vero potere che monopolizza la ricchezza, poi la sezione centrale della società composta da “veri americani” o “veri italiani”, e una sottoclasse che sottrae risorse alla “vera gente”: gli immigrati, i musulmani, i messicani, etc. Il populismo di destra difende la gente di mezzo, schiacciata tra l’alto e il basso. Per il populismo di sinistra ci sono solo due parti, l’élite che monopolizza ricchezza e potere e poi tutti gli altri: il 99 per cento contro l’1 per cento. La seconda differenza è che il populismo di destra ritrae i nemici della “vera gente” in termini concreti e identitari, spesso nazionalistici. Nel mezzo c’è il vero italiano, in cima ci sono gli ebrei, i bolscevichi o chi per loro, sotto gli africani, gli arabi, i musulmani. Il populismo di sinistra invece li raffigura in termini funzionali, a partire dal ruolo ricoperto, in chiave strutturale. L’1 per cento non è identitario, è numerico. Una differenza importante. Ma rimane il fatto che i movimenti populisti di sinistra non hanno ancora elaborato una posizione chiara e netta sull’immigrazione. Spero lo facciano presto».
L’altra cosa da fare - così suggerite in “Femminismo per il 99%” - è prendere lezioni dal movimento femminista, che avrebbe creato una nuova forma di politica, ridefinendo i concetti di “lavoro”, “classe” e “lotta di classe”. In che modo il femminismo può contribuire alla mappa politica del “nuovo blocco controegemonico”?
«Gli scioperi femministi dell’8 marzo sono centrali nelle proteste contro l’austerity. Le manifestanti e i manifestanti chiedono investimenti nella riproduzione sociale, per la salute, la casa, la sicurezza ambientale, la scuola pubblica. Chiedono che venga riconosciuto il valore del lavoro di riproduzione sociale, socialmente necessario ma non salariato. La conseguenza è cruciale: se il lavoro non è solo quello svolto in una fabbrica e salariato, il concetto di classe si allarga: fa parte della classe lavoratrice chiunque svolga un lavoro socialmente necessario. La sinistra dovrebbe ripartire da qui. Dal punto di vista generale, la strategia è conquistare alla nuova alleanza del populismo di sinistra le femministe e gli attivisti gay, gli antirazzisti e quanti lottano contro il cambiamento climatico. E rompere l’alleanza populista reazionaria conquistando quella parte di classe operaia tradizionale gravitata a destra, riconducendola a sinistra. Molti vengono proprio da qui. Ma sono stati traditi dal neoliberismo progressista».