Non così a Kiev e dintorni, troppo prossimi alla Russia, dunque al fuoco di uno sconvolgimento ardente, troppo delicati e da maneggiare con cura. Tanto da collocarli in un limbo lungo una generazione, né di qua (l’Europa) né di là (Mosca). E, per proseguire nella similitudine, sarà il caso di sottolineare come i Balcani adriatici erano il fronte sud dell’Impero austro-ungarico e una fetta dell’attuale Ucraina quello nord: le radici lunghe della storia talvolta si prendono le loro rivincite.
I paragoni sono però tutti zoppi e non è detto (non ancora) che il Continente debba assistere a un altro precipizio jugoslavo. Nonostante a Kharkiv, Donetsk, Odessa e Sebastopoli (in Crimea, dove hanno già fatto la loro minacciosa comparsa pure dei blindati russi), giovanotti e meno giovani, russofoni o russi tout-court, stiano creando milizie armate per opporsi a Maidan, la Piazza della capitale, che con la sua resistenza e il suo sacrificio ha provocato il rovescio del regime prima clamorosamente corrotto e al suo crepuscolo anche sanguinario di Viktor Janukovich.
Il presidente sostenuto e poi mollato da Vladimir Putin non c’è più, resta tuttavia quel 48 per cento di persone che lo aveva scelto non necessariamente perché lo amasse ma perché era garanzia di difesa di interessi ed espressione di quel blocco sociale russo maggioritario ad est e a sud: una fetta dell’anima al minimo divisa in due del Paese. L’altra è ucraina, senza considerare il lembo polacco persistente almeno in Galizia: una pluralità conseguenza del passato di una nazione che ha conosciuto solo brevi intervalli di indipendenza.
Sospinta verso occidente dall’onda dei giovani liberali di Maidan, i più cosmopoliti e sognatori; trattenuta dai nazionalisti estremi di Settore Destra e delle altre formazioni che pure nella stessa piazza hanno alzato le insegne di Stepan Bandera, personaggio controverso che si contaminò con Hilter, ma che sono stati decisivi nel momento in cui i fucili hanno sostituito gli slogan; tirata a oriente da chi vede nel nuovo zar l’unico fidato riferimento: così strattonata l’Ucraina rischia di dilaniarsi.
La parola brandita come una minaccia è secessione. Scenario che tutti dicono di voler scongiurare almeno fino a quando la realtà sul terreno non sarà andata oltre. I morti sono sempre un buon carburante per le ipotesi divisorie. C’è ancora un po’ di tempo, non molto. Dipende dagli attori protagonisti che non sono ucraini, come vuole tradizione dello sventurato Paese.
Ha avuto vent’anni, l’Ucraina, per dirsi nazione. Ha sprecato fin qui l’occasione, consegnandosi al potere clientelare dei pochi oligarchi che tutto hanno depredato e deciso, compresi presidenti e primi ministri, in un’orgia infinita di corruzione e malaffare derubricata troppo a lungo come “normalità”.
[[ge:rep-locali:espresso:285485180]]
La Mezhyhirya, la villa incredibile di Janukovich a 20 chilometri da Kiev, col galeone, lo zoo e i mosaici simil-bizantini, è solo il folclore della tracotanza. Assai più opulenza si troverebbe se si potesse frugare nei conti di Rinat Akhmetov, il magnate suo grande sponsor, e riparato, pare, con la moglie del presidente, nella sua casa di Londra in attesa di tempi migliori. O in quello di Dmytro Firtash, fresco acquirente della Pravex Bank che Banca Intesa controllava.
Gente che arriva dal passato sovietico e ha approfittato di tutte le collusioni. Mentre il Paese si spegneva, precipitava al 152° posto su 183 per corruzione (classifica di Transparency International) e al 134° su 142 per indipendenza della magistratura, cinque milioni di abitanti su 50, il 10 per cento del totale, emigravano perché ridotti alla fame (ne abbiamo cognizione anche noi con le badanti dei nostri pensionati), il Pil rimaneva stabile mentre quello dei confinanti triplicava e gli stipendi arrancavano attorno ai 300 euro.
Non si vede all’orizzonte un soldato della Maidan che abbia nello zaino il bastone da Maresciallo, un leader capace di affrontare la prova tremenda dello sfascio economico con 35 miliardi da trovare subito pena il dichiarare la bancarotta. Né può esserlo la tanto reclamizzata Yulia Timoshenko, popolare all’estero, assai meno in patria, nonostante l’empatia umana per il carcere duro subìto e la sedia a rotelle su cui è ridotta. Anche lei partecipò alla grande abbuffata, «signora del gas» e delle conseguenti mazzette, si è già giocata la sua chance. Tanto che nelle cancellerie si sussurra, nel linguaggio della diplomazia, che la donna con la treccina è «parte del problema e non parte della soluzione».
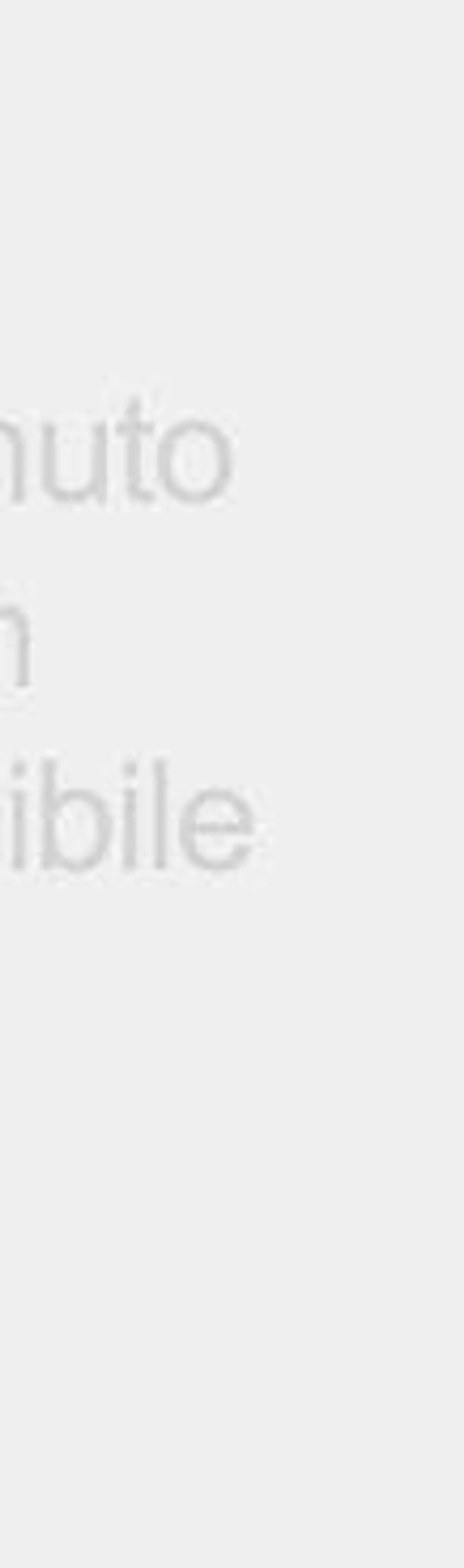
A meno che esista, ma va scoperta, una “Yulia 2.0”, mondata dal carcere, sinceramente pentita e rivolta, negli anni della piena maturità, al bene comune. Maidan non la ama, le ha tributato sorrisi stiracchiati, e la accomuna al suo nemico Janukovich, legati a filo doppio per la stessa brama di potere, simul stabunt simul cadent. Si presenterà, la Timoshenko, alle presidenziali del 25 maggio, stesso giorno in cui altrove si voterà per quell’Europa che sta dietro l’angolo, che difficilmente si riuscirà ad afferrare almeno nei tempi stretti.
Ma quale che sia il futuro Capo dello Stato e il futuro premier (dopo una revisione Costituzionale che ridarà centralità al Parlamento) l’Ucraina sarà per forza, nel futuro prevedibile, a sovranità limitata, con una parte delegata a chi sarà più generoso nell’allargare i cordoni della borsa. Il Fondo monetario internazionale ha già detto di non poterne mettere a sufficienza per coprire il fabbisogno urgente.
L’Europa, troppo a lungo dimentica di questa sua appendice, si fa avanti soprattutto con Angela Merkel e i polacchi, vicini assai coinvolti. Dall’altra parte, la Russia di Putin che ferma gli aiuti perché vede minacciati «i nostri interessi e quelli dei nostri cittadini» e minaccia di chiudere i rubinetti del gas, o quantomeno di alzare quel prezzo di favore che aveva sempre riconosciuto alla «Repubblica sorella» perché non morisse di freddo. Eppure saranno costrette a parlarsi, l’Europa e la Russia, sarebbe troppo pericoloso non avere, sulla faglia di frattura di due mondi, uno Stato cuscinetto, modello Finlandia, che assorba le potenziali tensioni causate da mercati diversi e da una diversa alleanza militare.
È folle pensare che, a causa di Maidan, lo zar possa mollare l’Ucraina. Non solo per la fine del suo sogno di Unione eurasiatica che la contempla ed è pedina fondamentale per la ricostruzione di un impero (almeno un impero moderno), non solo perché nella Crimea regalata a Kiev dall’ucraino Kruscev (durante una notte di sbronza vuole la leggenda) ha la sua flotta, ma anche perché 1.200 anni fa fu su quella terra che si formò l’embrione del regno russo. Dunque con Putin bisognerà scendere a patti. O rassegnarsi a una secessione pericolosa e dagli effetti, compresi quelli estremi, imprevedibili. Anche perché, tra i due litiganti, ne fa capolino un terzo. L’avete indovinato? È sempre lo stesso, si chiama Cina.
Ha il pregio, agli occhi degli ucraini, di non voler incidere sulle dinamiche dei governi. Gli basta fare business. L’Ucraina, si sa, è un granaio. Una vasta pianura con terra tra le più fertili del pianeta. Una corporation di Pechino ha già acquistato centomila ettari che diventeranno tre milioni a breve: il 5 per cento del territorio. Si chiama land grabbing e non si fa solo in Africa, anche nell’Europa che, per disperazione, si mette in vendita.



