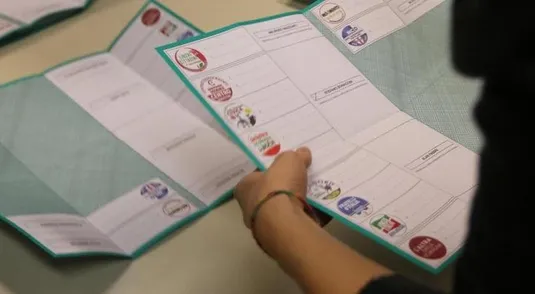Qual è stata la marcia in più di Matteo Renzi negli anni della scalata («Nel 2011 mi accorsi che l’Italia era scalabile», lo ha detto la sera del 24 ottobre alla Leopolda, un mese fa, sembra passato un secolo)?
La potenza comunicativa, certo. Il progetto della rottamazione, presentarsi come la risposta migliore a un’enorme richiesta di cambiamento della classe dirigente che montava dal Paese. Una capacità di manovra, tattica e strategica, da animale politico di razza, più un pizzico di fortuna. se il Pd di Bersani non fosse franato l’ultima settimana prima del voto 2013 a questo punto farebbe per la seconda volta il sindaco di Firenze e non il premier italiano tra i grandi della Terra.
Più di ogni altra cosa, però, la marcia in più di Renzi è stata tra il 2011 e il 2014 il senso della realtà. Essere, e non solo apparire, un leader con i piedi ben piantati sul terreno, sul concreto delle cose, sulla materialità dei problemi. È questo che gli ha permesso, per esempio, di dare voce a una generazione sparita, cancellata dalle carte geografiche della politica e dell’agenda economica. O ai sindaci dei piccoli comuni, i primi ad appoggiarlo senza riserve.
Il sindaco di San Giovanni Lupatoto Federico Vantini, che introdusse la convention di Verona in cui Renzi lanciò la sua corsa alle primarie del centrosinistra nel 2012. Oppure il sindaco di Castenaso Stefano Sermenghi, centro alle porte di Bologna in cui la sorella del premier Benedetta è residente e assessore.
Nel 2012 era l’unico sindaco della provincia di Bologna ad appoggiare Renzi, osteggiato anche dall’allora segretario regionale del Pd Stefano Bonaccini, oggi presidente dell’Emilia Romagna più che dimezzato, trimezzato, dato che è stato votato da meno della metà del 37 per cento degli elettori. A Castenaso alle europee il Pd prese 5323 voti, il 61,2 per cento, ieri 2333, il 49,6. E la coalizione di Bonaccini appena 2794 voti, comunque sopra la media regionale, il 56,3.
Vittoria netta, bravissimi @sbonaccini e @Oliverio_MarioG Massimo rispetto per chi vuole chiacchierare. Noi nel frattempo cambiamo l'Italia
— Matteo Renzi (@matteorenzi) 24 Novembre 2014Il senso della realtà ha fatto vincere Renzi negli anni del Bunga Bunga, dei giaguari da smacchiare, delle polemiche autolesioniste contro gli uomini soli al comando, dei tecnici senza cuore e senza consenso. Sembrava, quel sindaco di Firenze che viaggiava da solo in treno, una persona normale che parlava il linguaggio della verità e della quotidianità. È il senso della realtà che gli ha permesso di mandare a casa senza troppi problemi un premier come Enrico Letta, considerato troppo legato ai tempi del Palazzo, non abbastanza in sintonia con le urgenze del Paese.
Male affluenza, bene risultati: 2-0 netto. 4 regioni su 4 strappate alla dx in 9 mesi. Lega asfalta forza Italia e Grillo. Pd sopra il 40%.
— Matteo Renzi (@matteorenzi) 24 Novembre 2014Per questo mi ha stupito la reazione di Renzi di stanotte e di questa mattina ai risultati elettorali dell’Emilia e della Calabria. Ieri: «Male affluenza, bene risultati: 2-0 netto. 4 regioni su 4 strappate alla dx in 9 mesi. Lega asfalta Forza Italia e Grillo. Pd sopra il 40%». Oggi: «Vittoria netta, bravissimi Bonaccini e Oliverio. Massimo rispetto per chi vuole chiacchierare. Noi nel frattempo cambiamo l’Italia». Parole che colpiscono. E che svelano, quasi per lapsus, un progetto futuro. Un Paese in cui c’è una sola offerta di governo: il Pd di Renzi.
Un polo di destra egemonizzato dalla Lega di Salvini che, parola del premier, «asfalta» Berlusconi, il contraente del Patto del Nazareno, ma che non avrà mai i numeri per competere con il Pd per la guida del governo. E una sinistra messa con le spalle al muro: votare il Pd o restare a casa. E se resta a casa, peggio per lei. Resta Grillo, ma lui si è messo fuori gioco da solo e 5 Stelle sta tornando a quote dimezzate rispetto ai sondaggi nazionali. A Parma, governata da Pizzarotti, M5S si ferma al 13 per cento, la Lega è risorta e sale al 22.
Tutto questo c’entra poco con il disegno iniziale di Renzi di far diventare il sistema politico italiano europeo e competitivo. E soprattutto fa a pugni con la realtà. Perché il premier può litigare con chi vuole: la Cgil, i giornali, i gufi, i professoroni, Landini, ma non con la realtà. La realtà italiana di questo autunno rivela un Paese diviso, frammentato, arrabbiato, incattivito. Di sterminate periferie urbane in cui non arriva la politica, e neppure il neo-ottimismo del premier, le nuvolette celesti, il digitale o la competizione internazionale. Di fabbriche che chiudono o rischiano di chiudere, da Terni a Livorno, intere città in dismissione. Di proteste e di rivolte e di occupazione di strade in ogni dove. Di alluvioni e di pezzi di territorio lacerati, da ricucire.
Non si liquida tutto questo dividendo il mondo tra chi lavora (Renzi e il suo governo) e chi ha voglia soltanto di chiacchierare. Non è giusto. Di più: non è realistico. Si può anche decidere che non è un problema, che bastano i votanti per decidere chi vince, che in tutto l’Occidente funziona così eccetera. Liquidare il tutto con un piagnisteo.
Possono farlo i renziani di complemento, i cinguettatori per dovere di contratto o di conformismo, a loro volta espressione di un gruppo dirigente più virtuale che reale, miracolato dal carisma del Capo. Oppure le minoranze del Pd, che vivono in un mondo a parte perché quel che è accaduto in Emilia li riguarda da vicino, parla della loro incapacità di rinnovarsi, della Ditta che si sgretola nel punto più delicato, il senso di appartenenza di un elettorato fedele che non era mai venuto meno.
Tutti possono esultare, con insipienza e arroganza, meno il premier Renzi.
È lui a ripetere che gli elettori hanno sempre il telecomando in mano e che sono sempre pronti a fare zapping. Ma allora c’è ben poco di cui rallegrarsi se in Emilia due terzi degli elettori hanno preferito tenere il televisore spento piuttosto che assistere a uno spettacolo di attori mediocri. Chi l’avrebbe mai detto che proprio l’insaziabile Renzi avrebbe finito per accontentarsi.