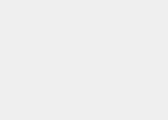Per capire quanto sia difficile contrastare la minaccia del terrorismo jihadista, rilanciata e amplificata dalle guerre religiose in corso dal Nord Africa al Medio Oriente, si può partire dai più famosi precedenti storici. L’attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono, con il suo bilancio di quasi tremila morti e le sue conseguenze epocali, è stato eseguito da diciannove dirottatori-kamikaze che non avevano neppure un’arma da fuoco.
Le 191 vittime della mattanza sui treni di Madrid sono state dilaniate da quattro valigie di esplosivo, che i terroristi ultra-integralisti salafiti avevano comprato (da un ladro spagnolo) appena dodici giorni prima. Mentre per la strage nel metrò di Londra, come a Casablanca e in molti altri eccidi, gli attentatori si sono fabbricati le bombe da soli, assemblando in casa prodotti chimici di uso comune.
Di qui il problema che angoscia le polizie di tutto l’occidente: come fermare un nuovo terrorismo capace di compiere immani carneficine non solo in totale segretezza, ma riducendo al minimo anche i reati preparatori?
Tra i poliziotti e carabinieri che lavorano nell’antiterrorismo, i più esperti studiano da anni come affrontare questa drammatica sfida investigativa. Molti hanno imparato a riconoscere generazioni di capi e gregari delle tante organizzazioni islamiste, intercettare i loro messaggi in codice, decifrare i segnali nascosti nelle lingue e dialetti locali, collegare e valorizzare i minimi indizi. Ma la risposta definitiva dello Stato spetta alla giustizia italiana nel suo insieme. Che non sempre e non ovunque sembra essersi dimostrata all’altezza del compito di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze collettive di sicurezza e i sacrosanti diritti di difesa. Soprattutto nei processi d’appello, molte inchieste importanti sono state azzerate da assoluzioni e scarcerazioni quantomeno discutibili.
Sentenze molto garantiste, forse troppo. Che hanno rimesso in libertà personaggi che oggi appaiono impressionanti, almeno col senno di poi. “L’Espresso” ha ricostruito una dozzina di casi di jihadisti conclamati che la giustizia italiana non ha potuto o saputo fermare: arrestati per il nuovo reato di terrorismo internazionale, sono stati assolti, ma si sono prontamente riciclati come reclutatori, combattenti, attentatori suicidi e perfino comandanti militari o feroci ideologi delle guerre sante che stanno insanguinando interi Paesi come Libia, Siria o Iraq. Conflitti che attraggono migliaia di volontari anche dall’occidente, che si arruolano nelle milizie più crudeli, spesso collegate a reti integraliste ramificate da anni in mezza Europa, Italia compresa.

Quando i loro nomi entrano nella banca dati delle polizie europee, però, a Parigi e Bruxelles scatta l’allarme: Ayachi è schedato come “l’emiro” di una pericosa organizzazione pan-islamista, con base in Belgio, che indottrina giovani cresciuti in Europa, per mandarli a morire da martiri combattendo (allora) in Iraq e Afghanistan. Gendron è il suo braccio destro e nel suo bagaglio la Digos trova dvd e pen-drive con un archivio inquietante: documenti di Al Qaeda tradotti integralmente, decine di nomi e foto di integralisti partiti per la guerra santa, scene cruente di addestramento alla battaglia, perfino testamenti firmati da ventenni convinti a immolarsi in nome di Dio.
Le autorità belghe e francesi trasmettono alla giustizia italiana interrogatori e intercettazioni che indicano Ayachi come il leader indiscusso di una rete terroristica transnazionale attiva fin dagli anni Novanta, con spaventose connessioni. L’emiro fermato a Bari, per dirne una, ha celebrato personalmente le prime nozze di una delle più inquietanti figure femminili del jihad internazionale, Malika El Aroud, marocchina trapiantata in Belgio, vedova di due martiri. Il suo primo marito era il kamikaze belga-tunisino che si è fatto esplodere in Afghanistan il 9 settembre 2001, riuscendo a uccidere il leggendario comandante anti-taliban Ahmed Shah Massud e a decapitare così il fronte contro Al Qaeda due giorni prima dell’attacco alle Torri Gemelle; il secondo, arrestato più volte tra Svizzera e Belgio, risulta morto due anni fa combattendo al fianco dei taliban pakistani in Afghanistan. Malika stessa, condannata per terrorismo, è tuttora in carcere in Belgio.
Informati che la polizia italiana ha catturato i due pesci più grossi, i magistrati belgi e francesi continuano a indagare su una quindicina di presunti complici dell’emiro, che vengono tutti condannati. In quei processi l’accusa dimostra, tra l’altro, che l’organizzazione di Ayachi era nata come centrale ufficiale di traduzione e diffusione dei proclami terroristici di Osama Bin Laden e del suo successore Ayman Zawahiri.
In Italia invece la giustizia si rivela molto più garantista. Da un verdetto all’altro, tra eccezioni ammazza-prove e formalismi procedurali, sembra quasi che si ripeta il vecchio copione dei processi a Cosa Nostra, nei decenni che hanno preceduto la storica maxi-sentenza del 30 gennaio 1992, quando le accuse ai mafiosi cadevano una dopo l’altra e alla fine vinceva sempre l’insufficienza di prove.
In primo grado, nel giugno 2011, Ayachi e Gendron vengono condannati a otto anni di reclusione. Nel luglio 2012 la corte d’appello li assolve a sorpresa, ma la Procura impugna e la Cassazione annulla il verdetto innocentista. Ayachi, tra l’altro, aveva fatto l’errore di rivendicare la sua fede in Al Qaeda spiegando di aver chiamato il figlio minore Mohamed Atta «perché lo considero un eroe». I suoi difensori italiani però, con arringhe magistrali, convincono i giudici che «non si può condannare nessuno per le sue idee, per quanto sembrino inaccettabili».
Molto probabilmente sul processo di Bari pesano i disastrosi precedenti di alcune montature orchestrate dai nostri vecchi servizi segreti nell’ansia di fare colpo dopo l’11 settembre, come le celebri assoluzioni dei tre pescatori egiziani di Anzio ingiustamente accusati di terrorismo nel 2002 o la fanta-scuola per kamikaze milanesi inventata nel 2005 dal generale Pollari.
Fatto sta che l’onda garantista di ritorno premia anche i due imputati di Bari, che il 3 aprile 2014 vengono assolti anche nel nuovo processo d’appello. Intanto altri giudici di secondo grado hanno scagionato Gendron pure per il traffico di immigrati e ridotto a soli due anni, ormai scontati, l’unica residua condanna di Ayachi.
Scarcerati dall’Italia, l’emiro e il suo fedelissimo collezionista di testamenti tornano beati in Belgio. Da dove ripartono segretamente per la Siria. Gendron, il francese convertito, si arruola in una milizia islamista e muore combattendo ai primi di aprile, proprio mentre l’Italia lo assolve.
L’emiro Ayachi sostiene di essere in Siria solo per portare “aiuti umanitari”, ma secondo la polizia belga è l’ideologo di una fazione in guerra, come confermano anche le foto, diffuse dalla sua stessa organizzazione, che lo ritraggono con un kalashnikov sulle ginocchia, circondato da jihadisti con i mitra e le bandiere nere.
Ora l’emiro assolto in Italia ha un martire anche in famiglia: suo figlio maggiore, Abdel Rahman Ayachi, che era diventato il comandante di un battaglione con oltre 500 combattenti chiamato “I falchi della Siria”, è morto in battaglia nel 2013. Perso il capo, i suoi miliziani, per lo più non siriani, sono confluiti nei maggiori eserciti jihadisti: i qaedisti di Al Nusra e i tagliatori di teste del califfato dell’Isis.

Nel 2012, proprio mentre quel network jihadista, molto forte nei Paesi Bassi e in Gran Bretagna, incita i musulmani europei alle rivolte di strada, Anas chiede alla questura di poter organizzare una manifestazione contro un pessimo film di un reazionario californiano, che fu usato come pretesto per l’assalto terroristico in cui fu ucciso l’ambasciatore americano in Libia. Il ventenne firma la sua richiesta a nome di “Sharia4Italy”, sigla mai comparsa prima in Italia e dichiaratamente collegata alla rete estera. Intercettandolo al computer, la polizia dimostra che Anas scarica e diffonde video di guerra, sermoni dei più pericolosi imam integralisti, inni al martirio, inviti a sgozzare i nemici.
Anas viene arrestato il 12 giugno, ma dopo due settimane riconquista la libertà: i giudici del riesame stabiliscono che non si può accusarlo di “addestramento al terrorismo”, perché si è comportato da reclutatore jihadista solo qualche volta, mentre per arrivare a una condanna in Italia la polizia dovrebbe provare un’attività «sistematica, non occasionale». Appena scarcerato, il ventenne contatta una rete di violenti predicatori albanesi e kosovari. E a quel punto parte per la guerra in Siria, da dove pubblica su Internet una foto con il mitra in spalla, sotto il nome di Anas Al Italy, “Anas l’italiano”. Ma nemmeno quel suo autoritratto armato potrebbe bastare alla giustizia italiana: il nostro codice, in attesa di una riforma ora ventilata anche dal ministro Alfano, punisce solo i mercenari che vanno in guerra all’estero per soldi.
Tra i diversi casi di integralisti assolti in Italia, ma diventati guerriglieri o terroristi all’estero, non mancano altre vicende controverse. Un esempio: nel 2011 la polizia di Catanzaro arresta l’imam di Sellia Marina, Mohammed Garouan, insieme al figlio Brahim. Tra le prove spunta un loro video con le tecniche per farsi una cintura esplosiva da kamikaze. I giudici del riesame però annullano gli arresti. Tornati liberi, i due predicatori vengono puntualmente segnalati in Siria. Dove Brahim, il figlio dell’imam, è entrato nella lista degli otto “jihadisti d’Italia” che risultano morti in battaglia.