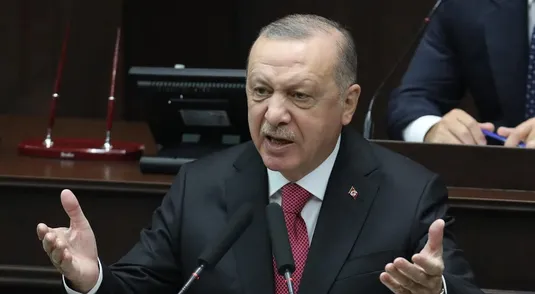Siamo a Makhmour, cittadina dell’Iraq settentrionale diventata uno snodo fondamentale dell’offensiva contro l’Is iniziata il 24 marzo scorso. Si trova a circa cinquanta chilometri da Mosul, la seconda città del Paese, conquistata dall’Is due anni fa. Bradosty spiega: «Quando qui sono arrivati i primi americani, la facevano facile. Ora quando li sentiamo parlare, evocano sempre la prima guerra mondiale: hanno capito che l’offensiva sarà lunga, costosa e piena di rischi».
«Sul fronte», dice ancora il colonnello, «l’esercito ufficiale iracheno deve muoversi da sud e noi peshmerga, che facciamo spesso da apripista, dovremmo spingere a nord e a est. L’obiettivo Usa è tagliare la retta che congiunge Raqqa e Mosul, mettendo in ginocchio la loro economia. Ma quello che hanno sottovalutato gli americani è che prima di pianificare un’operazione militare bisognerebbe tenere insieme forze militari già in conflitto tra loro».
Prima lo dice sottovoce e a mezza bocca, Bradosty. Poi, quando gli chiediamo se ha fiducia nell’esercito ufficiale iracheno, sorride sarcastico, avvicina il dito indice alla bocca e dice: «Ho l’ordine di non parlare dell’esercito iracheno. Sono un militare e obbedisco. Quello che posso dirti è che se è vero che esiste un esercito iracheno, è altrettanto vero che non esiste più uno Stato iracheno».

Bradosty riassume così il clima di questo fronte di guerra, lentissimo e surreale. Un fronte in cui la posta in gioco non è solo la riconquista di Mosul ma soprattutto la spartizione del potere che avverrà il giorno dopo, in un paese sempre più diviso da conflitti etnici e settarismo. Makhmour non è solo l’ultimo avamposto prima delle zone sotto il controllo dell’Is: è anche un’area contesa fra gli altri, cioè rivendicata sia dal governo di Baghdad, sia dal governo autonomo curdo (Krg) di base a Erbil. Dal giugno del 2014 la zona è divisa tra curdi e arabi sunniti, ma il governo di Erbil è stato chiaro: l’area è nostra. L’avamposto curdo è una casupola di cemento nudo: c’è una cucina e delle brandine a terra dove dormono i soldati dandosi il cambio ogni cinque ore. Davanti, sacchi di sabbia a protezione. A due chilometri, in lontananza, i villaggi ancora nelle mani dell’Is.
UNA COALIZIONE DIVISA IN TRE
I curdi hanno costruito, a partire da Makhmour, una trincea lunga mille chilometri. Ogni due c’è un fortino. Ogni fortino circa venti soldati. La trincea corrisponde di fatto, nelle intenzioni, al confine del futuro Stato curdo.
I curdi condividono il fronte con l’esercito iracheno e davanti al registratore tutti i comandanti dichiarano che le due forze «si coordinano quotidianamente». Ma durante la notte, di fronte all’ennesimo tè, nell’attesa di una comunicazione via radio o dell’avvistamento di movimenti sospetti attraverso i visori a ultrarossi, la versione dei fatti è decisamente più realista e i toni sono più diffidenti: «I colleghi iracheni non ci dicono mai esattamente cosa succede. Gli americani invece lo sanno che noi peshmerga siamo una forza fondamentale per la riuscita di questa offensiva. Se ricevessimo un ordine noi tutti saremmo pronti a combattere.
Però noi curdi senza un ordine del governo autonomo non possiamo superare il confine del nostro territorio e a sua volta il governo autonomo curdo deve coordinarsi con quello centrale di Baghdad». Parla così Bradosty, che era a Mosul quando la città è caduta e di quei giorni ricorda sia la popolazione che acclamava i miliziani di al Baghdadi come salvatori, sia le migliaia di soldati iracheni fuggiti in fretta e furia, abbandonando armi e veicoli militari dati loro in dotazione dagli americani, subito saccheggiati dai jihadisti.
I curdi considerano l’esercito iracheno debole, impreparato e soprattutto privo di motivazione.
Lo dimostrano, in parte, i fatti delle ultime settimane. Il villaggio di Al Nasr, ad esempio, liberato durante i primi giorni dell’offensiva, dopo poche ore è finito di nuovo nelle mani dei jihadisti che hanno lanciato un pesante contrattacco provocando gravi perdite tra le file dell’esercito iracheno. Dice il comandante curdo Khairy Mishko, nel silenzio della trincea rotto solo dal rumore dei droni e dai costanti colpi di artiglieria: «Adesso gli iracheni hanno ripreso una manciata di villaggi, in parte già abbandonati dai miliziani messi in fuga dai bombardamenti americani. Posti che non hanno praticamente importanza da un punto di vista militare. Forse hanno peso per i media internazionali, ma non servono a riprendere Mosul. Per riprendere Kharbarden, un piccolo villaggio di meno di un chilometro quadrato, ci hanno messo tre giorni: e quando sono entrati, i jihadisti l’avevano già abbandonato. Gli iracheni sono dilettanti. Se chiedessero a noi peshmerga di combattere, in pochi giorni potremmo segnare delle vittorie importanti».

I militari americani presenti a Makhmour sono ormai 4 mila: è facile vedere alti ufficiali marine e consulenti nelle basi irachene. Spesso è più difficile distinguere i soldati semplici: gli americani infatti hanno dotato gli iracheni di equipaggiamento, divise e armi. E i giovani soldati di Baghdad sembrano più interessati ai gadget che non alle strategie militari.
Christopher Harmer, analista presso il Washington Institute for the Study of War, ha sottolineato in queste settimane che l’Is non può aspirare a una ulteriore espansione territoriale, ma sta comunque mostrando tutta l’inadeguatezza dell’esercito iracheno.
Contemporaneamente gli Stati Uniti, pur riconoscendo una maggiore capacità delle truppe peshmerga sul campo di battaglia, sanno che mettere i curdi in prima linea corrisponderebbe a legittimare di fatto l’esistenza di uno Stato autonomo e rompere del tutto l’illusione di un Iraq unitario. Di qui lo stallo.
KAMIKAZE TRAVESTITI DA DONNE
Dall’inizio dell’offensiva su Mosul, i civili in fuga verso il Kurdistan iracheno sono più di quattromila. Arrivano di notte, attraversando le campagne e il fiume Tigri, camminando per ore. E giungono stremati agli avamposti militari implorando di essere salvati. Nella notte che abbiamo trascorso con i peshmerga della Quindicesima divisione, quattro ragazzi in fuga da Qayyarah (città ancora nelle mani dell’Is, dove si trovano un’ex base dell’esercito iracheno e una pista di atterraggio) sono arrivati scalzi e stremati al bordo del fossato. «Dobbiamo chiedere loro di spogliarsi, perché potrebbero essere kamikaze e avere addosso una cintura esplosiva», dice Bradosty mentre illumina con una torcia i corpi esili di questi minorenni: «È già successo nelle ultime settimane che ci attaccassero così: arrivano a gruppi di otto, dieci persone, spesso vestiti da donna col niqab, e improvvisamente cominciano a correre. Una volta di fronte al fossato si fanno esplodere uccidendo i nostri soldati».
Akram e i suoi tre amici invece risultano puliti. Sono fuggiti durante l’ora della preghiera: è più facile, spiegano, perché in quei momenti i miliziani dell’Is sono distratti. Ci raccontano anche che i loro genitori non volevano che scappassero perché da quando è iniziata l’offensiva i jihadisti hanno minato i campi intorno ai villaggi, proprio per evitare fughe di civili. Molti sono morti cercando di scappare e altri sono arrivati in Kurdistan feriti.
Akram ha ancora tutta la sua famiglia a Qayyarah: voleva salvare il proprio futuro ma ora teme ritorsioni sui suoi parenti. Racconta che quando sono iniziati i bombardamenti alleati, i miliziani dell’Is hanno cominciato a occupare le case della gente, vivendo insieme a loro: usandoli - di fatto - come scudi umani.
Secondo Airwars, un progetto di monitoraggio basato sui media locali e sui social media iracheni, sarebbero almeno 170 i civili uccisi dalla coalizione da marzo. Cifre, ovviamente, non confermate dai funzionari americani.
«Nella casa accanto alla nostra», racconta Akram, «quelli dell’Is avevano messo un mortaio. I vicini li hanno implorati di andare via, invece sono rimasti e alla fine la casa è stata bombardata e tre persone sono morte».
Secondo le associazioni umanitarie sono almeno 600 mila i civili ancora nelle mani dell’Is: chi è riuscito a fuggire affolla il nuovo campo di Dibaga, che ora contiene tremila persone più di quelle che potrebbe.
Molti di loro, come Akram, non si fidano dell’esercito iracheno. I civili giunti in Kurdistan dai villaggi liberati raccontano che i soldati di Baghdad spesso non sono in grado di distinguere tra civili e uomini dell’Is. E denunciano maltrattamenti.
La diffidenza delle persone è un’ulteriore ragione della lentezza dell’offensiva su Mosul: le tensioni tra tribù sunnite locali e le forze militari sciite, rischiano di esasperare tensioni già esistenti, in una guerra in cui la violenza è protagonista.
Akram dice che alcuni dei suoi familiari sono dall’altra parte: combattono con l’Is. E racconta che di là, da due anni, è stata impedita a tutti qualsiasi comunicazione con l’esterno. Poi parla delle decapitazioni in piazza e del reclutamento dei più giovani durante l’ora di preghiera. Ma soprattutto denuncia un radicale peggioramento delle condizioni economiche nei villaggi: i tagli dei finanziamenti all’Is iniziano a pesare. Conferma il colonnello Bradosty: «Molti civili raccontano di un impoverimento generale nelle zone controllate dal Califfo. Questo è molto importante per la riuscita della nostra operazione, perché mina il consenso intorno all’Is. Molta, troppa gente a Mosul ha piegato la testa a Daesh soltanto per ragioni economiche. Se riusciamo ad abbattere il loro sistema economico, perderanno consenso e sarà più facile liberare la città. Dobbiamo logorarli e isolarli, così da convincere chi ancora li appoggia e li protegge a non farlo più. Dobbiamo presidiare le strade secondarie per impedire loro di approvvigionarsi».
«Ma se Mosul è ancora nelle mani dell’Is la maggior parte della colpa è della gente stessa di Mosul», dice Arcan, soldato iracheno che incontriamo il giorno dopo in una base dell’esercito ufficiale di Baghdad. Ha 25 anni, un fratello ucciso dai jihadisti e una famiglia ancora intrappolata di là del fronte. Sta preparando l’Humvee con cui ci porterà verso Mahana, l’ultimo villaggio liberato gli iracheni. E intanto ci descrive - severo - le responsabilità dei suoi concittadini. «Li hanno appoggiati per convenienza e ora scappano per convenienza e perché sono spaventati dai droni e dalle bombe. Non scappano per convinzione, non scappano perché sono critici verso il Califfo. Non è venuto meno il sogno di al Baghdadi, sono solo cominciati a mancare i soldi».
"SIAMO SOLO 5000, NON POSSIAMO FARCELA”
Attraversiamo la trincea nella zona più pericolosa, ci sono ancora mine. Un mezzo militare è esploso poche ore prima del nostro passaggio.
I mezzi iracheni lavorano dalla mattina alla sera per lo sminamento delle campagne, ma i jihadisti hanno lasciato trappole dappertutto prima della fuga. Firas al Naser, responsabile media della base irachena, ci mostra sul suo telefono le immagini della presa di Mahana. Si vede un giovane soldato sostituire la bandiera del Califfato con quella irachena. Al Naser ci spiega però che è necessario liberare venti villaggi sulla strada di Mosul, prima di arrivare in città. Primo tra tutti Qayyarah, perché si trova a cavallo tra le principali vie di approvvigionamento del nord Iraq. «Dobbiamo accerchiarli prima dell’attacco finale», dice. Ma quando gli chiediamo che tempi siano stimati, tergiversa. «Questa non è una guerra, è una guerriglia. È impossibile prevedere quando riprenderemo Mosul. Possiamo solo dire: speriamo presto». E poi: «Ci sono cinquemila soldati nella base e non c’è dubbio che ne servirebbero almeno tre volte tanto. Con queste forze non possiamo farcela».
Il tempo è scandito dai colpi di mortaio che arrivano dall’altra parte della trincea e gli attacchi suicidi. Nelle ultime settimane gli uomini del Califfo hanno usato anche le armi chimiche. Poche settimane fa in tre ore sono arrivati venti razzi sulla città di Taza e oltre cento persone hanno registrato bruciature e problemi respiratori. I miliziani dell’Is hanno utilizzato gas cloro, che è altamente tossico.«Quando arriviamo nel villaggio, al Naser ci conduce nella rete di tunnel costruita dai jihadisti: ci sono decine di stanze, materassi, cuscini, il Corano dappertutto, resti di medicine per i soldati feriti che si sono curati nei cunicoli costruiti sottoterra, armi, resti di esplosivo.
Esattamente come a Sinjar, i miliziani hanno costruito una fitta e sofisticata città sotterranea, per muoversi nell’ombra e rendere ancora più difficile il lavoro dei droni americani.
Nella moschea del villaggio invece vediamo i resti di due kamikaze: si sono fatti saltare in aria prima dell’arrivo dei militari iracheni.
«Ci fidiamo degli americani», assicura al Naser, «e anche se sappiamo che ci vorrà molto più tempo del previsto, metteremo ogni nostro soldato a disposizione di questa offensiva. Arriveremo a Qayyarah, prenderemo Hawija, una città a 200 chilometri da Baghdad, poi conquisteremo Shirqat e Abbasi, li faremo sentire accerchiati. Dobbiamo stringerli in una trappola. Non importa quanto tempo ci vorrà, ma ce la faremo».
Ma tra l’esercito iracheno, quello curdo e i militari americani, formalmente alleati, di fatto non esiste né un accordo sulla strategia militare da mettere in campo, né tanto meno un piano condiviso per il dopo Is. Anche per questo si va avanti così piano. Intanto, appena di là del fronte, ancora 600 mila persone vivono sotto il controllo dei jihadisti.