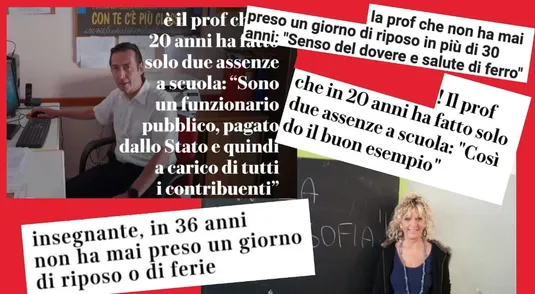Ero una docente precaria, capitai in una classe in cui non conoscevo gli studenti, come sempre. E, come sempre, mi legai a ognuno di loro, secondo il mio modo di intendere la scuola: il posto dove s’insegna a diventare cittadini responsabili e maturi, dove si regala sapere e desiderio di conoscenza, rispettando sempre l’altro, non la sua veste. Non ero stata sempre rispettata da studentessa, non l’ho mai dimenticato e, proprio per questo, ho deciso di cambiare parte di quell’istituzione non permettendo che i ragazzi subissero ciò che avevo dovuto sopportare io. Per questo motivo ho deciso di smettere di pubblicare (non di scrivere), di girare trasmissioni: rifiuto ogni proposta, non presenzio da nessuna parte; sono una docente e basta.
In questa classe, non diversamente da tutte quelle in cui avevo insegnato, il livello di conoscenza della grammatica era bassissimo e, pur essendo in un Istituto superiore di secondo grado, gli errori di ortografia innumerevoli. Evitando lo scaricabarile che serve solo a non agire, chiarii con alunni e famiglie che avrei ricominciato dall’inizio, con la coniugazione dei verbi regolari, l’analisi grammaticale, l’ortografia, appunto, non nascondendo che ci sarebbe stato molto da faticare, ma dando il mio sostegno continuo e individuale a tutti gli studenti: significò essere presente su una piattaforma, pronta a rispiegare tutto a ognuno in forma privata, per sei ore al giorno circa; mi stancavo, ma vedevo i progressi e andavo avanti, felice della gioia dei miei ragazzi che iniziarono quasi subito a vedere i risultati.

Ma, a distanza di un mese o poco più, Angelo ritornò come prima e fece perfino in tempo a dimenticare tutto quello che aveva studiato: a nulla servirono le mie lettere, i miei appelli a lui e ai compagni perché lo sollecitassero; i voti sul registro non potevano che testimoniare i dati di fatto e incontrai la famiglia.
Il primo colloquio fu strano: parlavo delle carenze del ragazzo, ma registravo dall’altra parte l’impressione che la famiglia non desse alcuna rilevanza alla conoscenza dell’Italiano; ci lasciammo, comunque, con la promessa che avrebbero seguito Angelo in modo che recuperasse. Non avvenne e, mentre la classe proseguiva il suo cammino, ormai erano così tante le lezioni perse tra uno sbadiglio e l’altro che recuperare diventava impresa titanica per quel ragazzo che non frequentava più neanche i corsi di recupero. E tornarono i genitori, stavolta allarmati: rispiegai tutta la situazione, nonostante, in ogni mio voto, aggiungessi da sempre tutte le motivazioni e chiedessi un intervento della famiglia; era aprile, se avesse provato seriamente a studiare e fosse stato attento in classe, sì, sarebbe riuscito a farcela, ero lì a non aspettare altro, che imparasse. Ma Angelo si limitò a saper coniugare più o meno correttamente un paio di verbi, a studiare qualche complemento, continuando a distrarsi in classe, a non prendere mai la mano che gli avevo offerta e restava lì, tesa, ad aspettare lui; il rendimento era calato decisamente anche in Storia, intanto, e non si decideva a far qualcosa per aiutarmi ad aiutarlo.
Arrivato maggio, la famiglia si ripresentò e stavolta le cose andarono molto diversamente: quel ragazzo, sì, si era finalmente deciso a fare qualcosa, ma la fine della scuola era ormai prossima, non sarebbe stato più intelligente pensare almeno a impegnarsi in Storia dove la situazione non era così tragica? Ogni mia parola veniva fraintesa: stavo, quindi, dicendo, che non doveva più studiare l’italiano? Con un paragone Dio solo sa quanto fuori luogo, specie se detto a me, venni paragonata a chi vede una persona affogare e gli dà un colpo di remo in testa. Fui insultata, venne messo in dubbio il mio modo di insegnare, le grida si sentivano fuori da quell’aula e vedevo gente che guardava allibita questo agitarsi di mani davanti alla figura anche abbastanza minuta di una docente che chiedeva dignità per la sua materia prima ancora che per la sua persona, in maniera pacata. Fino all’intollerabile. «Io la avverto! Stia attenta a quello che potrà capitarle se boccia mio figlio!». Diventai di pietra; seduta al mio posto, dissi: «Questa è una minaccia a pubblico ufficiale, perseguibile per legge. Il colloquio è finito, fuori». Continuarono a inveire, ripetei «Fuori!» e andarono finalmente via. La decisione di non denunciare l’episodio fu frutto di una riflessione essenzialmente basata su un solo fattore: non avevo testimoni. Chi aveva assistito era troppo distante per udire quelle parole, pronunciate con un tono di voce stranamente basso, in mezzo a tutte quelle urla.
Feci presente, naturalmente, l’accaduto ai colleghi e alla Dirigente scolastica: i primi non si mostrarono particolarmente stupiti, avevano subito anch’essi minacce e, a parole, giurarono che mai si sarebbero lasciati intimidire o comprare; alla seconda, invece, dissi che non avrei mai più accettato di incontrarli senza un testimone, e si offrì di fare da intermediaria, qualora ci fossimo rivisti.
Mi sentii in un mondo che di scolastico non aveva più nulla; noi insegniamo legalità, rispetto: consentiamo che i soprusi avvengano davanti a noi, sulla nostra pelle? Ebbi modo, comunque, di insegnare ad Angelo che cosa era l’onestà: il ragazzo chiese di essere interrogato in Storia e riuscì a recuperare degnamente, non aveva nessuna colpa per le azioni della sua famiglia; tutte le altre insufficienze si trasformarono, invece, in quel numero che valeva quanto la mia vita, sei, tranne Italiano: l’esame si svolse secondo la traccia che io avevo lasciato e Angelo seppe superarlo brillantemente, studiando per tre mesi la grammatica. Spero che almeno lui abbia compreso quanto vale la dignità di un docente, che non creda che la scuola (come la vita) sia formata solo da gente che abbassa la testa né che i soprusi siano destinati al successo, in terre di mafia come in quelle che si dicono estranee alla mafia.
Una nota divertente: pare che per non essere denunciati, i due abbiano detto che quella frase non era una minaccia, ma un volermi augurare qualcosa di brutto; considerato che ho un cancro, l’augurio a me suona ridicolo. Quasi quanto loro.