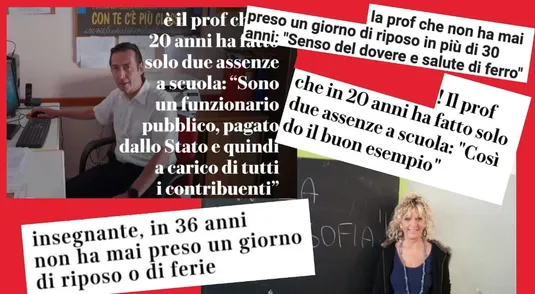L’episodio risale al febbraio del 2017 e fu proprio L’Espresso a scoprirlo e a dargli rilevanza. Seguirono interrogazioni parlamentari e un ricorso contro l’azienda. Alla Sevel di Atessa, del gruppo Fiat-Chrysler, il più grande impianto europeo per l’assemblaggio dei veicoli commerciali leggeri (tra cui il Ducato), un operaio si trovò costretto a farsi la pipì addosso perché i suoi capi gli avevano impedito di andare in bagno.
L’uomo, assunto da oltre dieci anni, aveva anche e a più riprese chiesto il permesso di recarcisi, alla toilette. L’attesa divenne però presto tormentosa e intollerabile. Non ce la faceva più a trattenersi. Di fronte al «no» dei suoi superiori, non gli restò, alla fine, che urinarsi dentro i pantaloni. E in seguito dovette continuare per un’oretta abbondante il suo turno in catena di montaggio.
Cronaca della negazione di un banalissimo, ma fondamentale, diritto fisiologico sul posto di lavoro nell’era del capitalismo avanzatissimo. Affermò la tuta blu: «Mi sento umiliato. Ho insistito parecchio, per oltre mezz’ora. Ho chiamato, cercato di farmi ascoltare. Invano».
La notizia è di queste ultime ore. Il tribunale di Lanciano ha accolto il ricorso del lavoratore e ha condannato la Sevel a corrispondergli un giusto risarcimento del danno. «Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento. La ricostruzione dei fatti ha trovato conferma nelle dichiarazioni rilasciate dai testi addotti dalla parte ricorrente, che risultano univoche, concordanti, lineari e coerenti» scrive nella sua sentenza la giudice del lavoro Cristina Di Stefano. E aggiunge: «Dagli elementi probatori raccolti in ordine alla gravità oggettiva del fatto, è possibile affermare che il datore di lavoro ha arrecato concreto e grave pregiudizio alla dignità personale del lavoratore nel luogo di lavoro, al suo onore e alla sua reputazione, indubbiamente derivante dall’imbarazzo di essere osservato dai colleghi con i pantaloni bagnati per essersi minzionato addosso».
FCA dovrà ora risarcirlo con 5 mila euro, oltre che farsi carico delle intere spese processuali. La cifra è più bassa di quanto inizialmente rivendicato perché la giudice non ha riconosciuto, per insufficienza di riscontri, il danno biologico, ma solo quello morale. Negli ultimi due anni e mezzo l’operaio ha lamentato infatti di soffrire di uno stato ansioso e depressivo, per cui è tutt'ora in cura, innescato proprio da quel pomeriggio di gogna.
«Questa sentenza ha reso giustizia all’operaio, restituendogli in parte una dignità che rimane irreversibilmente lesa» dichiara l’USB Abruzzo. «Sono soddisfatto. Avevo preso a cuore questa vicenda per la carica di giustizia inaudita che portava con sé. Avvenimenti che non dovrebbero essere neppure immaginabili, ma che purtroppo ancora avvengono, dopo tanti anni di battaglie per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori, riportandoci indietro di decenni – spiega all’Espresso l’avvocato Diego Bracciale, che ha rappresentato il dipendente -. Sono felice che sia stata fatta giustizia su un caso che aveva visto un’irrimediabile lesione della dignità e della serenità di un lavoratore esemplare. Attendiamo di vedere se FCA impugnerà la sentenza. Il mio ringraziamento va anche ai colleghi del mio cliente che hanno deciso, con coraggio, di testimoniare contro il datore di lavoro. Cosa, oggi, tutt'altro che scontata».
Nella sentenza sono riportate diverse loro dichiarazioni. «Non riuscì ad arrivare in bagno, si urinò nei pantaloni. Ricordo che dopo esservi stato, tornò a lavorare con i pantaloni bagnati nella zona dell’inguine» racconta un suo vicino di reparto. «Quando ci andò, aveva un andamento lento e sofferente, e si teneva la parte bassa della pancia» soggiunge un altro. «L’abbiamo visto cambiarsi solo durante la pausa delle 18, nel cosiddetto box Ute» ( e non in lavanderia come da lui richiesto).
Un’ora e un quarto dopo l’arrivo dell’urgenza di urinare, insomma: il suo primo allarme l’aveva lanciato alle 16.45.
Attualità
24 settembre, 2019Operaio costretto a urinarsi addosso: azienda viene condannata a pagare risarcimento
Il caso della Sevel di Atessa, gruppo Fca, denunciato nel 2017 dall'Espresso. A un dipendente, nonostante le ripetute richieste, fu vietato di andare in bagno e dovette lavorare per ore con i pantaloni bagnati