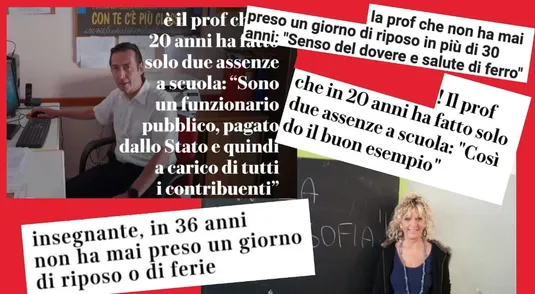Il cambiamento sta già avvenendo. La reazione all’emergenza coronavirus sta portando uffici, imprese e servizi a immaginare come portare avanti un mondo svuotato dalla presenza. Nelle città compresse dalle politiche di contenimento del contagio, si cerca di andare avanti. I decreti del governo per frenare l’epidemia hanno riaperto il dibattito sulla scelta - o non scelta - delle forme di occupazione “agile”, ovvero da remoto, da casa propria, dai territori parcellizzati per la necessità di ridurre al minimo i contatti. Ma lo stato d’eccezione sta facendo implodere schemi più profondi, rendendo necessarie riflessioni che vanno oltre la risposta all’emergenza. Diventando interrogativi su come sarà il lavoro del futuro.
Mentre l’Italia e l’Europa cercano infatti di mettere in campo ammortizzatori sociali per rispondere alla serrata economica globale, mentre le aziende impongono ferie o turni obbligati ai dipendenti, e i sindacati chiedono sicurezza per i dipendenti che non possono sospendere le proprie attività, ci sono categorie che risultano già adesso doppiamente fragili. Le partite iva e gli autonomi, che non possono contare su cassa integrazione o sostegni di categoria. I soci di cooperative o di servizi sociali privatizzati. I precari che rischiano di pagare due volte le debolezze di un sistema economico fragile già prima dell’emergenza. E questo è solo l’inizio di un panorama destinato a cambiare radicalmente per la convergenza fra lo shock del virus e la rivoluzione tecnologica in corso. L’Espresso ne ha parlato con Maurizio Del Conte - il giuslavorista che ha firmato il primo provvedimento legislativo sullo smart working in Italia, inserito nella legge 81 del 2017 - e con Daniel Susskind, ricercatore d’Economia all’Università di Oxford e autore di “Un mondo senza lavoro” in uscita per Bompiani nel 2021.
«La situazione d’emergenza sta forzando l’utilizzo normale del lavoro agile», inizia Del Conte, che dopo l’esperienza alla guida dell’Agenzia nazionale per le politiche attive (Anpal), è tornato a insegnare in Bocconi: «Ma di sicuro sta permettendo anche di scoprire che è uno strumento possibile, efficace, che potrà essere diffuso ben oltre i circa 600 mila dipendenti che ne facevano uso prima della crisi». Del Conte è un sostenitore sentito dell’occupazione distribuita in modo flessibile fra casa e ufficio: «Permette risparmi decisivi ai dipendenti - sulle spese di viaggio, di alimentazione, di delega a terzi di impegni domestici; consente un uso più flessibile del tempo; e allo stesso tempo se ben gestito non incide sull’efficienza, portando a risparmi anche per i datori di lavoro».
Ci sono però dei “come” che Del Conte ci tiene a precisare. «Ne sottolineerei tre, fondamentali: la concertazione; il consenso; e l’organizzazione».
Partiamo dal primo: «È importante che le forme di lavoro agile passino da accordi collettivi, per trovare il miglior equilibrio possibile fra vantaggi e rischi di questo modello. Nella legge del 2017 abbiamo inserito appositamente il fatto che un impiego non può essere eseguito esclusivamente da remoto, per evitare diventi un tipo di isolamento. Deve essere garantito il collegamento con la comunità sociale che il lavoro rappresenta. È una dimensione che va preservata sia a livello complessivo che singolarmente».
E qui si passa al secondo elemento: «Il consenso: bisogna evitare a ogni costo che l’occupazione da “remoto” diventi un modo per isolare lavoratori sgraditi, o per fare anticamera a una riduzione del personale. Per questo è necessario che questa tipologia sia una scelta consensuale, che nessun imprenditore può imporre ai propri dipendenti. Nel decreto per l’emergenza coronavirus è stata inserita una deroga a questo aspetto. Il datore di lavoro può predisporre obbligatoriamente un assetto agile per garantire la continuità. Ma questa deroga deve essere assolutamente sospesa con la fine dell’emergenza. Nel mentre, si potrebbe inoltre rendere meno asimmetrica: dando la possibilità al dipendente di chiedere forme di lavoro a remoto in questo momento eccezionale. Se non ci sono ostacoli dimostrabili, dovrebbero essere garantite a tutti».
L’ultimo aspetto è quello dell’organizzazione: perché l’agile sia agile, «servono infrastrutture: banda larga, spazi da poter condividere durante la giornata, criteri di valutazione dei risultati aziendali». Senza questi elementi, il rischio è che l’agilità diventi frustrazione: per le chiamate che non prendono, per la connessione che fa saltare passaggi di conversazioni, per l’attesa di risposte su come procedere su un compito o una missione. Inoltre, conclude Del Conte, se l’emergenza sta facendo associare il lavoro agile alle stanze domestiche dove milioni di cittadini devono restare più a lungo per evitare di propagare il contagio, il principio della norma non era a favore dell’isolamento, quanto a favore di una possibilità di incontro più flessibile. La tecnologia dovrebbe favorire questa apertura. Ma l’apertura rischia di diventare piuttosto una gabbia.
Daniel Susskind, che da anni studia l’impatto delle tecnologie sull’occupazione umana (“Un mondo senza lavoro”, come si evince dal titolo, ne è un’analisi radicale; in attesa del libro è possibile ascoltare online un suo eccezionale intervento alle conferenze Ted) inizia così la sua riflessione con l’Espresso a riguardo: «C’è una barriera nell’accettare l’isolamento e le soluzioni di lavoro da casa, al posto della condivisione di un ufficio, o di un posto dove possiamo sederci e discutere con gli altri. Questa barriera è una forma di resistenza culturale e sociale. Nell’emergenza che stiamo vivendo, le persone vengono forzate a usare le tecnologie per evitare gli spazi comuni. Questo significa che non torneremo più in ufficio? Penso che un cambiamento a riguardo ci sarà per forza. La pandemia sta in qualche modo catalizzando, accelerando, una possibilità data dalla tecnologia».
Susskind invita però a riflettere sulla dipendenza da interfacce, software, computer e algoritmi nell’organizzazione di servizi e attività. Perché quando si parla di come le macchine stiano sempre più velocemente sostituendo gli uomini nelle produzioni e nei servizi, «ci preoccupiamo sempre di quanti lavori la rivoluzione digitale porterà via, e non ci fermiamo a osservare come la tecnologia non cambierà solo i numeri, ma anche la natura stessa del lavoro». E qui si torna all’isolamento che migliaia di italiani stanno sperimentando in queste ore. «Il lavoro non è solo uno stipendio. Nelle nostre società, il lavoro è un obiettivo di vita. Parlando dell’epidemia, in questi giorni, la stampa inglese è piena di articoli che suggeriscono alle persone come potrebbero o dovrebbero trascorrere il tempo durante la quarantena. Penso sia il sintomo di domande profonde, che ci dovremmo porre tutti, rispetto al tempo. Perché normalmente usiamo tutto il nostro tempo lavorando. Per cui la prospettiva di perdere quel centro significa insicurezza e ansia su più livelli. Non è solo la paura di perdere il proprio reddito. È la paura di perdere la propria identità». C’è un altro aspetto della tecnica che il coronavirus non dovrebbe farci dimenticare. «Ed è la doppia natura della tecnologia. Tutti stiamo osservando la corsa per dare risposte tecnologiche all’epidemia, e il flusso di dati che arrivano da paesi come Singapore sui movimenti delle persone, i contatti. Le tecnologie possono aiutarci a contenere il contagio, certo, ma non bisogna mai sottovalutare l’altro lato di questa forza: la sorveglianza».
Isolamento, identità, controllo. Le domande interne alla rivoluzione tecnologica si intrecciano all’epidemia. Da una parte per l’incertezza sulle prospettive economiche per l’Europa e il resto del mondo, come conseguenza del virus - la promessa di un’occupazione sia per uomini che per macchine si fonda infatti su una prospettiva di aumento continuo della produttività e dei consumi che vacillava già prima dell’epidemia. «La globalizzazione era il principale fattore di crescita, grazie alle filiere globali. Quello sviluppo mondiale e apparentemente illimitato sta mostrando le sue implicazioni più profonde. La scala dello shock che stiamo vivendo ora avrà un impatto enorme in questo senso».
Ma la riflessione principale da fare è un’altra, suggerisce Susskind. «Penso che il collegamento più importante sia concettuale. Sia la crescita del virus che la crescita della tecnologia sono processi esponenziali. Nel caso della pandemia significa che un numero limitato di casi può esplodere molto velocemente in un un numero molto largo, e prenderci alla sprovvista». È la classica parabola del riso sulla scacchiera del faraone: un chicco nella prima casella, raddoppiando di volta in volta, arrivava a superare l’intero raccolto del mondo. «C’è una linea che segna la differenza rispetto a come percepiamo questo aumento. Tutto, prima, sembra una reazione eccessiva. Dopo, tutto sempre una sottovalutazione. La natura umana fa fatica ad accettare la crescita esponenziale. Ci adattiamo all’aumento graduale, mentre qui, c’è un esplosione. Ed è esattamente quello che sta accadendo con la rivoluzione tecnologica. Ci impegniamo a immaginare come sarà il lavoro nel 2030, eppure non aiutiamo le persone a sviluppare le capacità e le competenze che permetteranno loro di navigare questo cambiamento epocale. Le strategie possibili sono solo due: diventare qualcuno che disegna o costruisce le macchine; o diventare qualcuno che può competere con loro. Continuare ad educare persone per compiti o attività routinarie che verranno spazzate via dalla tecnologia, o che le macchine addirittura già compiono, è una non-strategia. Dobbiamo iniziare a pensare adesso a questo futuro». Se non vogliamo trovarci sorpresi, davanti a un mondo cambiato, come ci è successo con il virus.