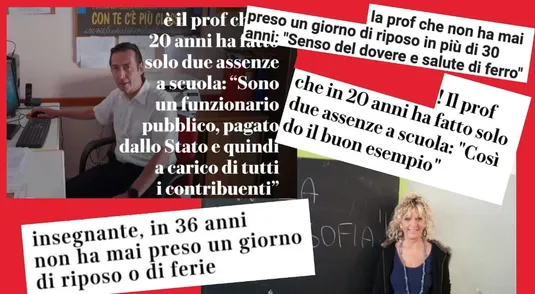Non lo vogliamo dire ma nel nuovo presente tutto ci sembra più faticoso.
Forse abbiamo bisogno di qualcosa in più per ritenere, le cose di ogni giorno, sensate o anche semplicemente, “utili”. Segnali più deboli, numeri più ridotti ma da tempo arrivavano le avvisaglie. Un po’ ovunque, nel mondo, è più evidente l’abbassamento della soglia di tolleranza rispetto ad una vita che non rende felici, a partire dalla propria dimensione lavorativa e da ciò è partito l’aumento delle dimissioni volontarie.
Ci han turbato le risposte alle nuove domande. Il “valore” del lavoro corre, sempre meno, di pari passo con la sua importanza soggettiva, il suo senso. È invece quest’ultimo è sempre più importante. Mi valorizza, mi fa crescere, come dice il Papa, “mi fa fiorire”, mi rende felice? Sono domande che ci si è sempre posti ma che oggi diventano più pressanti, assillanti, definitive. Complice, per alcuni, la libertà interiore che, nella tragedia, è stata riscoperta grazie alla discontinuità che questa pandemia ha generato. Tempi dilatati, domande. Paura di fronte alla scoperta della fragilità delle impalcature delle nostre esistenze, ma anche angoscia che nulla cambi e volontà che qualcosa si muova, finalmente. E invece del lavoro non si parla, i lavoratori sono protagonisti solo quando sono morti o disperati e nella battaglia per liberarsi dal lavoro o nel lavoro, ha vinto la prima cultura.
Stati Uniti, Cina e noi. Chi vede nel mercato il luogo salvifico di tutto come chi ne vede la causa di tutti i mali ha in comune lenti troppo binarie per capire le complessità di oggi, sempre più distanti dal determinismo economico di qualsiasi matrice. Negli Stati Uniti lo hanno chiamato “Great Resignation” o “Big Quit”, il numero crescente di dimissioni per la ricerca, spesso senza proposte in tasca, di qualcosa di più appagante. Lo stesso in Italia: a leggere le comunicazioni obbligatorie all’Inps notiamo una crescita del 40 per cento tra aprile e giugno 2021. L’85 per cento in più rispetto al 2020, ben 484.000 di dimissioni dal lavoro rilevate attraverso le comunicazioni obbligatorie all’Inps. Anche recentemente, i dati sul precariato dell’Inps, confermano che, anche negli ultimi mesi, le grandi dimissioni non si fermano: 112 mila cessazioni ad agosto, 952 mila nei primi 8 mesi. Al netto dei pensionamenti, +12 per cento di cessazioni di rapporti a tempo indeterminato in un anno è un dato che deve far pensare. Anche in Cina la tradizionale “busta rossa” contenente denaro (la nostra tredicesima, per chi ha la fortuna di riceverla) che le aziende consegnano alle persone prima del Capodanno, in Cina il nuovo anno quest’anno inizierà il nostro 1 febbraio. È l’occasione in cui si raggiunge la propria famiglia nell’entroterra e le aziende, in molti casi, già prima della pandemia avevano iniziato a consegnarla al ritorno al lavoro poiché è crescente il numero di persone che non vi fanno ritorno. Paese in cui le big tech si facevano vanto del “modello 996” lavoro 12 ore (9am-9pm) per 6 giorni alla settimana. La pandemia non è il fattore determinante, ha solamente accentuato, accelerato e messo in trasparenza, questa ed altre tendenze.
I 4+1 nodi del paradosso italiano. In Italia il fenomeno delle dimissioni volontarie è ancora più grave perché concomitante con altri 3 elementi: un tasso di disoccupazione giovanile tra i più alti d’Europa, concomitante con uno skills mismatch (disallineamento tra competenze richieste e quelle generate dal sistema di istruzione e formazione che determina posti di lavoro vacanti), una migrazione in uscita dal nostro Paese proprio di giovani con medio alte professionalità. A cui potremmo aggiungere, al contrario, una scarsa attrattività verso di noi dei giovani di altri Paesi.
Poco contenti del lavoro. I dati di Gallup dimostrano che solo il 5 per cento in Italia (10 per cento area Ocse) è contento del proprio lavoro. Pochi? Contenti non dello stipendio, dei benefit, della sua stabilità, proprio del lavoro che si svolge. Anche perché l’aspetto economico è rilevante ma ad esso si uniscono elementi di realizzazione, di condivisione di senso, di progetto, la qualità delle relazioni sociali. E ultimamente anche di flessibilità attiva. I migliori talenti chiedono sempre di più giornate di smart working, di non avere né orari né luoghi di lavoro rigidi, che consentano un equilibrio diverso tra lavoro e il resto della vita. In alcuni casi non si lascia solo il lavoro, ma si scappa dalle città e dai paesi che non si scelgono o che non ti accolgono, in cui non trovi né libertà né opportunità vere. Ci sono tanti fattori scatenanti, anche il bilancio di quanto tempo nel lavoro dedichiamo alle ossessioni della sua struttura gerarchica, a far cose di cui non percepiamo alcuna importanza. Ad ambienti lavorativi in cui la gerarchia e la valorizzazione è data alla fedeltà a vertici neanche tanto entusiasmanti. Per questo, per alcuni siamo nell’epoca dei galleggiatori mediocri che, travolti dal loro stesso coraggio, vedono in questi fenomeni, una straordinaria occasione per emergere.
Le ragioni per un nuovo inizio. Il «si vive una volta sola», l’abbassamento della soglia di tolleranza ha anche lati positivi: che ci sia maggiore mobilità può far bene ma non sarà facile con una rete di protezione e promozione sociale sempre più inefficace. Che fare allora? La prima cosa è inserire e integrare sempre di più la dimensione della “cura” in qualsiasi ambito della nostra esperienza umana nel lavoro. I sistemi produttivi e la vecchia economia fordista “curavano” poco, anzi, piuttosto generavano necessità di cura. Si chiedeva uno sforzo fisico, spesso ripetitivo, logorante. Nella grande trasformazione del lavoro il digitale, la robotica cooperativa, lo schema cambia. Bisogna operare affinché il lavoro richieda la nostra dote più incontendibile con le macchine e cioè la nostra #umanitàumentata. Torna con forza la capacità di costruire tessiture sociali territoriali in grado di realizzare diversamente le comunità del lavoro. Già da prima della frammentazione del lavoro, i suoi luoghi erano sempre meno comunità. Anche tra i lavoratori ha vinto un’altra cultura che divide e illude di poter vincere da soli. E il rischio è sempre più questo, restare veramente più soli, in una dimensione che ci opprime, costruendosi mille scuse e maledendo chi ha il coraggio o l’incoscienza di cambiare davvero.
Non servono gli esperti della fuga dal lavoro, ma architetti del nuovo lavoro. Coloro cioè che hanno la capacità e il coraggio di riflettere e progettare, andando oltre le vecchie categorie, perfette per capire ieri, ma che oggi sono inutili se non dannose finanche a descrivere il lavoro. Inserire la dimensione della cura è difficile. Mentre il digitale “scongela” il tempo e lo spazio del lavoro. Si apre una stagione di ridisegno degli spazi vitali e del lavoro e ciò può rappresentare un’occasione, ridisegnarli anche allo scopo di generare condivisione, di contenere tempi diversi, apparentemente non conciliabili nello stesso luogo: quello dell’efficienza (per sua natura, veloce) e quello appunto della cura (che non può che essere lento perché aiuta a prestare attenzione, accudisce). È proprio su questo che dobbiamo edificare ciò che ci sarà dopo il capitalismo: La persona, come protagonista di partecipazione e riscatto del lavoro dignitoso, quello che realizza, cambia le imprese, il territorio, le relazioni e i rapporti sociali, quello che giorno dopo giorno, rende più umani.
Sapere è libertà, anche di scegliere. Altrimenti polarizzazione opportunità e disuguaglianze. Valorizziamo con le nostre decisioni audaci, i lavori, le imprese, i corpi sociali e politici i territori che sono prima di tutto belle comunità umane. Dove non si smetta mai di crescere perché la formazione è un diritto, un dovere. Il miglior luogo di lavoro è quello dove la sfida progettuale è alta non solo perché l’ansia che ne consegue è grande ma perché la si compie insieme e con gli strumenti migliori: la migliore qualità di formazione. Si sceglie di andare o di restare, dove si sta bene e ci si mette in gioco. Dove ci sia una zona franca dalle vecchie regole del gioco: il servilismo e le buone conoscenze. Schiacciate una volta tanto dall’impegno, dalla competenza, dal buonsenso nutrito dal senso critico, ma soprattutto dove vi sia spazio di cura. Lo spazio che abilita sfide cooperative: quella di lavorare insieme, tutti, meglio e per questo, meno. Occuparsi dell’altro, del contesto, del tessuto delle relazioni. Bisogna battere i modelli manageriali che agevolano l’abbandono di cuore e cervello fuori dai cancelli, con la riconsegna all’uscita e con in mezzo qualche banale e strapagata indagine sul clima. Si vive volentieri, il lavoro edificato su quella vitalità fatta di azioni invisibili che rendono più forte, perché più giusta, una comunità. Il lavoro è anche relazione e ritessere le comunità del lavoro è fondamentale proprio per ricostruire il nuovo senso del lavoro. Serve intelligenza sociale dell’impresa. L’impresa che pensa è un motore sano di crescita e democrazia. Ora come non mai, perché abbiamo l’occasione di farci domande più sincere a cui non ripetere vecchie risposte autoconsolatorie.