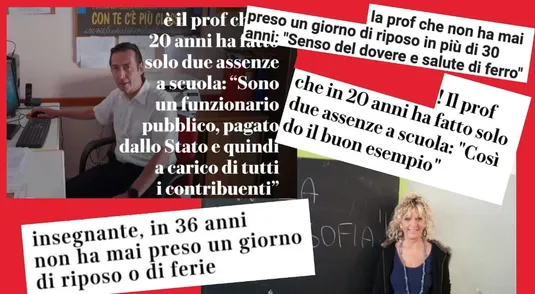«E la vita, la vita / E la vita l’è bela, l’è bela / Basta avere l’ombrela, l’ombrela / Ti ripara la testa / Sembra un giorno di festa». Che canzone sciocca, senza senso, così passata di moda. Eppure la ascoltate e sembra tirarvi su davvero, non come le lagne prime in classifica di oggi che parlano solo di problemi e tormenti. I cantanti urlano tutti, non si capisce cosa dicono, fanno dei gargarismi strani e straziati. Oggi se non hai un bel problema non ti si fila nessuno, lo dimostrano i continui coming out, i primi in classifica che sbandierano malattie rare o tragedie psichiche; è un trend in voga come non mai: se non soffre non è arte.
Sciocchezza enorme, di solito è vero il contrario. Solo stando bene ed essendo ben centrati si fa arte come si deve, si cambia pure la vita agli altri. Mi ricordo di musiche ironiche e leggere che mi hanno ispirato piccole rivolte, come quando mi licenziai dopo aver visto il settantenne Iggy Pop avere più vita di quanta ne potessi avere io, giovane usurato da un lavoro che mi rendeva infelice.
Mi sembra che facciamo tutti una vita senza la considerazione dell’imprevisto. Viviamo alla giornata, pieni pieni di lavoro, la pratica filo-religiosa che ha sostituito la fede nelle nostre vite. Alla messa no, in palestra sì. In meditazione no, in call perenne sì. Sempre più spesso mi capita di sentire la gente che quando esce da un bar o da un negozio, invece che salutare col buongiorno, saluta con «buon lavoro». Credevo fosse una pratica solo milanese, attecchita lassù in quella terra che già in antichità si formò come punto di ristoro dei commercianti verso e dalla Svizzera; invece la trovo ormai estesa in tutta Italia, quasi come la piaga linguistica del «piuttosto che» detto a sproposito.
Augurare all’altro buongiorno significa anzitutto gentilezza disinteressata, «buon lavoro» è invece così formale e riduce anche la pratica dello svago al minimo termine della produzione; mi fa pensare solo a cose tristi: il commercialista, l’Inps, il 740. Siamo il nostro lavoro ormai. E il nostro lavoro, almeno in Italia, di solito è pagato poco. Quindi siamo poco? Attenti perché basta un attimo per convincersene.
Ho amici quarantenni che tentano di far carriera e altri che non riescono a farla, di solito donne, che lavorano più degli uomini e vengono pagate meno. Non fanno altro che lavorare, sono sfranti di lavoro, c’hanno l’ansia di non valere abbastanza perché al lavoro vengono continuamente vessati e sfruttati, augurargli buon lavoro invece che un buon giorno mi sembra un chiodo da aggiungere alla loro croce. Che poi fossero dei lavoratori che con tutto quel lavoro si emancipano, fanno un upgrade sociale. Ma quando mai? Di solito quelli che lavorano così tanto riescono a malapena a pagarsi le spese e le bollette. Sono insicuri e infelici.
Quindi che fare? Buttatevi sulle canzoni vecchie: «Sempre allegri bisogna stare che il nostro piangere fa male al re». Oppure su qualche rara e nuovissima perla come “Vita magica” del geniale Martelli: «Perché lavori se poi godi solo a metà / Perché lavori se poi muori che lavori a fa’?». Lavorare e fischiettare, apparentemente in contraddizione, dovrebbero essere più spesso accomunati. Se quando fate il vostro lavoro riuscite a farlo, vuol dire che siete felici, che è adatto a voi. Altrimenti c’è un problema.