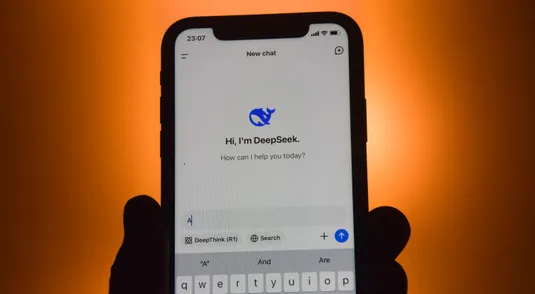All’indomani delle elezioni Dorne è andato più a fondo e ha esaminato l’impatto delle importazioni cinesi sulla scelta di voto. Nelle regioni americane in cui negli ultimi anni le importazioni di prodotti cinesi sono fortemente aumentate, gli abitanti sono stati più sensibili al richiamo di Trump. Negli stati chiave della Carolina del Nord, della Pennsylvania, del Michigan e del Wisconsin, per ogni punto percentuale di aumento di importazioni cinesi c’è stato un aumento di due punti percentuali del voto per Trump rispetto ai risultati ottenuti da George W. Bush nel 2000. La conclusione? Se le importazioni cinesi fossero state la metà tra il 2002 e il 2014, probabilmente Hillary Clinton avrebbe vinto.
Dunque Trump, che pur con la Cina è in debito, ha ragione di prendersela con Pechino in nome di tutta una generazione perduta di lavoratori. Peccato però che le dichiarazioni di guerra commerciale del presidente eletto arrivino a tempo scaduto. Troppo violente. Troppo tardi. Il danno è stato fatto in passato e non è rimediabile. Perché negli ultimi dieci anni la Cina è cambiata radicalmente. E le misure economiche di contenimento che avrebbero potuto funzionare all’epoca di Bush Junior (che vi rinunciò dedicandosi invece all’invasione di Iraq e Afghanistan) adesso finirebbero solo per essere controproducenti.
DA OPERAI A INVESTITORI
La Cina non è più la Fabbrica del Globo. Lo è stata per un quarto di secolo, attirando aziende storiche sia in Europa che negli Usa con quei salari bassissimi e quelle condizioni di investimento di estremo favore. Ma si trattava solo di uno stadio dello sviluppo industriale del Paese, da anni giudicato insostenibile dagli economisti. La Grande Crisi del 2008, con il crollo della domanda globale di beni, ha accelerato il passaggio a quello successivo, formalmente annunciato da Pechino nel 2009, verso un’economia basata sul consumo e sugli investimenti e solo parzialmente sulle esportazioni.
L’obiettivo della nomenclatura è portare la Cina su un percorso di crescita sostenibile nel lungo periodo. Costi quel che costi nel breve. Così negli ultimi dieci anni la crescita economica si è dimezzata, passando dal 12,7 per cento del 2006 a circa il 6 per cento attuale, causando tra l’altro un drammatico rallentamento del commercio globale. Il contributo delle esportazioni al prodotto interno lordo è passato dallo sfiorare il 36 per cento dieci anni fa a meno del 20 per cento l’anno scorso. Nello stesso periodo però la ricchezza del cinese medio è raddoppiata, il settore dei servizi ha superato quello industriale come contribuzione al Pil e, negli ultimi due anni, fusioni e acquisizioni all’estero hanno conosciuto un’impennata raggiungendo nel 2015 un valore complessivo di 5mila miliardi di dollari. In altre parole, la Cina di oggi ha bisogno di esportare molto meno di quella di ieri per continuare a crescere perché ha preso a investire e consumare a rotta di collo. Con la controindicazione però che il debito pubblico è esploso passando dal 160 per cento del Pil nel 2006 al 282 per cento odierno.
UNA TRANSIZIONE DIFFICILE
Certo il passaggio dalla Cina 2.0 alla Cina 3.0 non è stato e tutt’oggi non è indolore. Non per la Cina, che si ritrova ancora con un eccesso di produzione di beni. Non per il resto del mondo, che se li vede scaraventati contro a prezzi bassissimi. Secondo un’indagine del Wall Street Journal, gli aiuti di Stato forniti da Pechino a oltre 3000 aziende quotate in Borsa sono aumentati del 30 per cento tra il 2014 e il 2015.
Oltre il 40 per cento delle fabbriche d’acciaio sono in perdita. Pechino dovrebbe ridurre la produzione ma rimanda la decisione nel tentativo di non aumentare il tasso di disoccupazione e perdere il consenso popolare. Trump o non Trump, gli Usa stanno già reagendo. Solo nei primi mesi dell’anno sono partite una decina di indagini per dumping o aiuti statali verso aziende cinesi. E sempre quest’anno il dipartimento del Commercio americano ha imposto tasse del 266 per cento su acciaio importato dalla Cina dopo che il colosso dell’acciaio US Steel ha perso oltre un miliardo e mezzo di dollari e ha dovuto chiudere le fornaci del Sud, licenziando migliaia di operai.
LA GUERRA DELL' iPHONE
Ma a dichiarare una vera e propria guerra commerciale contro la Cina non è chiaro chi si farebbe più male. Secondo il Peterson Institute for International Economics (che è però un think-tank ultra liberista) una guerra commerciale con la Cina farebbe salire la disoccupazione a quasi il 9 per cento nel 2020 rispetto al 4,9 di oggi. E se Trump mantenesse le promesse su Cina (dazi del 45 per cento) e Messico (dazi del 35 per cento) la California perderebbe da sola 640mila posti di lavoro.
Resta il fatto che gli Usa sono il più importante mercato di esportazione cinese (e per esserlo basta una quota del 16 per cento): un aumento improvviso dei dazi peserebbe non poco sulle tasche dei consumatori in un momento di probabile rialzo dei tassi di interesse.
Senza contare che la Cina non rimarrebbe a guardare. Il China’s Global Times, un quotidiano portavoce del governo, ha fatto sapere che gli ordini dei Boeing potrebbero essere rimpiazzati con quelli di Airbus e che anche le automobili made in Usa e, soprattutto gli iPhone - tutti assemblati in Cina - potrebbero subire un forte contraccolpo. Per la Apple sarebbe una doppia batosta. Dal punto di vista produttivo il costo dell’assemblaggio in Cina ammonta solo al 4 per cento dei costi totali. Spostare l’attività in Usa sarebbe impensabile e altrove comunque dispendioso. E comunque Pechino è ormai capace di produrre da sola smartphone qualitativamente simili a quelli Apple. Ma ancora peggio sarebbe la perdita sull’altro fronte, quello dei consumi: i cinesi comprano due volte il numero di iPhone acquistati da americani ed europei insieme.
Per capire la velocità dell’accelerazione dei consumi cinesi nell’ultima decade basta osservare i dati della festa del consumismo cinese, il giorno dedicato ai “Single”, l’equivalente del Black Friday e del Cyber Monday in America. Nel 2009 le vendite complessive online ammontavano a meno di 200 milioni di dollari. Quest’anno hanno superato i 18 miliardi, contro i 5 miliardi registrati durante entrambe le festività Usa. In altre parole, non solo l’operaio americano è stato da tempo rimpiazzato da quello cinese (che è ora a sua volta rimpiazzato da quello vietnamita). Oggi rischia di esserlo sempre di più anche il consumatore.
COMPUTER, NON OPERAI
Anche a volerne accettare le conseguenze economiche, è improbabile che un’eventuale Grande Vendetta riporti i posti di lavoro lì dove sono stati perduti, spiega Edward Alden, fellow presso il Council on Foreign Relation. I telai delle fabbriche di tessuti in Carolina del Nord, ad esempio, sono andati in Cina anni fa e ormai hanno lasciato anche la Cina per il Bangladesh e il Vietnam.

«Quei lavori sono persi e non torneranno: i dazi non cambieranno la situazione». Insieme alla Cina anche il mondo è cambiato. Il vero nemico degli operai americani di oggi non sono più le fabbriche cinesi ma i robot americani. Cina o non Cina «la rivoluzione robotica sta per cominciare», spiega un report della società di consulenza Boston Consulting. Entro il 2025 i robot svolgeranno un quarto delle mansioni in ogni settore manifatturiero con benefici per la produttività aziendale. Secondo uno studio della Ball University se i livelli di produttività del 2000 fossero applicati ai livelli di produzione del 2010, gli Usa avrebbero avuto bisogno di 21 milioni di lavoratori anziché dei 12 attuali.
LA FINE DELL'ORDINE AMERICANO
Nel vano tentativo di riconquistare posti di lavoro rinchiudendosi in uno splendido isolamento, ciò che Washington perderebbe di sicuro è la sua leadership politica, oltre che economica, sul resto del mondo. Rischia di dichiarare da sola la fine dell’ordine mondiale americano nato sulle ceneri della Seconda guerra mondiale e durato settant’anni. Nell’idea di Obama il TPP (Trans Pacific Partnership) che Trump ha annunciato di non voler siglare, non era tanto un ulteriore trattato di libero scambio quanto la firma di un’alleanza tra l’America e i principali paesi asiatici in versione anti cinese. In un mondo in cui statistiche e grafici hanno in parte sostituito fucili e cannoni, la dirigenza americana sperava che un trattato all’apparenza solo commerciale potesse trasformarsi in una potente arma politica: stabilendo standard e condizioni di scambio avrebbe obbligato la Cina ad adeguarsi, evitando la creazione di regole e istituzioni proprie. Cosa che Pechino aveva già cominciato a fare l’anno scorso con la fondazione dell’Aiib, la Banca asiatica per le infrastrutture e gli investimenti, una sorta di rivale della Banca mondiale.
Se l’America abdicasse al suo ruolo di difensore del capitalismo globale che tanti consensi riscuote ancora in Oriente e nei paesi in via di sviluppo, la Cina non potrebbe non prenderne lo scettro. E sarebbe difficile per i paesi asiatici resistere al suo abbraccio e per il Giappone non riaprire la partita del nucleare. L’Australia è stata il primo Paese a rendere omaggio a Pechino e al nuovo ordine asiatico. All’indomani delle dichiarazioni di Trump sul TPP Canberra ha annunciato che lavorerà a favore della conclusione della Partnership economica regionale abbozzata dalla Cina in sostituzione del TPP con 16 stati dell’Asia e del Pacifico, tra cui Peru e Cile.
Per il mondo, il rischio di un domani non lontano, è che nel diventare uno dei leader di una comunità mondiale sempre più disaggregata, la Cina non venga cooptata - come vorrebbe l’Occidente - nelle sue istituzioni e obbligata alle sue regole del gioco ma che finisca per cooptare le altre nazioni in un sistema di ideogrammi e accordi da lei dettati. All’alba di un secolo sempre più cinese.