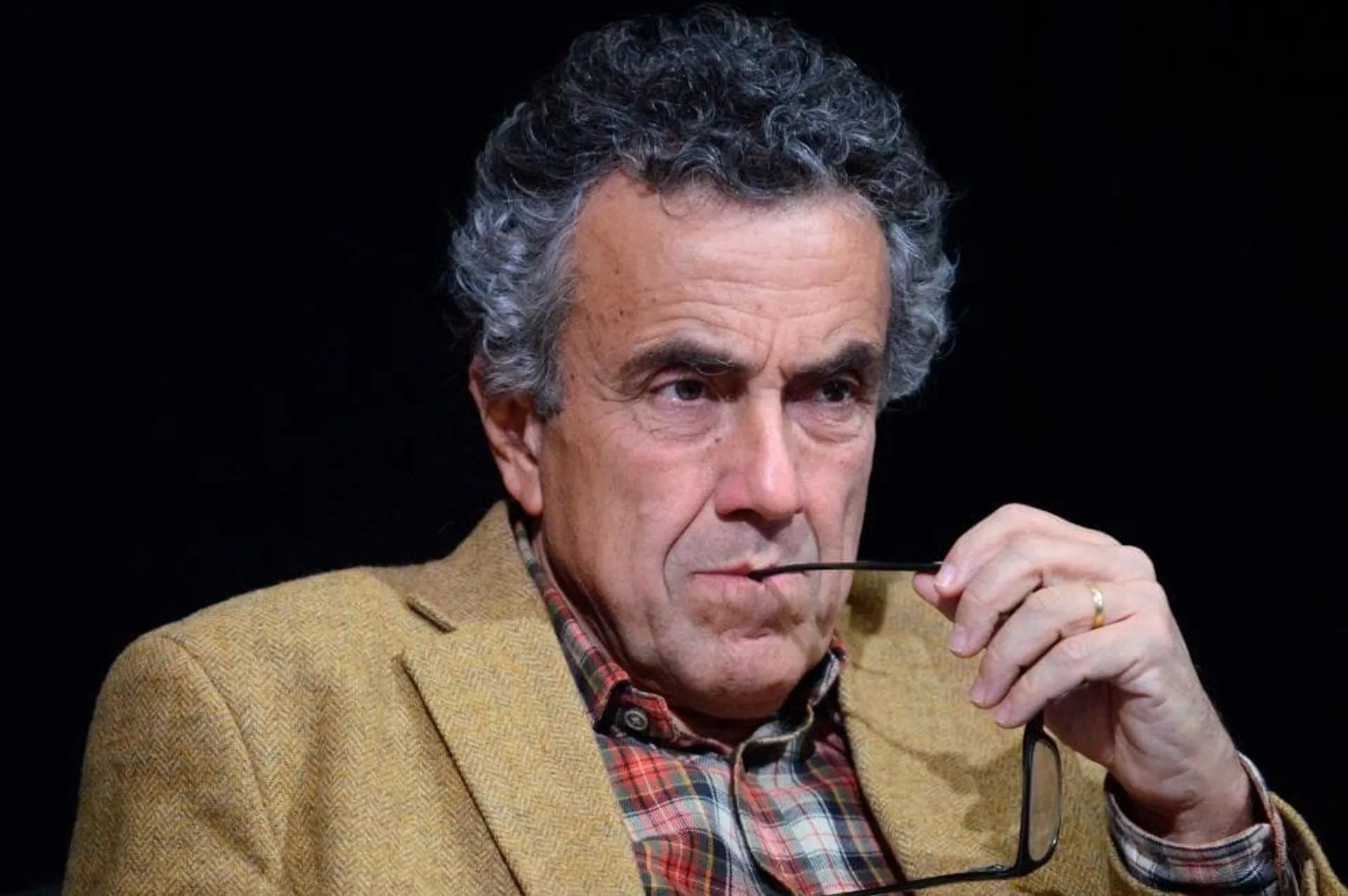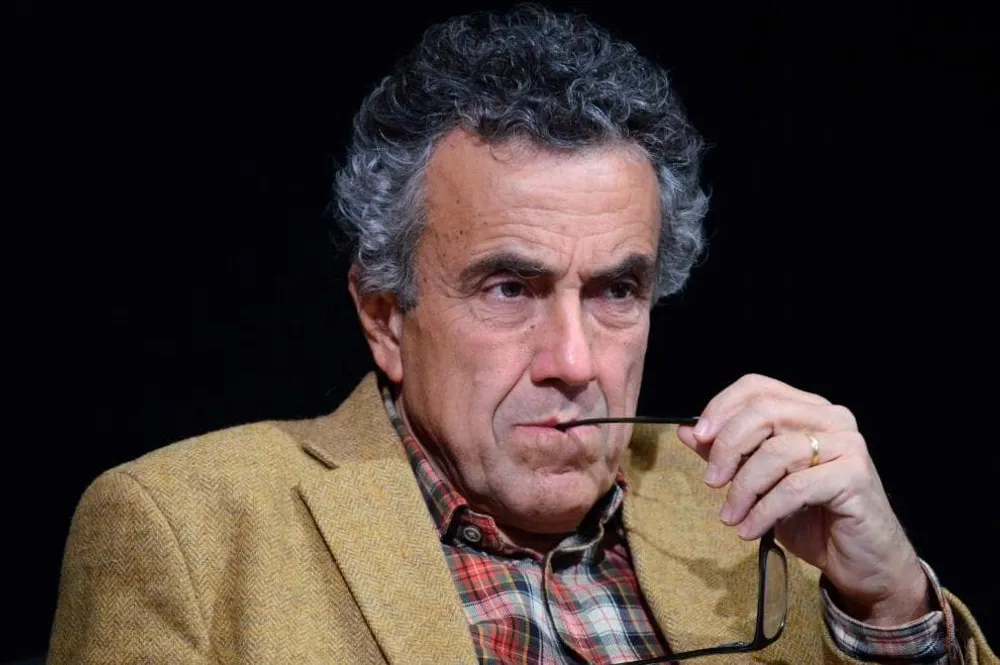
Il settimanale britannico, indicando nel 2018 quella causa scatenante, non scopriva nulla di nuovo. Ma aveva il pregio di riconoscerlo. Sin dal 2005, negli Stati Uniti, Karen Stenner aveva visto montare una “dinamica autoritaria”, indotta da un diffuso senso di minaccia a norme e valori delle comunità da parte di crescenti “diversità” ed eterogeneità. Era un aspetto di quella “disuguaglianza di riconoscimento” che è andata lievitando nelle aree marginalizzate dell’Occidente: la percezione da parte di vaste fasce di popolazione che il proprio ruolo, i propri valori, la propria identità siano disconosciuti dalla cultura dominante e dalle élites, che la loro voce sia ignorata. Un fenomeno che molteplici studi ci hanno ora descritto in profondità. Con quella disuguaglianza si sono intrecciate e reciprocamente alimentate, in tutto l’Occidente, le due altre forme di disuguaglianza: nell’accesso ai servizi fondamentali (scuola, salute, mobilità, cultura) e nella distribuzione di reddito e ricchezza. Con l’arresto della loro discesa e spesso peggioramenti anche forti, sin dall’inizio degli anni ’80; la creazione di vaste aree di povertà; il prolungato declino economico e sociale, relativo o assoluto, delle popolazioni di aree marginalizzate, soprattutto rurali o periferiche.
Nel 2008 tutto ciò era già abbastanza chiaro, tanto che a Bruxelles, sotto l’impulso di una leader socialdemocratica polacca e Commissaria Europea, Danuta Hubner, ben consapevole dei rischi di queste tendenze, le mettemmo a fuoco e con Anthony Atkinson, Andres Rodrigues Pose, Philip McCann e tanti altri suggerimmo un cambio di passo alla politica europea nel Rapporto “An Agenda for a Reformed Cohesion Policy”. Non solo rimettendo al suo centro la giustizia sociale, ma proponendo, in linea con le intuizioni di Jacques Delors, un metodo di «politica rivolta alle persone nei luoghi» che ricostruisse le arene di confronto acceso dove vulnerati e vulnerabili possano contare. Il cambio di passo non c’è stato, o è stato parziale e comunque incapace di intaccare le tre disuguaglianze. E così la furia è cresciuta. Di nuovo, nell’intero Occidente. E si è manifestata non solo con forme aggressive, di piazza e strada, ma anche nelle urne. È quella che ancora Rodrigues Pose fotografa nella “Geografia dello scontento”: la correlazione geografica fra declino economico-sociale e voto contro l’Europa, contro gli “esperti”, contro élites cosmopolite e europeiste, finanziarie e culturali, «che fanno i propri interessi». Una correlazione non dissimile da quella Usa fra voto a Trump e appartenenza a territori rurali o con minore istruzione.
E allora verrebbe da dire: non perdiamo più tempo a capire le cause. Sono evidenti, dimostrate, addirittura previste. Affrettiamoci piuttosto a rimuoverle. Giusto. È quello che dobbiamo fare con urgenza, prima che, in ogni paese a suo modo, simili furie anti-democratiche lievitino ancora, per ora in parte nascoste ma anche fortemente alimentate da angoscia e ferite di Covid-19. In fondo, la classe dirigente che governa l’Europa sembra averlo capito, se guardiamo al linguaggio della presidente von der Leyen, alle decisioni assunte o annunziate, agli obiettivi fissati: prima ancora di “verde” e “digitale”, la missione primaria della Recovery and Resilience Facility è indicata nella «coesione economica, sociale e territoriale». Ma il fatto è che qui in Italia (e altrove) non riusciremo a reagire se non vi sarà sufficiente consenso sulla diagnosi che ho richiamato. La reazione, anche di chi si avverte “di sinistra”, all’assalto di Washington è illuminante. Cavarsela con lo squilibrio mentale e demoniaco di Trump o con la barbarie dei “bifolchi” penetrati nel Senato Usa rivela, ha scritto Alessandro Portelli, il desiderio di «dire che noi non c’entriamo niente, di non mettere in discussione la normalità, [quando] invece è stata proprio la normalità di ieri a preparare il disastro di oggi». Una normalità fatta di gravi ingiustizie sociali, economiche e di riconoscimento. Ecco il punto. Prima di tutto, comprendere la natura multidimensionale delle disuguaglianze, come ce la descrive l’articolo 3 della Costituzione: «Ostacoli al pieno sviluppo della persona umana», che è fatto della soddisfazione di bisogni e aspirazioni, di dignità e comprensione, di reciprocità. E poi capire che l’aggravarsi di quelle disuguaglianze non è il frutto di eventi fuori del nostro controllo, bensì dell’egemonia culturale e delle politiche neoliberiste dell’ultimo quarantennio.
Attenzione. Non si tratta solo, ma anche, dell’impoverimento dell’impresa alla massimizzazione del suo valore patrimoniale, dell’occultamento di scelte politiche dentro decisioni tecniche pseudo-oggettive, di politiche pubbliche intenzionalmente cieche ai luoghi, dell’abbandono delle piattaforme digitali al controllo di pochi monopoli, del disinvestimento nelle pubbliche amministrazioni, ma anche della negazione a cittadini e cittadine di strumenti di confronto dove tutti possano far sentire la propria voce e contare: «Votate e, se non vi piace dove vivete, usate la vostra “libertà” e andatevene», è lo slogan di chi predica che «non c’è alternativa». Nel discutere le radici della vicenda americana, Ernesto Galli della Loggia, oltre alle disuguaglianze economiche, sottolinea quelle di riconoscimento. E indica gli effetti di estraneazione prodotti in «strati popolari o tra la piccola borghesia semi-scolarizzata» di «gigantesche [e rapide] trasformazioni ideologiche e del costume». Non lo si attacchi, come se stesse dicendo che diversità e libertarismo portati da quelle trasformazioni sono sbagliati. Si legga invece il seguito, quando egli sottolinea che questo cambiamento è avvenuto attraverso un dibattito pubblico in cui la voce di quegli strati «è stata soverchiata … perché priva della presentabilità e quindi dell’autorevolezza» della controparte colta, in un contesto di indebolimento dell’istruzione. E si pensi, all’incontrario, al lavorio profondo del Pci e di una parte importante del mondo cattolico nel costruire, in Italia le basi affinché le epocali riforme civili degli anni Settanta fossero espressione di larga parte del popolo, non solo delle élite.
Affrontiamo, allora, le molteplici disuguaglianze con misure dirette, come quelle che avanziamo nel libro collettivo del Forum Disuguaglianze Diversità “Un futuro più giusto” (Il Mulino): per liberare e accedere ai saperi; per trasferire poteri a donne, giovani e lavoro; per ricostruire arene di democrazia nella società e nelle organizzazioni. «In questo modo - scriviamo - la “frontiera politica” fra “noi” e “loro” cessa di riguardare, come nel progetto autoritario, una fittizia radice identitaria, e si trasforma in una strategia di cambiamento che avrà i suoi avversari in chi non vuole cambiare. È la strategia che diviene il discrimine, non pregiudizievoli e ingiustificabili muri identitari». Questa è la sfida. L’Italia se la gioca nel Piano di Ripresa e Resilienza, la prima possibilità di una strategia-Paese dopo anni e anni. Battendo il politicismo di queste ore, si dia vita al confronto. Si dia a donne e uomini di tutti i ceti sociali e di tutte le pieghe di quest’Italia rugosa l’opportunità di migliorare il Piano con i propri saperi, di contare nelle forme organizzate che già hanno e col metodo robusto del Codice Europeo di condotta sul Partenariato. I documenti che abbiamo potuto leggere si prestano a questo scopo. Sarà un modo per colmare il divario fra istituzioni e popolo, demolendo l’idea che quel Piano sia una “partita truccata”. Sarà il modo per mobilitare il Paese a realizzarlo.