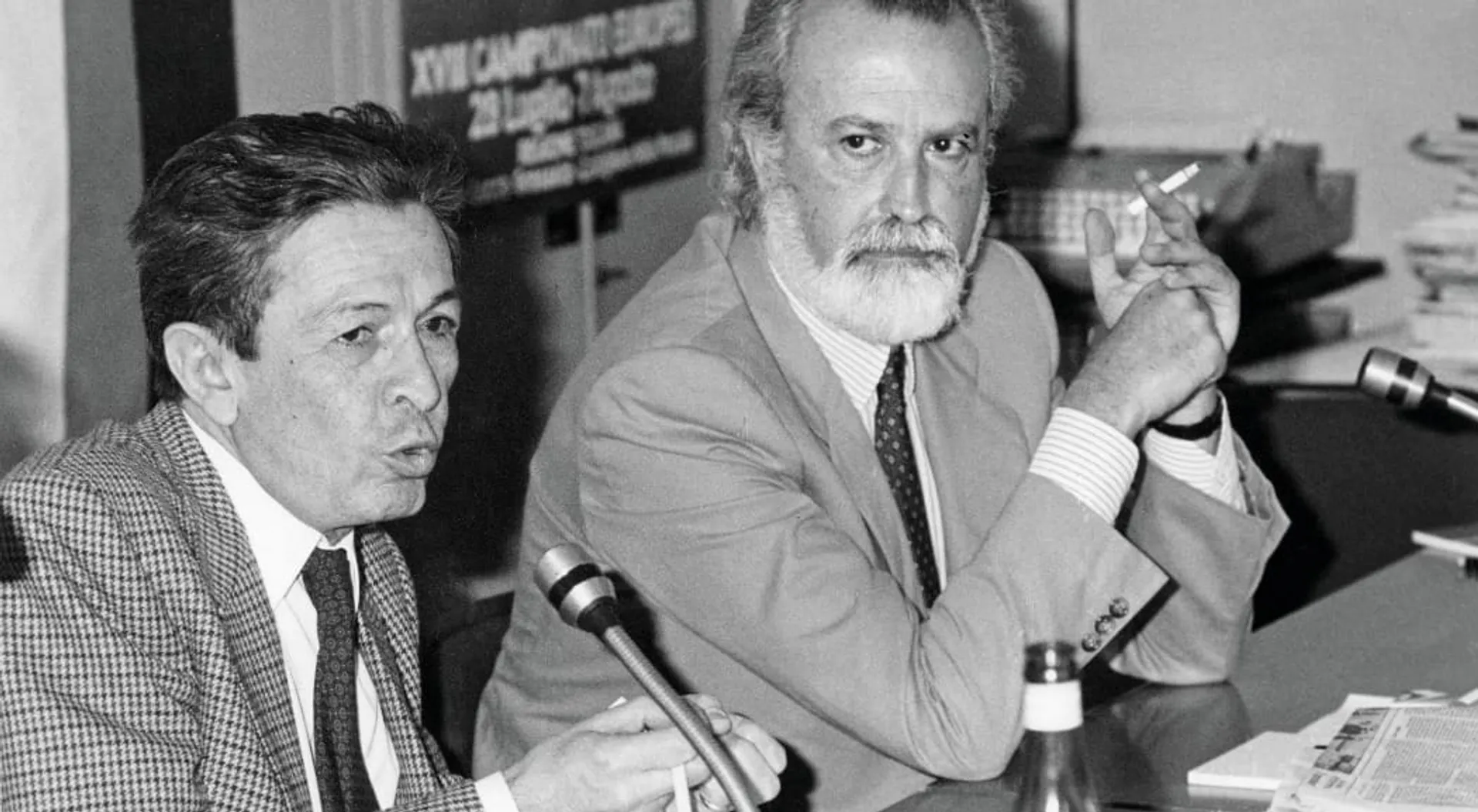«Io andavo ogni giorno in redazione come se andassi a una festa», ha ricordato una volta Eugenio Scalfari. Può sembrare una strana affermazione per chi conosce Scalfari solo attraverso i suoi editoriali asseverativi e solenni o per chi ricorda solo l’immagine del direttore severo, ieratico, capace di fulminare con un solo sguardo una carriera promettente. Ma la dimensione del gioco, del divertimento era parte integrante del suo carisma.
Certo, c’era poco da scherzare nelle riunioni vissute da molti come «un esame universitario da superare ogni giorno». Le discussioni potevano essere accanite fino alle urla e agli insulti, poi quando il direttore interveniva a distribuire torti e ragioni i veterani ammutolivano come i praticanti. Non solo i giovani, anche i giornalisti più anziani ed esperti di lui, che magari avevano visto guerre in tutto il mondo, ne subivano il carisma. E d’altra parte, come ha ricordato Carlo Caracciolo, anche da giovanissimo Scalfari impressionava per quanto fosse «deciso e sicuro di sé».

Così poteva capitare anche a un mostro sacro del giornalismo, inviato su un servizio importante, di trovare, al rientro in albergo dopo cena, un telegramma del direttore. E di chiedere al portiere di leggerglielo ad alta voce, davanti agli altri colleghi, sicuro di sentire un elogio. E invece di sentirsi recitare un rimprovero durissimo. «Mi vedo costretto a rilevare che il tuo pezzo di oggi è veramente deludente, fiacco senza atmosfera...».
Ma insieme c’era la leggerezza, lo scherzo, il gioco. Perché del gioco facevano parte le promesse di promozioni - «sei sulla rampa di lancio», «hai nello zaino il bastone di maresciallo» - che moltissimi hanno ricevuto. E, pur sapendo bene che quasi sempre promesse sarebbero rimaste, comunque facevano piacere.
E le metafore marinare: «la nave corsara» (che è sempre stata la preferita di Scalfari, anche quando i giornali erano diventati delle corazzate), con conseguenti premi e punizione iperboliche: «vi concederò diritto di saccheggio», o «farai nove giri di chiglia sotto la nave».
E c’era il direttore che si occupava della vita privata dei suoi redattori, che li invitava a confidargli i crucci sentimentali, i problemi familiari, le difficoltà quotidiane. Perché non si può lavorare bene se si è infelici e preoccupati. Resta leggendaria la mattina che nello stanzone di “Repubblica” squilla a vuoto il telefono sulla scrivania di un giornalista importante, noto seduttore. Il direttore passa e intima ai presenti: «Non rispondete. Potrebbe essere vostra moglie».
Questo atteggiamento, paterno e insieme materno, aggiungeva qualcosa di inconfondibile al suo carisma già eccezionale di inventore di giornali, editore, direttore, editorialista, intervistatore: una figura assolutamente unica nel giornalismo italiano del Novecento. Cosa ha significato avere un direttore così si è visto nei giorni dell’ultimo saluto, quando chi ha lavorato con lui, grandi firme e tipografi, vicedirettori e dimafonisti, inviati e commessi, tutti hanno manifestato, insieme alla immensa ammirazione per il genio del giornalismo, un autentico sconfinato affetto per la persona.
«Voi dovete essere contenti», «tu devi essere contento», era un altro dei suoi mantra, ripetuto centinaia di volte. E contenti si andava in redazione, mai come se si andasse a un lavoro qualsiasi, ma consapevoli di far parte di un’avventura speciale. Perché nella concezione di Scalfari fare il giornale è un mestiere, con la sua insopprimibile componente artigianale, ma non una professione che si esercita a prescindere dal progetto. Molti ricordandolo dopo la scomparsa hanno tributato gli onori dovuti al grande successo raggiunto dei suoi giornali provando in qualche modo a separarlo dal contenuto politico, civile e culturale, quasi fosse un risultato sì straordinario, ma ottenuto solo grazie a un’eccezionale abilità tecnica. E invece Scalfari ha sempre teorizzato e praticato un principio di fondo, tenacemente ripetuto nei decenni: «La struttura editoriale e la linea politica del giornale sono tutt’uno».

Come ha scritto Alberto Asor Rosa, «Eugenio ha perseguito con incredibile energia e una forza intellettuale e vitale assolutamente eccezionale una battaglia inesausta per riuscire a fare dell’Italia un Paese democraticamente maturo, rispettoso delle regole, fermo sui principi, operoso e civile, e in definitiva, puramente e semplicemente, un Paese normale, almeno secondo il canone democratico occidentale».
Una battaglia con molti nemici, che tra l’altro hanno spesso tacciato questa ispirazione di fondo di essere elitaria e antipopolare. Un’accusa doppiamente sbagliata. Perché l’essere élite era ammesso, anzi apertamente rivendicato. E perché l’oggetto delle critiche scalfariane non era certo il popolo, ma la borghesia italiana, autentico ventre molle del Paese, mai capace di farsi classe dirigente a differenza delle borghesie che Scalfari ammirava, la francese e l’inglese prima di tutte. Se il programma di contribuire a “formare la classe dirigente del futuro” poteva forse sembrare ambizioso, di certo non si può dire che non fosse necessario.
Oggi che di classe dirigente non è nemmeno il caso di parlare e che, lontani i giorni del successo, i giornali lottano semmai per la sopravvivenza, si resta comunque con il sentimento di aver fatto parte di un’impresa straordinaria, bella, e importante, e di averlo fatto assieme a lui con passione e impegno, e in allegria.
Durante i festeggiamenti per i suoi novant’anni uno dei migliori giornalisti che hanno passato tutta la vita professionale nei suoi giornali, nel fargli gli auguri, rievoca: «Direttore, quante volte mi hai detto “Hai il bastone di maresciallo nello zaino!”». Negli occhi di Scalfari passa un lampo: «Ci siamo divertiti, eh?».
Grazie, Eugenio, per averci invitato alla festa.