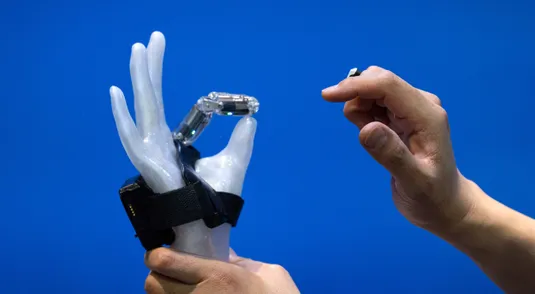Qualunque racconto, qualunque narrazione, è intessuta di realtà. Più volte, nel corso di questi millenni in cui si è ragionato sul mistero del narrare, ci si è spinti fino ad ipotizzare che fosse esattamente la realtà il materiale principale della finzione. Quel patrimonio esperienziale che Fielding già nel 1749, nell’incipit del “Tom Jones”, chiamava “natura umana” e che, nonostante si presenti come una teoria di fenomeni ripetitivi e sempre uguali: amarsi, odiarsi, tradirsi, mentire, fuggire… tuttavia nella mente di un narratore diventa esperienza unica e irripetibile. Questo rapporto mediatico, ma anche medianico, tra l’ordinario e lo straordinario sarebbe il motivo per cui abbiamo bisogno della letteratura. L’idea sarebbe di considerare la vita propria e le vite altrui come un immenso archivio di fatti, di cose che accadono, di piccoli grandi avvenimenti salienti. In tempi di pandemia per esempio è assai difficile non tenere conto di quanto proprio le pandemie nel corso dei millenni abbiano costituito un vero e proprio argomento, quello che gli specialisti chiamerebbero topos letterario. Basti pensare al percorso che da “La Guerra del Peloponneso” porta a “La Peste” di Camus, attraverso il “Decamerone” o “I Promessi Sposi”.

Ma, ritornando a Fielding e al suo “Tom Jones”, le coordinate diventano chiare se si afferra una metafora gastronomica attraverso la quale il genio inglese prova a specificare questo fenomeno di dipendenza e trasformazione di una realtà schietta e prosaica che diventa narrazione specifica, materiale complesso. La natura umana, afferma Fielding, non è altro che una bistecca. La stessa che si può trovare in tutte le cucine, può diventare una suola o un manicaretto, dipende da chi la cucina. Lo scrittore dunque è uno chef della realtà. È un minatore esperto che sa trovare la pepita d’oro, la vena preziosa, nell’immensa miniera dei fatti comuni. Un archivista creativo che reperisce, capisce e fa parlare documenti apparentemente inerti. Una strada, un materiale precipuo, della narrazione, consisterebbe, dunque, in una mentalità specifica che riconosce come malleabile un materiale che a tutti gli altri appare come rigido e immutabile. Il mestiere del narratore risulterebbe nell’acquisire questa mentalità, questa visione del mondo, ed essere in grado di supportarla con un’adeguata competenza tecnica. E la competenza tecnica del narratore è anch’essa paradossalmente, seccamente, banale: sintassi e vocabolario. Cioè essere in grado di non rovinare la nostra metaforica bistecca con la fiamma sbagliata o con un condimento di cui non si conoscono le caratteristiche. In presenza di questi due punti chiave: mentalità narrativa e competenza tecnica, l’unica cosa che non serve è l’inesistente. L’illusione cioè che narrare consista nell’inventare qualcosa che non esiste.
Chi ha letto abbastanza sa bene che quanto più si coltiva questa illusione tanto più si rischia di imbattersi in materiali che ci illudevamo di avere inventato noi e che invece sono in campo da millenni. Tanto vale farsene una ragione e capire fino a che punto questa limitazione apparente sia, al contrario, il motore di tutto. Il realtà leggere meno di quanto si scrive è una sindrome che attanaglia molti “scrittori” dei nostri tempi. Una sindrome che genera gran parte dei qui pro quo collegati alla coscienza di cosa sia arte nella sua consistenza etimologica di artificio. E cioè l’idea che ogni volta si cominci da capo, si riparta dal punto zero, solo perché si considera una perdita di tempo documentarsi su quanto è avvenuto prima. Sarebbe come andare ancora oggi a farsi cavare un dente dal barbiere. Voglio dire che l’evoluzione non consiste mai nella mutazione della sostanza, ma nella modificazione dei metodi attraverso cui quella sostanza si mette in campo. Per intenderci: la scrittura sa fare a meno dell’invenzione ma non della lettura. La scrittura nonostante la lettura si presenta miserevolmente illusoria, passeggera, spesso inutilmente complicata, ma senza complessità. Senza cioè quei riverberi che fanno durare una pagina aldilà della pagina stessa. Chi confondesse la coscienza che scrivere una storia significa anche saper tenere conto delle storie già scritte, con la limitazione alla propria capacità di inventare, semplicemente non è un narratore: è qualcuno che scrive e che non ha il polso della situazione. Ora può senza dubbio capitare che in una contingenza siffatta si possa arrivare a produrre qualcosa di leggibile, ma lo scrittore, come lo chef, come il cardiologo, come il carrozziere, ha il dovere di saper replicare e addirittura specializzare e migliorare il proprio operato. Enfatizzare la libertà creativa dello scrivere e del narrare come dono gratuito significa spesso pretendere un risultato senza sacrifici. Come pretendere di affrontare lo slalom gigante senza i paletti che lo caratterizzano. Mentre scrivere, narrare, è prendersi la propria libertà creativa tenendo perfettamente conto dei paletti.
Un esempio efficacissimo di quanto un grande scrittore possa essere creativo nonostante l’invenzione ce lo da Filippo Maria Battaglia nel suo “Nonostante tutte” con cui Einaudi editore ha deciso di inaugurare la Collana Unici. Si tratta di Unici con i paletti che abbiamo precedentemente messo in evidenza e cioè Unici nell’affrontare il narrare a partire da quella natura umana e dalla capacità di enfatizzare un’esperienza apparentemente comune, o comunque vissuta, reperibile, in un atto narrativo specifico, metaforico, complesso.
Battaglia sa che scrivere è un atto sacrale, una sorta di teca dove la vita che scorre può essere isolata, esposta, e resa rappresentativa. Di “Nonostante tutte” Battaglia non ha inventato una riga, ha comprato la bistecca bella e pronta in quell’emporio esperienziale infinito che è l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Dopo aver consultato, e letto, migliaia di pagine di diari e corrispondenze di donne “qualunque” dell’Italia del dopoguerra, da nord a sud, ne ha estratto, con una strepitosa opera di selezione, la storia di un’unica donna immaginaria. Sempre lavorando con un materiale diaristico di quell’Archivio, Einaudi tempo fa aveva affidato a una scrittrice totale come Evelina Santangelo la cura e la “reinvenzione” del ponderosissimo diario di vita di Vincenzo Rabito e l’aveva pubblicato sotto il titolo di “Terra matta”. L’operazione di Battaglia è tuttavia assai più complessa e ardita, direi uno sviluppo di quella precedente esperienza, perché alla riconnessione di materiali provenienti dalla stessa fonte, sostituisce la rigenerazione di una vita fittizia attraverso l’elaborazione di esperienze reali difformi nel tempo e nello spazio. Tutte le centinaia di donne che hanno testimoniato il loro ordinario in diari, lettere, comunicazioni, sono diventate un’unica donna che testimonia la propria straordinaria esistenza. E quest’unica donna, grazie alla competenza, alla creatività, alla libertà, alla capacità di combinare materiali, appare al lettore credibile, attendibile, fino al punto da risultare inventata.
Un esempio efficace in questo senso è offerto dal mondo dell’audiovisivo dove spesso si raccontano storie fondendo materiali di repertorio differenti, spezzoni derivanti da archivi o cineteche che tuttavia riescono ad offrire un immaginario coerente. Nessuno metterebbe in dubbio la competenza di un regista che oltre a girare le proprie scene sia in grado di rivitalizzare e dare nuovi significati a scene altrui. Esattamente in questo modo si è mosso Battaglia, ottenendo un risultato stupefacente. Il paradosso del fiore finto talmente perfetto che “pare vero” o del fiore vero talmente perfetto che “pare finto”. Esattamente come la letteratura: il prezzo della verosimiglianza è l’estrema elaborazione. Si sembra veri grazie alla finzione. Si può raccontare nonostante la scrittura, ma mai, mai, nonostante la lettura.