Giorgia Meloni vorrebbe un presidente della Repubblica «patriota», se è un omaggio va bene alla ragione sociale del suo partito (Fratelli d’Italia), e ci mancherebbe altro che il garante dell’unità nazionale non sia anche un difensore della Patria. Patria, lo ricordo a Meloni che ama esprimersi in spagnolo, nel romanzo dello scrittore Fernando Aramburu è parola che i baschi traducono con Euskal Herria, indica insieme il territorio e il popolo che lo abita, è appartenenza familiare e destino, maledizione, è “aita” e “ama”, padre e madre, per questo Michela Murgia parlò sull’Espresso di Matria (12 novembre 2017).
In un paese di recente e fragile unità nazionale come l’Italia, ce lo hanno insegnato Giulio Bollati e Carlo Tullio-Altan, il carattere nazionale è stato il prodotto di un lungo processo storico, ma anche un progetto politico e culturale. Patrioti sono stati i risorgimentali, i mazziniani, i garibaldini, i partigiani. Ma patrioti si sono definiti quelli che la Patria l’hanno tradita, l’8 settembre 1943, e l’hanno poi consegnata all’esercito invasore nazista. Patrioti si chiamavano tra di loro gli iscritti alla loggia massonica P2. Patrioti si vorrebbero rappresentare gli esponenti della Lega di Salvini che prima sognavano la secessione della Padania dall’Italia, poi si sono riscoperti nazionalisti salvo presentarsi a Mosca con il cappello in mano a chiedere finanziamenti agli uomini di Putin.

Patriota per patriota, preferisco considerare patriota Giorgio Ambrosoli, un uomo di destra, iscritto all’Unione Monarchica Italiana, che prima di essere ucciso nel 1979 dalla mafia armata dal bancarottiere Michele Sindona lasciò alla moglie Anna Lori una lettera in cui scriveva: «Ricordi i giorni dell’Umi, le speranze mai realizzate di far politica per il paese e non per i partiti: ebbene, a quarant’anni, di colpo, ho fatto politica e in nome dello Stato e non per un partito. Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo creduto (…) Abbiano coscienza dei loro doveri verso se stessi, verso la famiglia nel senso trascendente che io ho, verso il paese, si chiami Italia o si chiami Europa». Oppure la cattolica Tina Anselmi, la ragazza della Repubblica, che da partigiana aveva scelto il nome di battaglia Gabriella, come l’arcangelo Gabriele, portatore di buone notizie, e che da presidente della Commissione di inchiesta provò a smascherare i piccoli uomini della loggia massonica P2, usurpatori di un progetto di rinascita nazionale. Vorrei una figura come lei al Quirinale, mentre candidato, invece, è uno degli adepti di Licio Gelli, la tessera 1816, poi diventato monopolista televisivo, fondatore di un partito tricolore, presidente del Consiglio.
Tra i viventi, considero patriota il generale Giorgio Allori, il 4 febbraio 2022 compirà cento anni, i lettori dell’Espresso lo hanno conosciuto il 25 aprile 2020, in pieno lockdown, quando raccontò la sua storia e mostrò i quaderni della sua deportazione. È stato uno dei 650mila militari italiani che rifiutarono di arrendersi dopo l’8 settembre 1943 ai nazisti, trascinati nei campi di concentramento di mezza Europa per restare fedeli a una patria che intanto si frantumava. Giurò da ufficiale su un piccolo tricolore fatto a pezzetti e nascosto negli abiti, ricomposto nella baracca dei prigionieri: un racconto anti-retorico e emozionante. E patrioti, chissà se Giorgia Meloni sarà d’accordo, sono i nuovi italiani, ancora in attesa di cittadinanza, che affollano i banchi delle scuole e le postazioni delle fabbriche, che aiutano a non morire di vecchiaia il Paese demograficamente bloccato.
C’è attorno a Giorgia Meloni uno strano timore reverenziale, quello che in genere circonda un leader in potente ascesa, su cui sono disposi ad aprire una linea di credito imprenditori, boiardi di Stato, intellettuali, giornalisti, nonostante la pessima figura incassata appena due mesi fa alle elezioni amministrative di Roma. Appare più credibile di Matteo Salvini, più politicamente avveduta nella sua rivendicazione di uno spazio per i conservatori, famiglia politica da sempre negletta in Italia (Giovanni Orsina, La Stampa, 13 dicembre) e perfino più umanamente simpatica, come ha scritto Ernesto Galli della Loggia (Corriere della Sera, 14 dicembre). In pochi si sono interessati a chiederle in cosa consista il modello di presidenzialismo che la presidente di Fratelli d’Italia ha lanciato all’ultima festa di Atreju.
Il presidenzialismo è un fantasma che circola nella società italiana, come dimostrano nelle pagine che seguono i dati raccolti da LaPolis dell’Università di Urbino e Demos nel rapporto “Gli italiani e lo Stato”, arrivato alla XXIV edizione, per la prima volta pubblicata sulle pagine dell’Espresso.
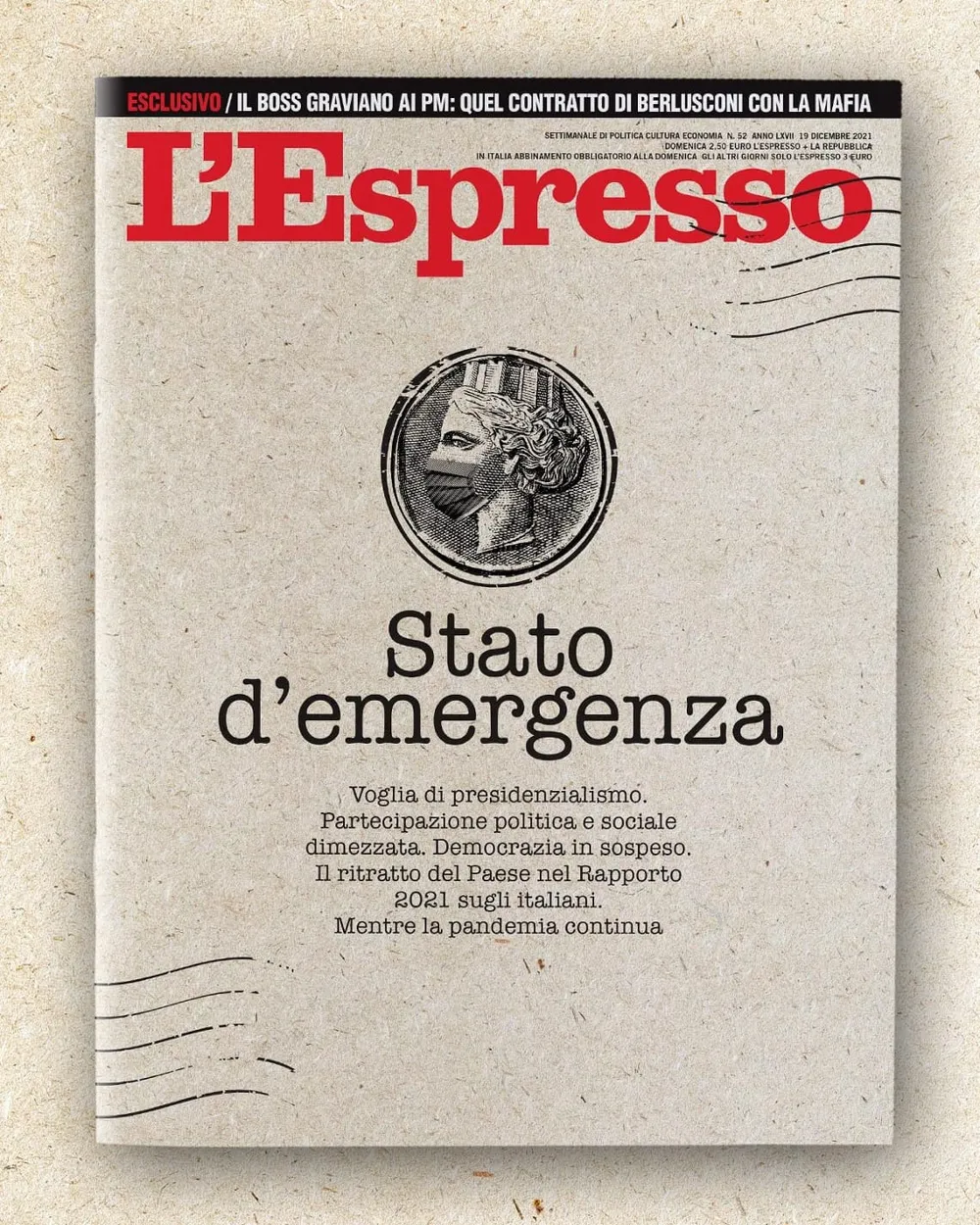
Tre italiani su quattro vorrebbero votare per il presidente della Repubblica, di cui si ignorano poteri, funzioni e limiti. E tre italiani su quattro, la stessa percentuale, non riescono a pensare al futuro. È la «democrazia sospesa» di cui parla Ilvo Diamanti, di cui sono elementi solo in apparenza contraddittori la crescita della fiducia nei confronti delle principali istituzioni (il presidente della Repubblica, il Comune, la Chiesa, perfino i partiti salgono nella considerazione degli italiani) e il dimezzamento della partecipazione politica, sociale e civile. È il ritorno della delega, un dato costante della democrazia dell’emergenza. È la richiesta di un leader forte che fa da sfondo al vento presidenzialista intuito dalla destra. Una domanda che non necessariamente coincide con un modello autoritario, semmai emerge il profilo di una politica paternalista, che si fa carico delle urgenze e delle necessità dei cittadini e che si identifica con le strutture dello Stato. Ma senza i territori, i corpi intermedi, la società civile la democrazia resta una scatola vuota, un simulacro spoglio, o peggio un terreno di conquista.
In Italia parliamo di Paese per non dire la parola Patria, ma intanto nel 2020 e ancora di più nel 2021 che si chiude è tornato una antica conoscenza, lo Stato. Lo Stato nazionale che organizza la sanità pubblica e la logistica dei vaccini, simboleggiato dal generale Francesco Paolo Figliuolo, lo Stato che è chiamato a spendere i fondi europei di Next Generation Eu. Lo Stato sembrava destinato a estinguersi per lasciare il posto alle istituzioni sovranazionali o agli Stati senza territorio come sono gli spazi virtuali dei giganti del web, oggi è l’attore politico che fissa le regole dell’emergenza. Lo Stato dunque è lo spazio privilegiato dell’azione, in Occidente, negli Stati Uniti, nell’Europa dove ritornano gli spostamenti di truppe e i venti di guerra per il controllo dei confini, ma lo Stato è anche l’epicentro della crisi, di tutte le tensioni, delle mancate risposte. È uno Stato in stato di emergenza, un’emergenza che rischia di diventare perenne in presenza di una fragilità di sistema che non è stata riparata e che anzi nelle prossime settimane rischia di accentuarsi.
A Mario Draghi, da più di dieci mesi, è stato delegato il compito di risolvere l’emergenza sanitaria e l’emergenza economica legata alla distribuzione dei centinaia di miliardi del Recovery Fund. Ad assegnargli questo compito, chiamandolo alla guida di un governo di unità nazionale è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una sera drammatica, nel pieno di una crisi politica senza sbocchi, motivando la sua scelta straordinaria con la situazione emergenziale.
Oggi quelle due emergenze non sono esaurite. La campagna vaccinale ha avuto successo, è la diga che viene alzata per bloccare la variante Omicron che terrorizza l’Europa, sperando che la protezione basti a reggere l’onda d’urto della pandemia. Sul fronte economico sociale, il Piano per la Ripresa e la Resilienza (Pnrr) è stato presentato per mesi come la leva salvifica di ogni cambiamento strutturale del Paese: oggi quella comunicazione si dimostra eccessivamente ottimista e rischia di lasciare spazio ai delusi del Pnrr o a chi (a ragione) non si è appiattito su una visione miracolistica dei fondi europei ma ha avvertito che tutte le disuguaglianze sarebbero rimaste nelle pieghe profonde della società italiana. Lo sciopero generale di Cgil e Uil è un primo segnale. Ma è una torsione pericolosissima, perché se il Piano dovesse entrare in difficoltà se ne avvantaggerebbero in campagna elettorale quelle forze che vantano la loro estraneità alla operazione Draghi, come il partito di Giorgia Meloni.
Di questo Stato la destra rivendica la rappresentanza, la guida, la presidenza della Repubblica. E mette in campo il suo nome più divisivo, il patriota Silvio Berlusconi. Una candidatura che procede a colpi di strappi, minacce, qualche ricatto (politico). Per esempio quello avanzato dal direttore del Giornale della famiglia Berlusconi (14 dicembre): se la coalizione di destra non si mostrerà compatta nel sostegno al suo fondatore Salvini e Meloni potranno scordarsi la guida del governo nella prossima legislatura. Per essere più concreti, è già stata fornita ai capi della destra la cassetta degli attrezzi con i mezzi tecnici: votare per Berlusconi con le schede segnate e riconoscibili (Berlusconi, Silvio Berlusconi, S. Berlusconi) per evitare i franchi tiratori, i 101 che affossarono Romano Prodi, ma alla rovescia, questa volta nel centro-destra contro il Cavaliere di Arcore su cui sono in arrivo altri guai (come scrive Lirio Abbate sull’Espresso questa settimana).
In queste condizioni, dalla quarta votazione in poi, quando il presidente della Repubblica si elegge con un quorum più basso, a maggioranza assoluta, si rischia il cupio dissolvi del muro contro muro, con i centristi pronti a fare da sponda determinante per una soluzione qualsiasi, per il Presidente Qualunque. E allora sì che il vento presidenzialista, la richiesta autoritaria, diventerebbe irrefrenabile, nel Paese dell’eccezione permanente, in questo Stato di emergenza.


