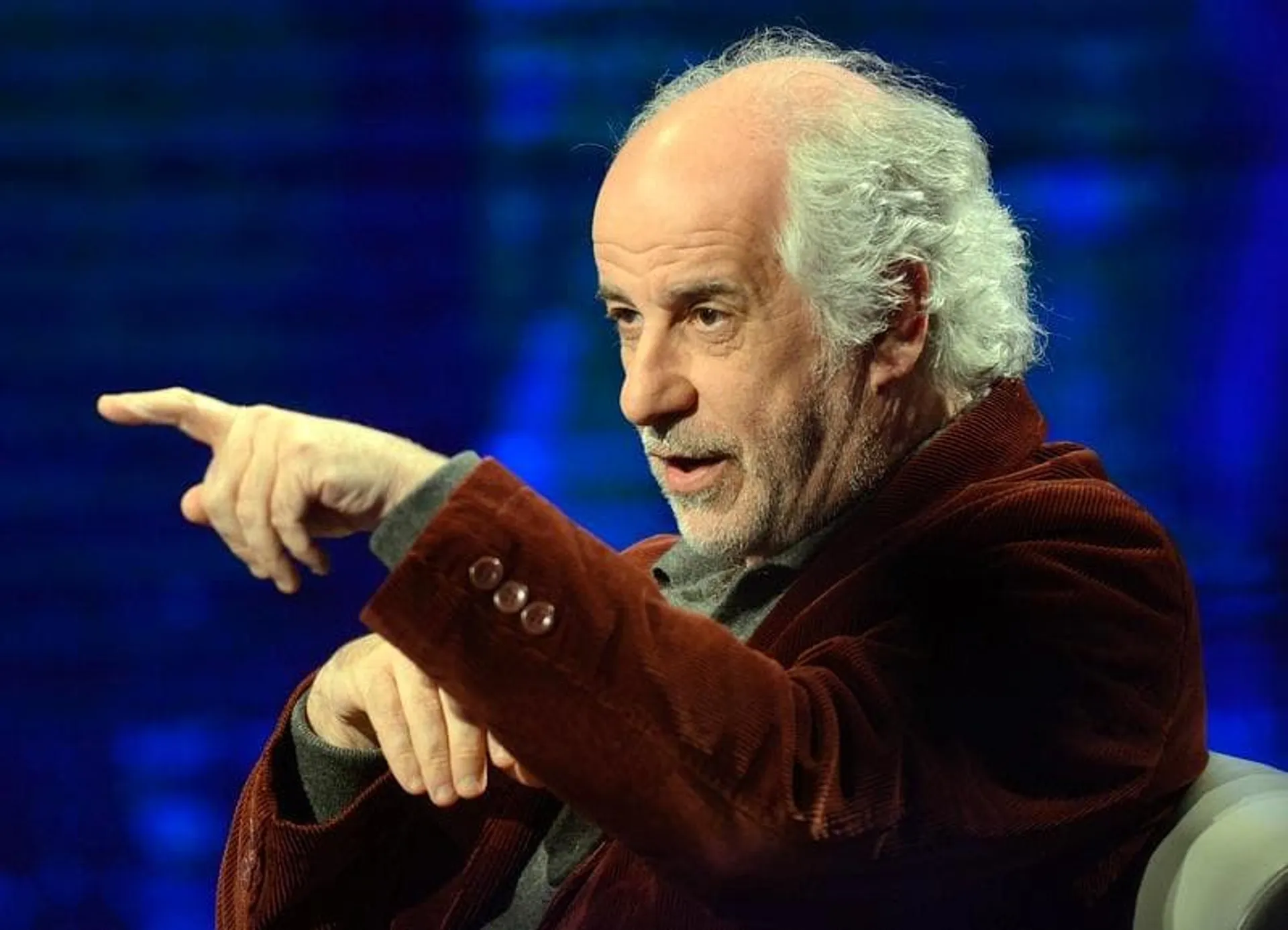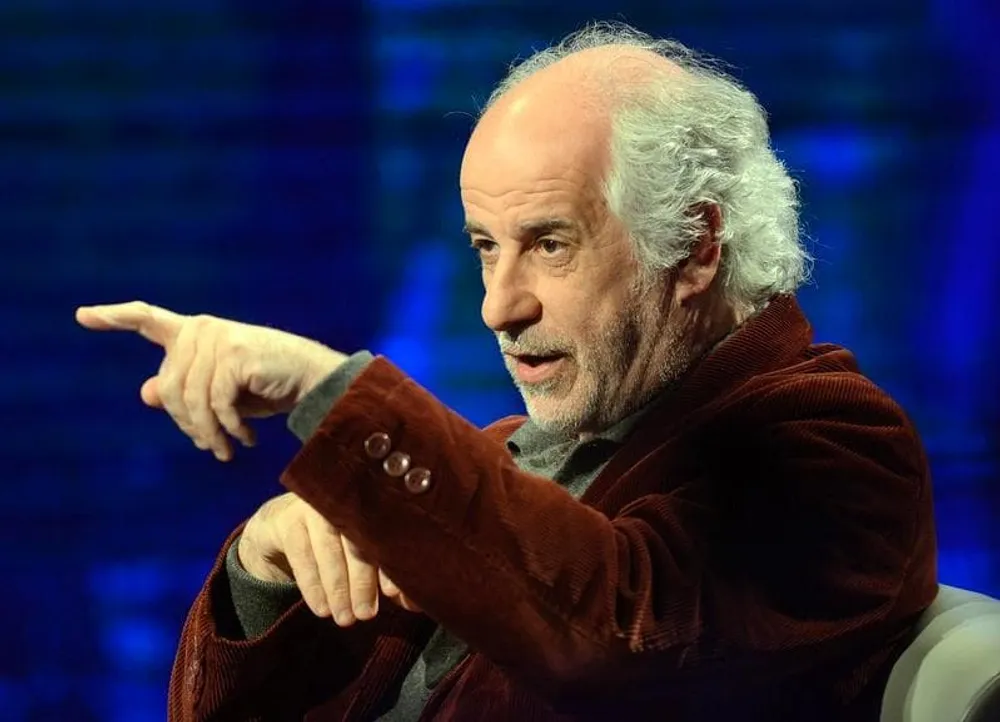
Lo incontriamo in un camerino del teatro Argentina di Roma prima di una delle ultime repliche italiane de “Le voci di dentro” di Eduardo De Filippo, lo spettacolo che presenta da due anni in Italia e all’estero riempiendo immancabilmente le sale. È un testo che Servillo è riuscito a rendere nuovo pur rimanendo fedele a Eduardo, costruendo un’alchimia che rapisce lo spettatore, lo incanta e lo coinvolge in un’operazione di cui avverte gli aspetti creativi.
È così, Servillo? Lei fa un teatro che è insieme suo e dell’autore?
«La sua domanda è per me una lusinga, perché mi fa sentire compreso nelle mie intenzioni, che sono quelle di un interprete che scava dentro il testo, come una talpa. Io mi ritengo un interprete nella misura in cui cerco di risollecitare i valori emotivi e intellettuali di un testo per restituirli vivi in quel magnifico triangolo che si crea ogni volta tra l’attore, il testo e il pubblico. La mia fedeltà non è museale, non è timida».
Com’è?
«È come quella dei grandi direttori di orchestra che si misurano con una sinfonia di Beethoven facendole proprie, non però fino al punto da sconcertare il pubblico. Ma è anche come quella di un artigiano che, sera dopo sera, ha come materia il testo, il corpo, il contatto con le proprie emozioni profonde e il modo con cui governa le relazioni di quindici persone che stanno insieme per anni. La mia compagnia condivide con me la consapevolezza che il teatro è rimasto il solo luogo, insieme alla poesia, che ha al centro la parola come necessità».
È per affermare questa necessità che lei protrae le repliche di una stessa opera per centinaia di serate? Non è un’abitudine frequente nel teatro italiano.
«Ritengo le repliche più importanti delle prove. Più si replica, più il teatro diventa un percorso di conoscenza. Il teatro è il contrario di un evento, è vagabondo per natura. È solo così che si scoprono pubblici sempre nuovi. Quando siamo stati a Napoli per la terza volta e abbiamo trovato un pubblico del tutto diverso, ho avuto l’impressione che fossimo dei marinai che si inoltrano in mari sconosciuti, buttano a mare le reti e pescano pesce nuovo. Con questa commedia di Eduardo sono alla trecentesima replica e conto di arrivare, con la mia prossima e ultima tournée all’estero, almeno a 350».
Tra pochi giorni l’Università di Bologna le darà una laurea ad honorem in Arti dello spettacolo. A questo punto della sua carriera non le pare un riconoscimento quasi pleonastico?
«È invece il motivo per cui l’ho accettata. Se avessi ricevuto un’offerta di una laurea in Filologia romanza, mi sarei sentito un usurpatore. Ma questa, già data ad artisti come Leo de Berardinis e Martin Scorsese, la ritengo pertinente. Me la sono meritata sul campo da adulto, io che da ragazzo ho lasciato l’università senza laurearmi».
Sembra un rammarico. Perché ha interrotto gli studi?
«Non è un rammarico e le racconto come è andata. Studiavo Psicologia anche con discreto profitto alla Sapienza di Roma, ma avevo già cominciato a recitare. Al secondo anno, mi presentai a un esame piuttosto stanco. Il professore, che era un sacerdote, se ne accorse e me ne chiese il motivo. Mi vergognavo a dire che avevo fatto le prove di uno spettacolo fino a tardi, ma alla fine confessai: “Faccio l’attore”. E lui: “Allora smetta con questi studi perché le ingombrano lo spirito”. Era un buon consiglio: se avessi conosciuto a fondo i meccanismi psicologici, ne sarei diventato un portatore didascalico in scena».
Ma lei non è soltanto un uomo di teatro. È al cinema che negli ultimi anni deve una fama più vasta e successi internazionali.
«Il cinema è un’altra faccenda. Lo dico col massimo rispetto, ma in alcuni paesi dell’entroterra casertano lo chiamavano “umbruglio entre ’o lenzuolo”, cioè un lenzuolo su cui si proiettava qualche imbroglio. Nel teatro siamo lì, vivi, ad officiare un rito con il pubblico in un tempo esistenziale condiviso. Nel cinema non c’è svolgimento e si ripete una scena finché il regista rapisce quel momento che poi è fissato e non cambierà mai più. Se vuole una sintesi: il cinema cattura, il teatro dona».
Comunque era dai tempi di Vittorio Gassman che un attore non toccava i suoi livelli di popolarità sia al cinema che a teatro. Come vive questa bigamia?
«Amando profondamente anche il cinema come attore e come spettatore. Più volte ho scelto di partecipare a quei miracoli sorgivi che sono le opere prime, e sempre ho costruito un’amicizia con i registi con cui ho lavorato. Ma se lei pensa che ho fatto il primo film che avevo già 40 anni, capisce dove mi sento a casa. Questa che lei chiama bigamia mi dà comunque l’opportunità di mischiare i pubblici. È la cosa che considero più importante».
Sta dicendo che il pubblico indistinto de “La grande bellezza” viene a vederla interpretare Goldoni o Eduardo?
«Ho questa sensazione, specialmente per il pubblico giovane. L’importante è che i ragazzi che vengono a teatro non sentano lo iato tra l’entusiasmo che possono aver provato al cinema e lo spettacolo cui assistono. Detto in parole povere: non prendano il pacco».
Come si evita questo rischio?
«Facendo in modo che avvertano una continuità tra il modo di fare il cinema e il modo di fare teatro. La soluzione è nello stile, che in fondo è sempre un compromesso tra il linguaggio e la necessità di esprimere quel linguaggio».
Se ci tiene a mischiare e allargare i pubblici, come non l’abbiamo mai vista in tv?
«Perché fino ad oggi non ho mai ricevuto una proposta che sembrasse interessante quanto uno degli spettacoli o dei film che ho fatto».
Forse chiede troppo alla televisione.
«Non credo. Negli anni Settanta e Ottanta buona parte della mia formazione è dovuta anche a prodotti televisivi come “Berlin Alexanderplatz” di Fassbinder, “Twin Peaks” di Lynch, “Heimat” di Reitz, “Scene da un matrimonio” di Bergman. Se ricevessi una proposta di quel tipo, non troverei niente di strano ad andare in tv».
Nel clima culturale in cui viviamo potrebbe mai accadere?
«Ho qualche difficoltà a immaginarlo. Oggi la televisione è interessante soltanto per il racconto dell’Italia portato avanti da alcune inchieste giornalistiche. Nel settore della finzione non segue, come fanno invece cinema e teatro, un obiettivo di approfondimento. Va per le spicce. Come, del resto, tutto il Paese, che è precipitato nel burrone dell’ignoranza».
Se fosse in suo potere, dove comincerebbe a correggere e riparare?
«Dalla scuola, non c’è alcun dubbio. Ho un figlio di 18 anni e uno di 13, incontro di frequente ragazzi delle università e delle accademie. In tutti vedo un grande desiderio di esempi, non solo virtuosi, ma talentuosi. Però la gran parte dei giovani è ormai incapace di ragionare in maniera astratta, non comprende le metafore, cioè gli strumenti per avventurarsi nel pensiero in maniera gratuita, e così non avrà mai la possibilità di disporsi all’ascolto, al contraddittorio. L’unica strada è restituire dignità e valore alla figura del docente, che, insieme a quella dell’attore, è la più degradata».
Che cosa le unisce in questo svilimento?
«La cultura dell’immediatezza. Quella per cui il talento non ha a che fare con la disciplina, i risultati non dipendono dallo studio, perché ti giochi tutto in un giorno. Dominano l’esibizionismo l’ecletticità, il generico desiderio di esprimere se stessi».
Ma in una società in cui la scuola è di massa e tutto è spettacolo, come si può invertire la cultura del talent show?
«Non lo so, ma bisogna passare da quella porta. Io so quello che devo alla mia formazione scolastica. Ai miei anni dai salesiani devo la dimensione della socialità appresa nel condividere un pallone. Al liceo statale devo l’incontro con un professore di filosofia che mi ha fatto capire come la vita possa essere orientata dai pensieri».
Fra pochi giorni, debutterà a Genova con il recital “Parole e musica” insieme a suo fratello Peppe e canterà anche lei. Nel passato ha diretto alcune opere liriche e non è la prima volta che allestisce uno spettacolo musicale. Che cosa cerca ancora nella musica?
«Che mi sveli il suo mistero. Mi sono sempre chiesto come sia possibile che una sollecitazione che è fisica, perché riguarda l’orecchio, possa renderci capaci di ricapitolare la nostra vita o immaginarne un’altra in un luogo che non c’è, che è astratto perché la musica non si tocca e non si vede. Per questo la ritengo la più sublime tra le arti, la più vicina alla preghiera».