Se si continuerà a leggere, se la civiltà della parola scritta non si spegnerà nelle prossime generazioni, credo ci sia un solo libro sulla cui sopravvivenza si può giurare e che sarà letto con la stessa passione con cui noi l’abbiamo letto: “L’isola del tesoro” di Stevenson. Quando ci saranno dei ragazzi cui questo libro non piacerà, vorrà dire che è cominciata l’era dei mostri o degli angeli, che è poi la stessa cosa. Altri titoli non saprei trovare. Forse i “Miserabili”, che io ho letto e riletto tra i dieci e i dodici anni così bene come poi non ho saputo rileggerlo a trenta. (30 aprile 1972)
Non chiamatemi intellettuale
Fintanto che si parla all’intellettuale come a uno che partecipa di una categoria o corporazione, non mi sento chiamato in causa. Anche ammettendo la restrizione che intellettuali siano quelli professionalmente e sindacalmente definibili in quanto tali, credo si possa senz’altro affermare che ci sono, all’interno della corporazione, tanti singoli tipi d’intellettuale quanti sono - per così dire- gli iscritti. Ogni intellettuale è una monade. E c’è la monade con porta e finestre e c’è la monade chiusa. E nessuno dovrebbe azzardarsi a giudicare - stante le non lontante e nefaste esperienze - che la monade chiusa (la propria camera, la biblioteca, il labirinto) merita ostracismo o disprezzo mentre da coltivare, da preferire e da privilegiare è la monade aperta. Ci sono monadi spalancate che sono del tutto cieche; e monadi chiuse che vedono tutto.
Non credendo, dunque, di far parte di una categoria, corporazione o sindacato, se qualcuno mi corre dietro chiamandomi “intellettuale” non mi volto nemmeno. Mi volto - e rispondo - se mi chiama per nome e cognome.
(20 febbraio 1983)
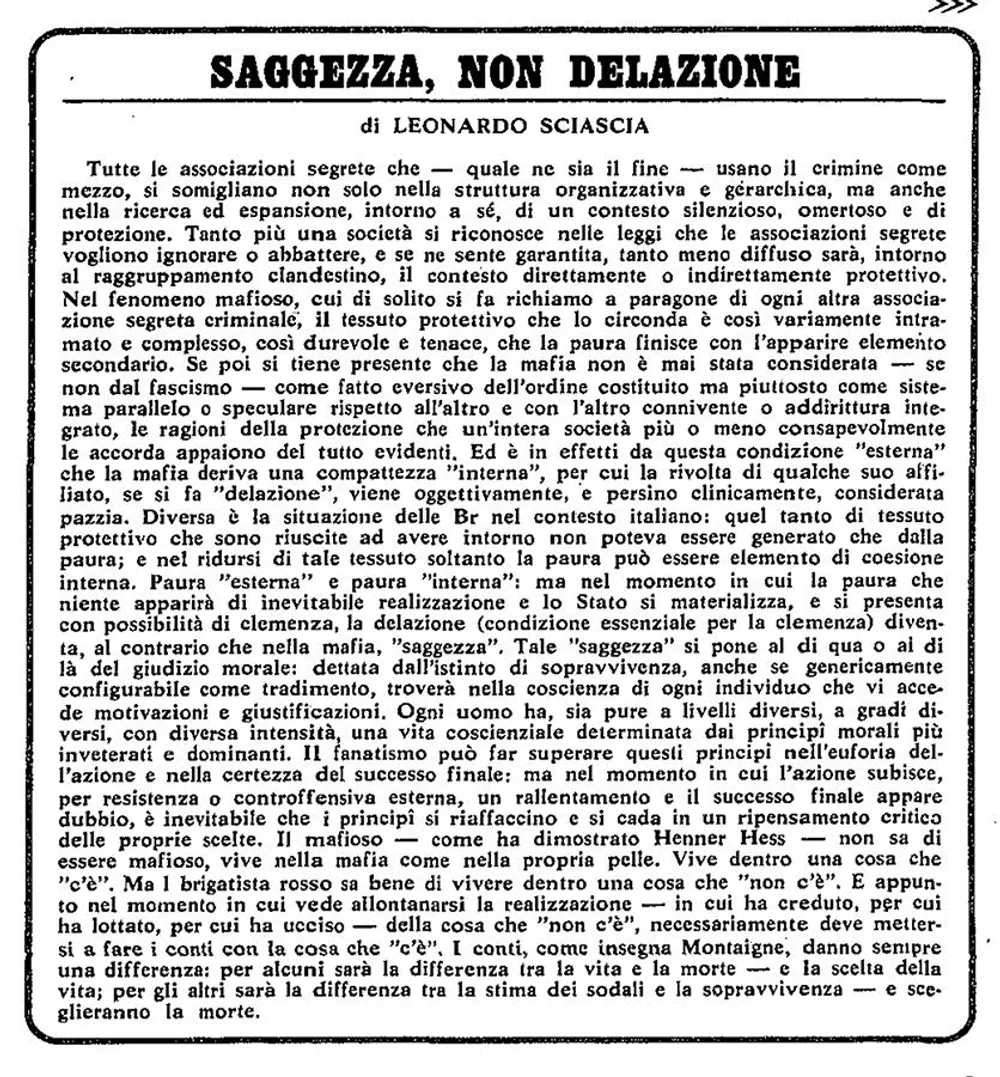
Gli italiani e le tasse
Quale il vizio, il difetto, la remora da colpire principalmente negli italiani cominciando, come troppo tardi si comincia, a parlare di una “questione morale”?
Qualche anno fa, da pochi giorni in Italia, un diplomatico straniero mi chiese: “Da dove si comincia in questo paese? Dalla scuola?”. Risposi: “Dalle tasse”. E continuo a pensarla così. Non avendo dello Stato un’idea mitica o mistica, considerandolo come un insieme di servizi al cui mantenimento i cittadini dovrebbero concorrere principalmente devolvendogli una parte considerevolmente proporzionata del loro reddito, ritengo che il sottrarsi a questo dovere implichi necessariamente una condizione di indifferenza o di rassegnazione o addirittura di avversione nei riguardi di questi servizi che si dovrebbero pretendere in cambio. Insomma: si pretende di avere per quel che si paga. Quando non si paga, si ha soltanto quel tanto che non si paga: del denaro che non può diventare servizio, specie in un mondo e in un’epoca in cui i servizi non possono essere gestiti e assicurati che dall’organizzazione di vaste collettività.
Se si riuscirà a vincere negli italiani l’orgoglio di non pagare le tasse, e anzi a trasformare il sentimento d’orgoglio in sentimento di vergogna - e ciò, purtroppo, non potrà avvenire che attraverso un fatto repressivo - credo che ciascuno e tutti cominceranno a pretendere di più dai servizi dello Stato: di più nella giustizia, di più nella scuola,. di più nella sicurezza pubblica… Far pagare le tasse a tutti gli italiani che le debbono: è forse l’utopia più che grande che possa darsi questo paese. Ma bisogna pur provare a realizzarla. Perciò mi piace Reviglio. Quando lo vedo seduto al banco del governo, con lo sguardo un po’ sperso e senza quell’aria di sicurezza che hanno altri ministri, mi sento un po’ confortato. Farà magari qualche errore, ma crede in questa grande utopia. Speriamo che lo lascino lavorare. (21 dicembre 1980).
Moro, un uomo solo
Non c’è un Moro di prima, grande statista, e un Moro prigioniero che non ha il senso dello Stato. Moro non è mai stato un grande statista e non ha mai avuto il senso dello Stato. Moro è stato un grande politicante e un grande democristiano. Questo viene fuori nel modo più chiaro leggendo quello che Moro ha scritto e soprattutto leggendo il discorso in difesa dell’onorevole Gui al Parlamento. Quindi quelli che hanno inventato un grande statista che non è più un grande statista hanno commesso, umanamente parlando, un delitto. E questo per me è il nodo del dramma: il misconoscimento di quest’uomo, l’aver fatto di quest’uomo, che era lucido e continuava a pensare come sempre, un pazzo, un uomo impazzito di paura. Agli italiani è stata offerta questa terribile mistificazione. Non ho avuto mai nessuna simpatia per il Moro politicante, ma ho sentito un grande affetto per quest’uomo solo, negato, tradito. (24 settembre 1978)
La Mafia e le Brigate rosse
Tutte le associazioni segrete che - quale ne sia il fine - usano il crimine come mezzo, si somigliano non solo nella struttura organizzativa e gerarchica, ma anche nella ricerca ed espansione, intorno a sé, di un contesto silenzioso, omertoso e di protezione. Tanto più una società si riconosce nelle leggi che le associazioni segrete vogliono ignorare o abbattere, e se ne sente garantita, tanto meno diffuso sarà, intorno al raggruppamento clandestino, il contesto direttamente o indirettamente protettivo. Nel fenomeno mafioso, cui di solito si fa richiamo a paragone di ogni altra associazione segreta criminale, il tessuto protettivo che lo circonda è così variamente intramato e complesso, così durevole e tenace, che la paura finisce con l’apparire elemento secondario. Se poi si tiene presente che la mafia non è mai stata considerata - se non dal fascismo - come fatto eversivo dell’ordine costituito ma piuttosto come sistema parallelo o speculare rispetto all’altro e con l’altro connivente o addirittura integrato, le ragioni della protezione che un’intera società più o meno consapevolmente le accorda appaiono del tutto evidenti. Ed è in effetti da questa considerazione “esterna” che la mafia deriva una compattezza “interna”, per cui la rivolta di qualche suo affiliato, se si fa “delazione”, viene oggettivamente e persino clinicamente, considerata pazzia.
Diversa è la situazione delle Br nel contesto italiano: quel tanto di tessuto protettivo che sono riuscite ad avere intorno non poteva che essere generato dalla paura; e nel ridursi di tale tessuto soltanto la paura può essere elemento di coesione interna. Paura “esterna” e paura “interna”: ma nel momento in cui la paura che niente apparirà di inevitabile realizzazione e lo Stato si materializza, e si presenta con possibilità di clemenza, la delazione (condizione essenziale per la clemenza) diventa, al contrario che nella mafia, “saggezza”. Il mafioso - come ha dimostrato Henner Hess - non sa di essere mafioso, vive nella mafia come nella propria pelle. Vive dentro una cosa che “c’è”. Ma il brigatista rosso sa bene di vivere dentro una cosa che “non c’è”. E appunto nel momento in cui vede allontanarsi la realizzazione - in cui ha creduto, per cui ha lottato, per cui ha ucciso - della cosa che “non c’è”, necessariamente deve mettersi a fare i conti con la cosa che “c’è”. I conti, come insegna Montaigne, danno sempre una differenza: per alcuni sarà la differenza tra la vita e la morte - e la scelta della vita; per gli altri sarà la differenza tra la stima dei sodali e la sopravvivenza - e sceglieranno la morte. (27 aprile 1980)





