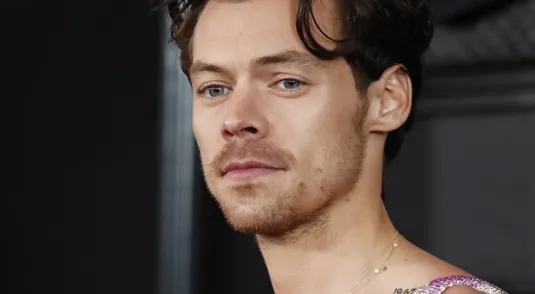Innovazione
11 settembre, 2025Detenute, profughe, persone vulnerabili. Le grandi aziende hi-tech sfruttano la manodopera per addestrare le macchine. Parla il professore autore di un documentario-denuncia
Lo scorso giugno, quando Meta ha annunciato la nomina di Alexandr Wang a capo del nuovo programma di superintelligenza artificiale, la stampa specializzata ha salutato l’ennesimo enfant prodige della Silicon Valley. A soli 28 anni è diventato uno dei volti più influenti della corsa verso l’Intelligenza Artificiale Generale. Una parabola americana da manuale: studente brillante del MIT, accordi da miliardi di dollari, ascesa fino ai vertici dell’industria tech.
Dietro questa narrazione patinata la realtà è un’altra: Wang è innanzitutto cofondatore di Scale AI e il suo ingresso in Meta è coinciso con l’investimento di quasi 15 miliardi di dollari che il colosso di Zuckerberg ha fatto nella sua azienda. Fondata solo pochi anni fa, la startup che lo ha trasformato in una star del settore si regge su un’attività tutt’altro che glamour: impiegare milioni di operai dei dati che per somme irrisorie inseriscono informazioni, etichettano immagini, trascrivono testi, filtrano contenuti sensibili. Sono i rider dell’intelligenza artificiale: lavoretti precari e sottopagati che alimentano la tecnologia del futuro.
Mentre investitori e opinione pubblica si lasciano abbagliare dalla retorica della superintelligenza, dietro le quinte si muove quest’esercito industriale che continua a lavorare per Scale AI e per centinaia di altre aziende di questo tipo. La verità è che l’intelligenza artificiale, per quanto sofisticata possa apparire, dipende ancora massicciamente dal lavoro umano più precario del Pianeta. Un numero imprecisato di lavoratori digitali, che secondo le stime della Banca Mondiale superano ampiamente i cento milioni a livello globale.
Da anni i media documentano le condizioni di lavoro di questi “proletari del clic”. Nel gennaio 2023, due mesi dopo il lancio di ChatGPT, un’inchiesta della rivista Time portava alla luce l’esistenza di veri e propri sweatshop digitali in Africa, dove i lavoratori venivano retribuiti poco più di un dollaro e mezzo l’ora per “addestrare” l’intelligenza artificiale di OpenAI.
A supporto del reportage di Time c’erano anche le ricerche di universitari come me, impegnati da anni in indagini sul campo per documentare questa realtà. In quel periodo stavo già lavorando con il regista Henri Poulain quello che sarebbe poi diventato il nostro nuovo documentario, “Nel Ventre dell’Intelligenza Artificiale” (“In the Belly of AI”, Federation Studios, 2025). La mia attività di ricerca si intreccia da tempo con la produzione di inchieste televisive sui rapporti tra tecnologia e lavoro. Questa volta abbiamo deciso di puntare i riflettori su un fenomeno in piena espansione: il ricorso, per far funzionare l’intelligenza artificiale, alle persone più vulnerabili. Dalle vittime dei conflitti armati, ai milioni di disoccupati nei continenti più poveri, fino ai lavoratori a basso reddito anche nei Paesi ricchi. Non si tratta solo di aziende come Scale AI, ma di catene internazionali di sfruttamento nell’economia digitale.
Uma Rani, economista dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro di Ginevra, lo spiega con una chiarezza disarmante durante una delle prime interviste nel nostro documentario. Ogni volta che ChatGPT risponde a una domanda, che un’auto Tesla evita un ostacolo o che Instagram riconosce un volto in una foto, dietro quell’automazione si nasconde un flusso di lavoro umano che attraversa il Pianeta. Non è solo codice e algoritmi: è sudore, fatica e sfruttamento in Paesi dove qualche centesimo può fare la differenza tra sopravvivere e non arrivare alla fine del mese.
Ma questa intervista era solo l’inizio. Durante mesi di riprese abbiamo incontrato decine di persone: detenute nelle carceri finlandesi che per due euro al giorno addestrano delle intelligenze specializzate, profughe ucraine ridotte a taggare immagini digitali per mantenere i loro figli, migranti indiani che etichettano immagini per pochi centesimi l’ora. Ma sono stati soprattutto i lavoratori dei quartieri poveri di Nairobi, in Kenya, a colpirci di più. Non solo per le condizioni di sfruttamento estremo, ma per le conseguenze psicologiche devastanti del loro lavoro. Molti di loro addestrano l’intelligenza artificiale delle grandi multinazionali a non generare contenuti illeciti: stupri, torture, omicidi, abusi. Questo tipo di attività, chiamata anche “moderazione”, rappresenta il lato più buio dell’addestramento delle intelligenze artificiali. Anche chi modera contenuti su Facebook sta in realtà insegnando a dei sistemi automatici a bloccare foto e testi violenti o offensivi. Chi svolge questi compiti sviluppa spesso disturbi post-traumatici da stress dopo aver trascorso mesi a visionare e catalogare materiale raccapricciante.
Di fronte a queste testimonianze, ci siamo urtati al muro di silenzio delle Big Tech. Qual è la risposta delle aziende che sviluppano IA di fronte a tutto questo? Praticamente nulla. A parte qualche timido tentativo di darsi codici etici che non hanno valore legale, il loro lavoro principale sembra essere quello di zittire le voci critiche. La realizzazione di “Nel Ventre dell’Intelligenza Artificiale”, più che in altri nostri progetti, è stata un campo minato: interviste con esperti e testimoni annullate all’ultimo minuto, mancate autorizzazioni da parte di istituzioni e amministrazioni pubbliche, intimidazioni da parte di avvocati legati a grandi multinazionali e delle forze dell’ordine.
L’episodio più surreale è accaduto a Nairobi, dove stavamo intervistando alcuni addestratori di intelligenza artificiale. Mentre giravamo, un gruppo di agenti di polizia ha fatto irruzione nel locale e ha fatto pressioni sulla troupe per far spegnere le telecamere. Il Kenya si trova in una posizione particolarmente delicata nei rapporti con i giganti della tecnologia. Il Paese è diventato un hub cruciale per questo tipo di servizi digitali, ospitando un numero imprecisato di operai dei dati che lavorano per i giganti mondiali dell’IA. Questa dipendenza economica rende il governo keniano particolarmente ricettivo alle pressioni delle multinazionali. Qualche mese dopo l’irruzione della polizia durante le nostre riprese, il presidente William Ruto in persona è intervenuto pubblicamente nelle cause legali contro le aziende che sfruttano i lavoratori con salari da fame. Ha annunciato un emendamento per impedire future azioni legali contro queste aziende: «Abbiamo cambiato la legge, così nessuno potrà più portarvi in tribunale».
Quello che abbiamo capito durante questi anni di lavoro è che questo esercito di operai dei dati non è “lavoro invisibile”, come spesso viene definito. È attivamente nascosto dalle aziende del settore tecnologico che utilizzano intimidazioni, ostacoli legali e manipolazioni mediatiche per costruire uno storytelling che fa di persone come Alexander Wang i soli eroi della rivoluzione digitale.
Ma i veri eroi sono altri. Gente comune, senza fama né riconoscimenti: le donne e gli uomini che oggi finalmente si organizzano in sindacati e associazioni per rivendicare condizioni di lavoro dignitose. Sono loro che, anche grazie a documentari come il nostro, possono ora sperare che la loro voce sia finalmente udita. Perché dietro ogni algoritmo intelligente c’è sempre e comunque l’intelligenza umana. E quella intelligenza merita rispetto, dignità e giustizia.

LEGGI ANCHE
L'E COMMUNITY
Entra nella nostra community Whatsapp
L'edicola
Non passa lo straniero - Cosa c'è nel nuovo numero de L'Espresso
II settimanale, da venerdì 23 gennaio, è disponibile in edicola e in app