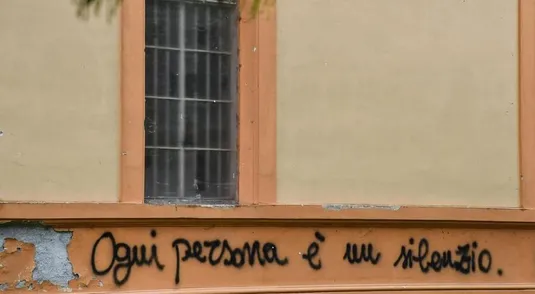Resterà a lungo nella memoria l’esito, nettissimo, della sfida per aggiudicarsi l’Expo 2030 (Riad 119 voti, Roma appena 17). Roma vive da tempo una fase di evidente difficoltà, innegabile. E tuttavia questa oggettiva circostanza non deve condurre a interpretazioni su Expo 2030 che poco hanno a che fare con la realtà cruda dei fatti. Perché rispetto a contese come quella per l’aggiudicazione di un grande evento planetario quale l’Expo, la condizione in cui versano le città o gli Stati in competizione gioca un ruolo fino ad un certo punto. Non si tratta di ridimensionare o relativizzare le cause dello stato di difficoltà in cui si dibatte da tempo Roma. Il tema è un altro.
Come è stato accertato, per Expo 2030 Riad ha speso 190 milioni di euro per le attività di “promozione” della sua candidatura, Roma appena 30 (la terza città concorrente, della Corea del Sud, ben 130 milioni di euro). È in quei 190 milioni che va prevalentemente ricercato il senso di quel riferimento alla «deriva mercantile» di cui ha parlato l’ambasciatore Giampiero Massolo. Perché la città aggiudicataria di un evento assegnato da organismi internazionali che, in fondo, rispondono solo a se stessi è scelta attraverso un voto, cui partecipano i delegati dei Paesi grandi, piccoli e piccolissimi che hanno diritto di esprimerlo. Un voto, dunque, nel quale i Paesi piccoli e piccolissimi valgono quanto i Paesi più grandi.
All’indomani della sconfitta di Roma, anche sui media, che con riferimento a ciò che accade all’interno dei confini nazionali agitano continuamente la questione morale, si è potuto leggere che non c’è di che scandalizzarsi della pratica del «voto di scambio» nelle competizioni per aggiudicarsi grandi eventi di respiro planetario. Dove per «voto di scambio» si intende più spesso il baratto fra progetti di cooperazione e voto a sostegno della candidatura del Paese (candidato) “cooperante”.Tutto questo è abbastanza bizzarro. E fa sorgere interrogativi di fondo sui 30 milioni spesi per Roma. A chi dice che non c’è da meravigliarsi della pratica del voto di scambio, sarebbe da chiedere come si poteva pensare di competere con soli 30 milioni di euro. All’evidenza, così prevedibilmente insufficienti da autorizzare il pensiero di un loro ingiustificato impiego. A chi invece opinava che la logica del voto di scambio non sarebbe stata praticata, si potrebbe oggi perfino domandare se, all’opposto, i 30 milioni spesi non siano stati anche troppi. Che si muova dall’uno o dall’altro punto di vista, comunque 30 milioni non tornano. O sono troppo pochi, o (se si riteneva potesse e dovesse bastare la “grande bellezza”, by Paolo Sorrentino) sono troppi.
Altra cosa, è vietato non domandarsi perché si può essere disposti a investire fino a 190 milioni pur di aggiudicarsi Expo 2030. Forse perché è un colossale affare economico per chi lo ospita? I precedenti, per la verità, non dicono questo. O forse perché attrae attenzione e considerazione positiva su Paesi senza o in calo di appeal? O, ancora, perché lo scambio con il voto non è tanto un modo per aggiudicarsi l’evento quanto la porta per aprire relazioni, commerciali e no, con il Paese disposto a barattare la propria preferenza? Ah, saperlo.