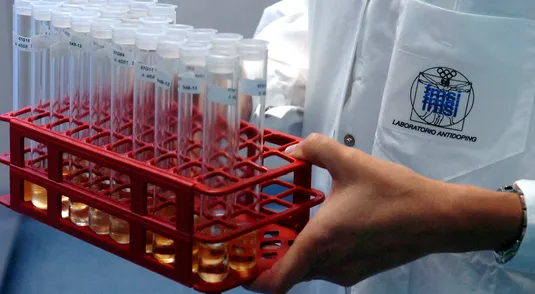Il 25 agosto, a Cortina si è tenuto un flashmob per la salvaguardia del Lariceto che andrebbe distrutto con la costruzione della pista da bob per i 25° Giochi olimpici invernali, a Milano e Cortina, nel 2026. L’opera ha un costo stimato di 124 milioni di euro ed è solo la punta dall’iceberg della contestazione alle Olimpiadi invernali. Il precedente flashmob del 20 luglio, invece, unito dalla frase «non nel mio nome», mi ha ricordato i sit-in della campagna «apriamo i porti» nel 2018 davanti all’ambasciata italiana a Bruxelles, contro le politiche migratorie del governo Conte-Salvini.
È interessante ragionare sulla scelta dello slogan e sul concetto di «nome» che ritroviamo spesso nelle azioni collettive di protesta. In entrambe i casi, e sono casi diversi, il «nome» equivale al consenso. Lo slogan «non nel mio nome» denuncia infatti una stortura nella cittadinanza, nel senso di processo partecipativo; è la denuncia di una firma falsificata. «Adesso è troppo tardi per lamentarsi, le decisioni sono già state prese», sentiamo dire. Ma c’era una sedia per i comitati cittadini durante i processi decisionali? Come mai queste analisi costi-benefici avvengono sempre a porte chiuse? E come mai gli studi e i sopralluoghi paralleli raccontano sempre un’altra storia?
Le azioni di protesta come i flashmob contro le Olimpiadi invernali vengono spesso inquadrati come «nimby», «not in my backyard», ovvero «non nel mio giardino». L’acronimo viene usato per denigrare i movimenti e accusarli di voler semplicemente fare a scaricabarile su altri territori: «Fatelo, ma non qui, altrove». Tuttavia non è quasi mai il caso e credo sia più onesto, intellettualmente, definirli come movimenti e realtà che lottano contro opere inutili e/o dannose, contro progetti insostenibili o comunque non prioritari, ovunque essi siano.
Abbiamo bisogno di politiche di adattamento e di mitigazione dei cambiamenti climatici e di infrastrutture ad hoc, ma questo i governi lo sanno bene. Invece che «nimby», credo sia più giusto nominare questi movimenti «nimce» ovvero «not in my collapsing era», «non nella mia epoca al collasso». Stiamo assistendo alla radicale destabilizzazione della vita sulla Terra. Stiamo facendo esperienza di massicce perdite di raccolti, incendi apocalittici, fiumi che esondano e inondazioni epiche.
Ci aspettano centinaia di milioni di rifugiati dalle regioni rese inabitabili dal caldo estremo o dalla siccità permanente, mentre facciamo finta di non sapere che il Mediterraneo è una di queste. Alcune proiezioni prevedono 1.2 miliardi di rifugiati climatici entro il 2050. A oggi, i cambiamenti climatici sono già la principale causa di migrazione al mondo, nonostante il termine rifugiato climatico non esista nella Convenzione sui rifugiati. Dal 2008, oltre 318 milioni di persone sono state sfollate a causa di disastri climatici, vale a dire l’equivalente di una persona ogni secondo o dell’intera popolazione australiana ogni anno. Sapevamo dell’apartheid climatica, ma forse credevamo di stare dall’altra parte.
L’Italia deve dichiarare lo stato di emergenza climatica e deve agire di conseguenza. A livello pratico significa saper definire cosa è prioritario per la sopravvivenza della nostra specie. Riprendendo la metafora di Greta Thunberg, chi starebbe sul divano a guardare i giochi olimpici mentre la propria casa va a fuoco?