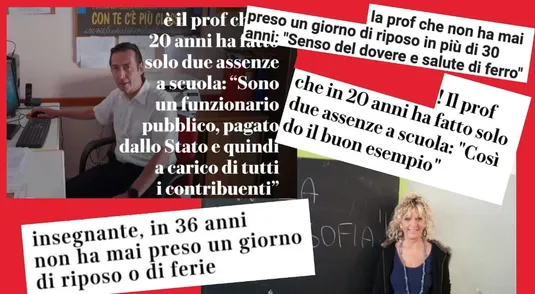Una volta l’Istat, una volta la Banca d’Italia, una volta il ministero. Ogni volta che qualcuno pubblica uno studio sull’occupazione, in Italia si innesca la polemica sugli effetti del jobs act di Matteo Renzi. È stato così anche per i dati che l’Inps ha diffuso il 10 ottobre, che pure spingono una ricercatrice come Marta Fana, dottoranda in Economia alla SciencesPo di Parigi a dire senza incertezze (e a dimostrarlo su Internazionale) che anche sorvolando sulle oscillazioni mensili e concentrandosi sul dato complessivo degli occupati, come suggeriscono di fare dal governo, rispetto alle risorse investite e all’addio all’articolo 18, «l’Italia in termini di aumento occupazionale fa peggio dei Paesi che non hanno fatto il Jobs act e non hanno regalato 15 miliardi alle imprese».
È così? Se il punto sono le politiche del governo Renzi una sintesi non azzardata può in effetti essere quella di dire che, più del jobs act, qualche effetto temporaneo lo hanno avuto gli sgravi fiscali. «Gli sgravi», ci dice ancora Fana, «hanno avuto un enorme effetto sulla dinamica dei contratti a tempo indeterminato, sia per i nuovi che per le trasformazioni, stipulati dalle imprese nel 2015». Calati gli incentivi, però, nel 2016 il crollo: «Da inizio anno», continua Fana, «le nuove assunzioni sono calate drasticamente. E non solo rispetto al 2015 ma anche rispetto al 2014».
Ma è proprio dai dati dell’Inps che il senatore Pietro Ichino, giuslavorista nelle file di Matteo Renzi, parte per difendere la riforma. Per Ichino, dopo la forte spinta degli incentivi, il flusso è rallentato solo perché «abbiamo assistito a un certo numero di assunzioni che sarebbero state fatte l’anno successivo, e che sono state invece anticipate al 2015 per godere degli sgravi». Un dato che dovrebbe peraltro rallegrarci, «perché è gente che ha cominciato a lavorare un anno prima». Effetto doping, insomma: l’effetto sperato dal governo, a sentire Ichino. Che replica così a chi fa notare che 2016 la percentuale di nuovi contratti indeterminati è addirittura più bassa di quella del 2014: «Il confronto corretto va compiuto tra i venti mesi dal primo gennaio 2015 e il 31 agosto 2016 (ultimo dato disponibile) e i venti mesi tra il 1° gennaio 2013 e il 31 agosto 2014: nel 2015-16 si sono verificate 1.214.672 assunzioni in più, di cui 818.306 a tempo indeterminato e 396.356 a termine».
I numeri che snocciola Ichino sono gli stessi di cui si vanta sull’Unità il sottosegretario Tommaso Nannicini, economista spalla di Renzi: «Per raggiungere un livello di occupazione stabile più alto di questo bisogna risalire all’agosto 2009», scrive Nannicini insieme a Filippo Taddei. «Ichino, come Nannicini e Taddei», è però la replica di Fana, «usano le fonti a seconda della propria convenienza. Stando nel merito delle loro scelte, se le imprese hanno anticipato assunzioni che avrebbero comunque fatto spinte dalla congiuntura, allora ciò non fa altro che corroborare l’idea secondo cui gli sgravi non sono stati altro che un meccanismo per distribuire reddito nazionale dai salari, tramite la fiscalità generale, ai profitti».
È questo che fa, dunque, il jobs act, sposta reddito dai lavoratori alle imprese? In Italia questa tesi viene da tempo sostenuta dall’economista Emiliano Brancaccio, che il 26 ottobre discuterà di riforme del lavoro proprio con Ichino, in un seminario organizzato dalla Scuola Superiore di Magistratura. «Il governo - afferma Brancaccio - insiste a dire che il Jobs act starebbe creando centinaia di migliaia di posti di lavoro. Ma se vogliamo affrontare la questione su basi scientifiche dobbiamo come minimo effettuare un’analisi comparata tra Paesi. E qui Eurostat ci dice che nel 2015 l’Italia ha fatto registrare un aumento degli occupati che è pari a soli tre quarti dell’aumento medio dell’occupazione nell’Eurozona e a poco più della metà dell’incremento medio in tutta l’Unione europea. Stando alle previsioni per il 2016 e per il 2017, poi, la situazione purtroppo non cambia». «La ripresa italiana ha camminato finora a un tasso pari a un terzo rispetto alla media Ue», è l’obiezione di Ichino, «ed è ragionevole pensare che se dell’aumento dell’occupazione due terzi sono costituiti da rapporti stabili, questo è dovuto all’azione congiunta di entrambe le misure, l’incentivo economico e la riforma».
Il rimpallo tra i due potrebbe proseguire a lungo, ovviamente, anche se per Brancaccio i dati Eurostat non dovrebbero meravigliare: «Non c’è obiezione che tenga. La ricerca scientifica in materia», ci dice, «ha chiarito da tempo che tra precarizzazione e occupazione non c’è una relazione statistica significativa. Persino l’Ocse e l’ex capo economista del Fmi hanno dovuto riconoscerlo». Tanto vale, però, spostarci sulla teoria. Che idea c’è dietro il jobs act?
Brancaccio spiega che «l’unico dato sul quale la letteratura in materia converge è che la rincorsa alla precarizzazione riduce il potere rivendicativo dei lavoratori, schiaccia i salari e accentua le disuguaglianze tra i redditi». Ecco, per lui, il vero effetto del jobs act: «In una ricerca sui Paesi Ocse condotta con Nadia Garbellini e Raffaele Giammetti, abbiamo stimato che una riduzione dell’indice di protezione dei lavoratori di un punto risulta mediamente associata a un calo della quota salari di circa mezzo punto in un anno, e che ogni shock che riduca le tutele è associato a cali ulteriori della quota salari nell’arco del quinquennio successivo». «L’arresto della dinamica salariale è semmai un effetto della crisi», dice a questo punto Ichino. «Ma quello che stiamo osservando - prosegue Brancaccio - sembra proprio la tesi della Bce, che punta sull’abbassamento dei salari per aumentare la competitività».
«Peccato che quando si riducono le tutele, i salari declinano e con essi i prezzi, i ricavi e i redditi in generale, innescando il tremendo fenomeno della deflazione da debiti», continua Brancaccio, che anni fa è stato tra gli economisti che avanzarono, proprio per questo, la proposta di uno standard retributivo europeo. «Un’idea che mirava a sanzionare i Paesi, come la Germania, che hanno gonfiato le loro esportazioni anche a colpi di tagli alle tutele e ai salari relativi», ci spiega, precisando però che «per attuarla oggi ci vorrebbe un forte coordinamento europeo della contrattazione, che sembra impossibile», perché «i tedeschi si oppongono persino a soluzioni più modeste, come l’istituzione di un salario minimo europeo».
Ichino, di suo, punterebbe più sulla necessità di legare le retribuzioni alla produttività - e alla contrattazione - aziendale, e quanto all’idea di uno standard retributivo minimo continentale, osserva che «ci sono differenze di produttività troppo forti tra i Paesi membri, perché si possa arrivare a un minimo unico continentale».
La certezza, alla fine, è che le norme, anche le più lasche, non sono lasche quanto vorrebbe il mercato, che in fatto di precarietà sposta sempre più avanti il limite. Per Ichino il Jobs act ci ha «allineato con il resto dell’Europa in fatto di licenziamenti», ma anche la nuova normativa non sembra stare al passo con il cambiamento dei rapporti di lavoro. «Anche perché», dice ancora Brancaccio, «quando il legislatore concede nuove deregolamentazioni alcune imprese si spingono puntualmente oltre, chiedendo che le norme si adeguino continuamente ai loro espedienti».
Il recente caso di Foodora, ad esempio, ha fatto scoprire ai più la cosiddetta “gig economy”, l’economia dei lavoretti, resa trendy dalle sue app, e i voucher liberalizzati hanno moltiplicato le occasioni di lavoro a chiamata «venendo usati dalle aziende», ci spiega Fana, «anche per retribuire prestazioni a dipendenti già contrattualizzati. Con il cottimo che esce così pure dalla gig economy». Dall’economia dei celebri fattorini in bicicletta di Foodora, il cui caso per Ichino non è una novità: «I fattorini in bicicletta sono come i pony express degli anni 80», ci dice, «e come in quel caso non dobbiamo chiederci se possiamo stabilire uno standard retributivo per il lavoro autonomo, perché il diritto europeo non lo consente, ma dobbiamo decidere se rivedere i criteri su cui stabilire cosa sia e cosa non sia lavoro dipendente».
Perché allo stato dei fatti nonostante le pettorine brandizzate, le convocazioni e le notifiche via app, i fattorini non sono neanche paragonabili ai vecchi co.co.co, dice Ichino, se, come per i pony express, il contratto consente loro di non rispondere alla chiamata della centrale. La pensa diversamente l’avvocato giuslavorista Daniele Leppe, secondo cui «il comportamento di Foodora, e quello di tante altre imprese, è favorito dal Jobs act mediante l'abolizione dei contratti a collaborazione, che prevedevano l'obbligo di retribuire i lavoratori con un "compenso minimo" pari a quello indicato nei rispettivi contratti collettivi. L'eliminazione di questa norma impedisce oggi ai lavoratori di Foodora di poter rivendicare davanti al Tribunale del lavoro il pagamento di una retribuzione base analoga a quella dei lavoratori subordinati».
Politica
25 ottobre, 2016Ma il jobs act funziona o no?
C’è chi lo difende, come il giuslavorista Ichino, e chi ne fotografa l’insuccesso, come l’economista Brancaccio. I due si confronteranno alla Scuola superiore di Magistratura. Un bilancio della riforma, che prosegue nel mito della flessibilità