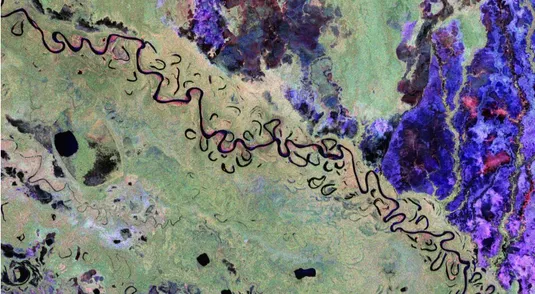Cultura
10 febbraio, 2017La storia del capitalismo va di pari passo con l'assenza di benessere in ampie fasce di popolazione. Nascono così la terapia cognitivo-comportamentale e le altre tecniche che consentono di spostare la felicità dalla dimensione sociale alla sfera psicologica individuale. Per produrre e consumare con il sorriso. È il tema al centro dell'"Industria della felicità", il nuovo saggio di WIlliam Davies
Ridi, ridi, così compri di più
«Il mio libro non è necessariamente una critica al neoliberalismo. Spesso mi chiedono com’è possibile che la felicità sia qualcosa di così negativo, e rispondo che non è sempre così. Prendiamo Trump: se fosse totalmente malvagio, non sarebbe certo dove si trova. Se si trova lì è perché ha delle qualità che certe persone trovano magnetiche». William Davies, sociologo inglese autore dell’”Industria della felicità” (Einaudi) sembra temere che certi contenuti del libro finiscano per confluire nei mille tortuosi rivoli dell’anticapitalismo. Il fatto è che quella che lui si limita a definire «una storia e critica culturale degli sforzi per trasformare la felicità umana in un qualcosa di misurabile» è un saggio fondamentale per definire cos’è oggi la felicità.
Concetto ora plastico, ora liquido, ora evanescente, mai fisso. Utopia verso cui convergono ego e moltitudini. Su cui si sono ininterrottamente interrogati - tanto per citarne alcuni - Buddha, Aristotele e Platone, Seneca e Jeremy Bentham, fino ad Albano e Romina e a Pharrell Williams. Nonché la maggior parte del resto dell’umanità: la quale nel quotidiano insegue la felicità da ben prima dalla dichiarazione dei diritti dell’uomo delle rivoluzioni americana e francese, le stesse che ne avevano trascinato la ricerca come fine ultimo dell’esistenza umana in questo stesso mondo e non oltre.
Fu allora che il capitalismo, tutt’altro che insensibile al valore economico di qualsiasi penuria, cominciò ad accorgersi di lei, o meglio della sua assenza, spesso cronica in così ampie fasce della popolazione del mondo occidentale nonostante la diffusione del benessere economico nel secondo dopoguerra. Cominciava così un sodalizio che dura ancora in quest’epoca di capitalismo occidentale ormai incorporeo, in cui l’indotto commerciale della ricerca della felicità conia instancabilmente discipline ad hoc.
Come la cosiddetta psicologia positiva, la terapia cognitivo-comportamentale, le psico-economia ?e varie neuroscienze, dal mondo dei consumi individuali fino all’introduzione dei dipartimenti di risorse umane nelle imprese per aumentare produttività e controllo. Modalità tutte basate sulla pratica di una ragioneria/ingegneria delle emozioni che presume la misurabilità ?di determinati impulsi chimici nel cervello e ne rileva la quantità e il modo di influenzarla. E tutte convergenti attorno allo spesso frainteso concetto di capitale umano, che presume che la forza lavoro sia psicologicamente aumentabile e dunque non fissa: uno degli assunti principali del neoliberismo contemporaneo, che per rendere profittevole (e innocua) la felicità doveva prima di tutto scinderla dalla sua intrinseca dimensione sociale e relegarla nella comoda soggettività della sfera psicologica. Programma vasto, ma ?non impossibile. L’obiettivo? Produrre ?e consumare con il sorriso. Ieri, sulle labbra; oggi, più spesso, negli emoticon sul display del telefono, del tablet, ?del computer.
Davies non usa il termine mercificazione, forse per le sue connotazioni troppo “marxisant”. Del resto non tutti i suoi protagonisti erano mossi dall’intento di fare soldi. Non certo il già citato Bentham, illuminista inglese tra i primi e più noti teorici moderni della felicità. Il quale credeva che la politica «andasse sottratta da tutte le ambiguità insite nel discorso sulla morale». Anziché parlare di diritti umani o giustizia, che riteneva categorie prive di fondamento anche per la sua incrollabile fede nella scienza, il filosofo inglese riteneva che la felicità fosse l’unica cosa che tutti gli uomini si trovassero d’accordo nel desiderare; ?da qui la sua idea di una scienza che misurasse le emozioni umane. Una visione ottimistica e tipicamente illuminista, «che in seguito», spiega Davies, «viene fatta propria da individui con il chiaro e deliberato intento di fare soldi, con l’avvento del marketing e delle ricerche di mercato all’inizio del XX secolo e con la comparsa nel mondo dell’impresa di quel dipartimento oggi noto come “Risorse umane”, che comincia ad imporsi attorno agli anni Trenta del Novecento».
Il problema è che questa felicità continua a scarseggiare. Questo nonostante sembri così a portata di mano, con buona pace dei workshop sulla felicità tenuti da monaci buddisti ultrailluminati agli ultraricchi riuniti annualmente sulle nevi ?di Davos, fatto citato e discusso da Davies. Scarseggia nonostante le mille applicazioni che mappano la continua risacca degli stati d’animo nel manager di successo come nell’operaio emancipato ?e nell’analista informatico, e i manuali ?di auto-aiuto che spesso avviliscono l’intelligenza e la fantasia dei destinatari. ?I molti esclusi da queste nuove pratiche continuano a cercare di procurarsela ?in modo “old school”: attraverso alcool, stupefacenti, psicofarmaci. Più sale ?la preoccupazione per i crescenti casi di depressione, infatti, più si cerca di indurre le persone a gestire le proprie emozioni nel tentativo di evitarli piuttosto che agire sulle loro cause sociali. E l’infelicità diventa malattia.
«Qui entrano in gioco ?la terapia cognitiva comportamentale e la psicologia positiva degli ultimi venticinque anni», continua Davies. «Per arrivare all’ultimo decennio, con l’ambiente circostante ormai diventato smart, capace cioè di monitorare o rilevare i nostri stati d’animo attraverso tecnologie indossabili o metodologie innovative, come la cosiddetta analisi dei sentimenti via computer, cioè la scrittura di software capaci di calcolare i nostri sentimenti a seconda dai movimenti dei nostri occhi ?o del nostro corpo, fino al modo in cui inviamo un’email o un tweet».
Pur illuminando le storture e i rischi di un simile avanzamento del controllo, Davies ?è convinto che alla base dell’industria ?del benessere, nelle pratiche new age, nell’aromaterapia come nella medicalizzazione unilaterale di sintomi pur di vendere psicofarmaci, ci sia un impulso incontestabilmente positivo, e ci tiene a sottolinearlo: «Ciò che funziona così bene in luoghi di lavoro che mettono l’accento sul benessere o in prodotti intesi a soddisfare certi desideri, è che a un certo livello funzionano: danno il benessere ?che promettono. Alla base c’è pur sempre il sogno dell’illuminismo, pur nella consapevolezza di come certe utopie siano finite nel totalitarismo più oscuro. Il fatto è che Bentham era incredibilmente ottimista circa le possibilità del progresso, della scienza e del potere della misurabilità».
Chissà se l’autore del “Panopticon” avrebbe mantenuto tanto ottimismo davanti agli esperimenti di manipolazione dell’umore dei propri utenti da parte di Facebook o al diluvio di app che misurano le nostre funzioni vitali per rilevare il nostro fluttuare di serotonina, per poi mandarle allo stesso Facebook o a chi ?per lui perché poi, a sua volta, le rivenda a terzi un tanto al tera. Resta che il percorso di ricerca del comportamentismo angloamericano dimostra un’imperturbabile continuità. E che sia tuttora perseguito, nonostante faccia parte della stessa ideologia che ha prodotto la crisi finanziaria dalla quale non si riesce a uscire. «Nella Gran Bretagna che cerca di togliere a tutti i costi i sussidi a certe fasce della popolazione, ci sono congerie di psicologi positivi, motivational speakers e anche terapisti che organizzano corsi di “behavioural activation” negli uffici di collocamento ?per indurre le persone a essere più attive nella loro ricerca di un lavoro, cui gli iscritti sono fortemente incoraggiati a partecipare anche quando non vogliono: ?è un caso chiaro in cui lo stato, nel nome del contenimento del debito socialmente imposto, forza le persone a parlare ?e a comportarsi in una certa maniera».
Nonostante la critica costruttiva di Davies ?a quest’ossessione del privato e del pubblico con la “felicità”, nel misurare l’impatto positivo attribuito a queste pratiche c’è poco da gioire: dal “misurabile” si passa assai facilmente al “miserabile”. E se la definizione che della felicità ha dato il sulfureo Slavoj Zizek risulta troppo oltranzista («È una categoria per schiavi», ha detto una volta il filosofo sloveno) forse ci può venire in aiuto, al riparo da qualunque accusa di snobismo, la pubblicità di una marca americana di latte: «Happy cows make happy milk».
Concetto ora plastico, ora liquido, ora evanescente, mai fisso. Utopia verso cui convergono ego e moltitudini. Su cui si sono ininterrottamente interrogati - tanto per citarne alcuni - Buddha, Aristotele e Platone, Seneca e Jeremy Bentham, fino ad Albano e Romina e a Pharrell Williams. Nonché la maggior parte del resto dell’umanità: la quale nel quotidiano insegue la felicità da ben prima dalla dichiarazione dei diritti dell’uomo delle rivoluzioni americana e francese, le stesse che ne avevano trascinato la ricerca come fine ultimo dell’esistenza umana in questo stesso mondo e non oltre.
Fu allora che il capitalismo, tutt’altro che insensibile al valore economico di qualsiasi penuria, cominciò ad accorgersi di lei, o meglio della sua assenza, spesso cronica in così ampie fasce della popolazione del mondo occidentale nonostante la diffusione del benessere economico nel secondo dopoguerra. Cominciava così un sodalizio che dura ancora in quest’epoca di capitalismo occidentale ormai incorporeo, in cui l’indotto commerciale della ricerca della felicità conia instancabilmente discipline ad hoc.
Come la cosiddetta psicologia positiva, la terapia cognitivo-comportamentale, le psico-economia ?e varie neuroscienze, dal mondo dei consumi individuali fino all’introduzione dei dipartimenti di risorse umane nelle imprese per aumentare produttività e controllo. Modalità tutte basate sulla pratica di una ragioneria/ingegneria delle emozioni che presume la misurabilità ?di determinati impulsi chimici nel cervello e ne rileva la quantità e il modo di influenzarla. E tutte convergenti attorno allo spesso frainteso concetto di capitale umano, che presume che la forza lavoro sia psicologicamente aumentabile e dunque non fissa: uno degli assunti principali del neoliberismo contemporaneo, che per rendere profittevole (e innocua) la felicità doveva prima di tutto scinderla dalla sua intrinseca dimensione sociale e relegarla nella comoda soggettività della sfera psicologica. Programma vasto, ma ?non impossibile. L’obiettivo? Produrre ?e consumare con il sorriso. Ieri, sulle labbra; oggi, più spesso, negli emoticon sul display del telefono, del tablet, ?del computer.
Davies non usa il termine mercificazione, forse per le sue connotazioni troppo “marxisant”. Del resto non tutti i suoi protagonisti erano mossi dall’intento di fare soldi. Non certo il già citato Bentham, illuminista inglese tra i primi e più noti teorici moderni della felicità. Il quale credeva che la politica «andasse sottratta da tutte le ambiguità insite nel discorso sulla morale». Anziché parlare di diritti umani o giustizia, che riteneva categorie prive di fondamento anche per la sua incrollabile fede nella scienza, il filosofo inglese riteneva che la felicità fosse l’unica cosa che tutti gli uomini si trovassero d’accordo nel desiderare; ?da qui la sua idea di una scienza che misurasse le emozioni umane. Una visione ottimistica e tipicamente illuminista, «che in seguito», spiega Davies, «viene fatta propria da individui con il chiaro e deliberato intento di fare soldi, con l’avvento del marketing e delle ricerche di mercato all’inizio del XX secolo e con la comparsa nel mondo dell’impresa di quel dipartimento oggi noto come “Risorse umane”, che comincia ad imporsi attorno agli anni Trenta del Novecento».
Il problema è che questa felicità continua a scarseggiare. Questo nonostante sembri così a portata di mano, con buona pace dei workshop sulla felicità tenuti da monaci buddisti ultrailluminati agli ultraricchi riuniti annualmente sulle nevi ?di Davos, fatto citato e discusso da Davies. Scarseggia nonostante le mille applicazioni che mappano la continua risacca degli stati d’animo nel manager di successo come nell’operaio emancipato ?e nell’analista informatico, e i manuali ?di auto-aiuto che spesso avviliscono l’intelligenza e la fantasia dei destinatari. ?I molti esclusi da queste nuove pratiche continuano a cercare di procurarsela ?in modo “old school”: attraverso alcool, stupefacenti, psicofarmaci. Più sale ?la preoccupazione per i crescenti casi di depressione, infatti, più si cerca di indurre le persone a gestire le proprie emozioni nel tentativo di evitarli piuttosto che agire sulle loro cause sociali. E l’infelicità diventa malattia.
«Qui entrano in gioco ?la terapia cognitiva comportamentale e la psicologia positiva degli ultimi venticinque anni», continua Davies. «Per arrivare all’ultimo decennio, con l’ambiente circostante ormai diventato smart, capace cioè di monitorare o rilevare i nostri stati d’animo attraverso tecnologie indossabili o metodologie innovative, come la cosiddetta analisi dei sentimenti via computer, cioè la scrittura di software capaci di calcolare i nostri sentimenti a seconda dai movimenti dei nostri occhi ?o del nostro corpo, fino al modo in cui inviamo un’email o un tweet».
Pur illuminando le storture e i rischi di un simile avanzamento del controllo, Davies ?è convinto che alla base dell’industria ?del benessere, nelle pratiche new age, nell’aromaterapia come nella medicalizzazione unilaterale di sintomi pur di vendere psicofarmaci, ci sia un impulso incontestabilmente positivo, e ci tiene a sottolinearlo: «Ciò che funziona così bene in luoghi di lavoro che mettono l’accento sul benessere o in prodotti intesi a soddisfare certi desideri, è che a un certo livello funzionano: danno il benessere ?che promettono. Alla base c’è pur sempre il sogno dell’illuminismo, pur nella consapevolezza di come certe utopie siano finite nel totalitarismo più oscuro. Il fatto è che Bentham era incredibilmente ottimista circa le possibilità del progresso, della scienza e del potere della misurabilità».
Chissà se l’autore del “Panopticon” avrebbe mantenuto tanto ottimismo davanti agli esperimenti di manipolazione dell’umore dei propri utenti da parte di Facebook o al diluvio di app che misurano le nostre funzioni vitali per rilevare il nostro fluttuare di serotonina, per poi mandarle allo stesso Facebook o a chi ?per lui perché poi, a sua volta, le rivenda a terzi un tanto al tera. Resta che il percorso di ricerca del comportamentismo angloamericano dimostra un’imperturbabile continuità. E che sia tuttora perseguito, nonostante faccia parte della stessa ideologia che ha prodotto la crisi finanziaria dalla quale non si riesce a uscire. «Nella Gran Bretagna che cerca di togliere a tutti i costi i sussidi a certe fasce della popolazione, ci sono congerie di psicologi positivi, motivational speakers e anche terapisti che organizzano corsi di “behavioural activation” negli uffici di collocamento ?per indurre le persone a essere più attive nella loro ricerca di un lavoro, cui gli iscritti sono fortemente incoraggiati a partecipare anche quando non vogliono: ?è un caso chiaro in cui lo stato, nel nome del contenimento del debito socialmente imposto, forza le persone a parlare ?e a comportarsi in una certa maniera».
Nonostante la critica costruttiva di Davies ?a quest’ossessione del privato e del pubblico con la “felicità”, nel misurare l’impatto positivo attribuito a queste pratiche c’è poco da gioire: dal “misurabile” si passa assai facilmente al “miserabile”. E se la definizione che della felicità ha dato il sulfureo Slavoj Zizek risulta troppo oltranzista («È una categoria per schiavi», ha detto una volta il filosofo sloveno) forse ci può venire in aiuto, al riparo da qualunque accusa di snobismo, la pubblicità di una marca americana di latte: «Happy cows make happy milk».
LEGGI ANCHE
L'E COMMUNITY