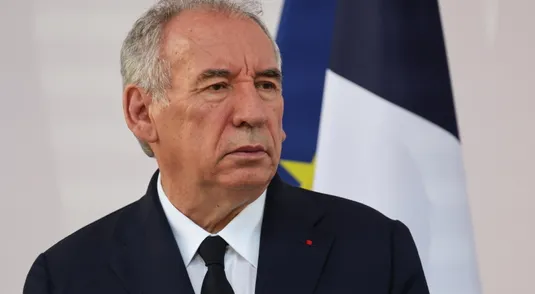«Io abito al civico 75. Quando aspetto amici a cena so che ogni volta, alle 20 e 40, arriverà la telefonata: «Sono alla Baia verde, mi ricordi il tuo numero?». Anche se è già venuto altre volte, ogni ospite non lo ricorda mai.
Stiamo perdendo la memoria. Abbiamo 40 50 60 anni, siamo convinti di mostrarne 10 di meno e fingiamo sia normale, ma tant’è. Intorno alle 22, grosso modo prima del dolce, c’è sempre un ospite (non lo stesso, però) che parla di un film visto la sera prima, anzi te lo consiglia, ma poi si ferma, tentenna e tace: qual era il titolo?
È in quel momento che parte, credo in parecchie tavole tra amici, qualunque sia il dolce e quanto il vino bevuto, in un crescendo insieme patetico e grottesco, l’osceno spettacolo dell’amnesia. Lanciamo suggerimenti, perifrasi e metonimie sin quando emergono dal pozzo film mai nati o sepolti e allora il concorso per titoli si estende, con pessime figure, retoriche e non, anche agli attori - c’era quell’attrice, aspetta come si chiama?, quella che prima era sposata col marito di quell’altra, lei bellissima, impegnata in azioni umanitarie, sì Angelina Jolie, ecco! Ma con chi era sposata?
Ricordare stanca. Dimentichiamo i numeri di cellulare dei figli, i compleanni e le date, le password e gli appuntamenti, dimentichiamo scadenze e rinnovi di polizze, certificazioni, anniversari, di ritirare cose o consegnarne altre, dimentichiamo come si chiama l’idraulico (dunque non puoi rintracciarlo in rubrica), di scrivere l’appunto sull’agenda o di consultare l’agenda con l’appunto. Dimentichiamo il codice per aprire il portone, quello per accedere alla banca on line e la parola (lo ammetto) che avevi in mente a questo punto.
Amnesy International. Ci scherzi sopra per dimenticare.
Dimentichiamo ovunque, appena possiamo, per sgravare la mente, disperderci, svaporare. E si capisce. Siamo assediati da password, pin, codici d’accesso e verifica per Bancomat, siti o servizi on line, ma disponiamo ancora di un primitivo cervello a due emisferi, molto lontano dalle prestazioni della più grezza intelligenza artificiale. Siamo insonni per questo, dicono gli esperti, abbiamo troppi dati in testa che a notte rilasciano ansia. Dimentichiamo per questo, dicono altri esperti, perché se il cervello non si depura col sonno si autopulisce resettando, dissolvendo. Succede che a volte eccede nello sgombero, e butta via anche materia utile e ancora in uso. Ma succede. Non basta salvare con nome, se non ricordi il nome.
Dimentichiamo per sotterrare minacce o traumi, diceva Freud, si chiama rimozione. Ma sfrondiamo anche per sopravvivere nella giungla di dati che ci avviluppa e assedia, inarrestabili e ingovernabili: notizie false e vere, vecchie e nuove, tutte insieme e addosso, e dunque tutte frustranti, concordi solo in un nocivo aspetto: quello di farti sentire inabile a contenerle, valutarle, scremarle. A gerarchizzarle o rifiutarle.
I gradi della disperazione sono tre, diceva Elias Canetti: «Non ricordarsi di nulla, ricordare qualcosa, ricordare tutto». In sintesi, la memoria come maledizione. Ma lui non ha conosciuto il web. Né la tentazione o il beneficio di delegare la costruzione e la gestione del ricordo a un iPhone o un Pc, capaci persino di amplificare la nostra memoria stanca e costipata. E non solo ricordando per noi, ma sottraendoci persino, nell’infinita cambusa del web, il diritto all’oblio.
È così che si perdono, sull’Etna, sempre più turisti e gitanti. Non memorizzano cartelli e sentieri, contando sul cellulare, ma poi non c’è campo o non funziona il navigatore - ed è panico. Forse è il viaggio che ci rende più svagati, inclini a deporre il peso della mente? In Inghilterra i viaggiatori ogni anno spendono 179 milioni di sterline per ricomprare le cose dimenticate a casa.
Accumuliamo e disperdiamo, rinviamo per dimenticare – cose, contatti, relazioni. I nostri iPhone grondano di telefonate perse, messaggi senza risposta, numeri senza nome, mail diventate invisibili perché finite in fondo alla fila. Una ricerca dell’Università di Glasgow propone un grande e molto opinabile riscatto per gli smemorati: sono più intelligenti, si sostiene, perché la mente che si svuota è più recettiva al nuovo.
Ma, scusate, uno scienziato, uno studioso, non dovrebbero più di altri “far tesoro della memoria”? Mnemosine, la dea greca della memoria, figlia di Urano e di Gea, cioè del cielo e della terra, ha concepito con Zeus nove figli, ovvero le nove muse, ispiratrici dell’arte e del pensiero, che dunque si nutrono di memoria. E nel mondo medievale e rinascimentale, cioè anche dopo l’invenzione della stampa, la memoria era un provvido sistema di conoscenza, una mappa di addestramento per conservare le nozioni. Un vero “teatro della memoria”, con tanto di palco, gradoni e intersezioni, era infatti il progetto di quel visionario utopista di Giulio Camillo, ideato nel Cinquecento come struttura mnemonica per il compendio e governo dei saperi e del creato, fra occultismo, filosofia ermetica e cabala.
No, diffidate di chi ci vuole smemorati, anche il mercato e i media preferiscono consumatori svagati e disattenti. Non è un bene disperderci nella schiuma dei giorni. Dimentichiamo per dissolverci ma finiamo con l’auto assolverci. E dimenticare la storia, quella tua e quella comune, può essere un torto o un abuso, non solo depurazione e leggerezza.
«Beato chi incarna la malattia del suo tempo!», disse Simone Weil. Chissà. Ogni epoca comunque ha la sua malattia, che la compendia in forma simbolica. Come l’Aids ha segnato gli anni ’90 e il tumore ha presidiato l’immaginario degli anni successivi, oggi sembra l’Alzheimer la malattia del tempo. Morbo fatale, obliquo e misterioso, non a caso indagato in tanti film e romanzi, che esprime nel modo più tragico e folle la nostra deriva del ricordo.
Patologie e studi scientifici a parte, la memoria è diventata uno spazio oscuro e ambivalente, che imbarazza. Se da una parte costruiamo musei con le cose ordinarie di ieri, tra le voci dei nonni registrate negli archivi, dall’altro riduciamo i musei a serbatoi di intrattenimento ludico e infantile, nell’ossessione mercantile di rendere presente, pulsante e tecnologica ogni testimonianza del passato. Riempiamo case e armadi di roba vintage, ma rincorriamo gli ultimi modelli di Iphone, cuffie, sneakers, jeans. Stipiamo di foto i cellulari, ma è una memoria d’istante, che vuole solo catturare, o trasmettersi al presente. Non vuole essere tramandata.
Chi non maledice ogni tanto Facebook quando ti ripropone ossessivamente ricordi inutili o molesti? La memoria può inquinare il presente come un ingombro tossico, quando è troppa o indifferenziata, e specialmente se vuoi riconfigurarti in nuove scelte di vita. E può essere im pegnativa perché è anche responsabilità. Dimenticare, non voler lasciare tracce di sé, evitare di essere o produrre ricordo, orme, è anche un modo per sottrarsi alla continuità, a una narrazione regolare, al tempo, all’età.
L’amore ai tempi di Tinder, polverizzato e veloce, asintattico, preferisce al tasto della memoria quello cancel. Si corre ma senza lasciare impronte. Amarsi e svanire, tornare al bip delle chat. Farsi corpo, incontrarsi e scorporarsi. Ghosting - cioè rendersi fantasmi.
Il più geniale esteta ed esegeta della memoria è stato Borges, che con la memoria si dilettava tanto da farne oggetto non solo di studio e di risarcimento biografico (essendo cieco vedeva con la mente) ma di fantastiche manomissioni. Ebbene, ci ammonisce lui, non è salubre nemmeno ricordare troppo. Si potrebbe finire come il “memorioso” Funes, del suo omonimo racconto, che sbattendo la testa in una caduta anziché perdere la memoria recupera quella di tutto il mondo, una memoria assoluta e spaventosa.
«Ricordò tutti i rami e i grappoli di un pergolato, la forma delle nuvole australi dell’alba del 30 aprile 1882, il tracciato della schiuma che un remo sollevò dal Rio Negro alla vigilia dell’impresa di Quebracho. (…) E non solo ogni foglia di ogni albero di ogni bosco, ma ognuna delle volte che l’aveva percepita o immaginata». Il contadino Funes conobbe così tutte le lingue, ma gli sembrarono inadatte e progettò un codice, con un sistema di numerazione singolare: «Invece di seimilatredici, diceva (per esempio) Màximo Pérez, invece di settimalaquattordici, La ferrovia, altri numeri erano Luis Melàn, zolfo, le carte di bastoni, la balena, il gas, Napoleone. Invece di cinquecento diceva nove». Troppa memoria può fare impazzire, dunque. E comunque non rende felici.
La cena è finita, intanto. Sono andati via tutti con la solita raccomandazione, «Fammi uscire», e sto sparecchiando mentre squilla il telefono: «Sono rimasto chiuso dentro, me lo apri il cancello elettrico?». Benedetto colpo di citofono. Dimenticato, anche stavolta.
Cultura
20 dicembre, 2018Numeri, nomi, fatti. Dimentichiamo tutto. Per rimuovere paure. E per resistere a giungle di dati
Amnesia, oblio e altri disastri: la malattia del nostro tempo è la perdita di memoria
LEGGI ANCHE
L'E COMMUNITY
Entra nella nostra community Whatsapp
L'edicola
Stati Uniti d'Europa - Cosa c'è nel nuovo numero de L'Espresso
Il settimanale, da venerdì 11 luglio, è disponibile in edicola e in app