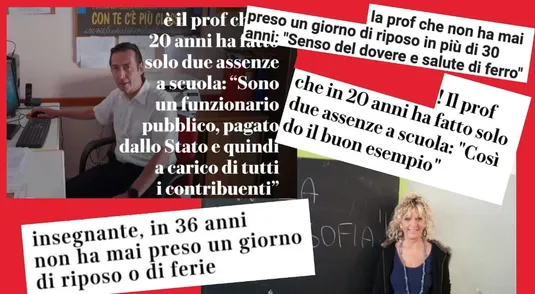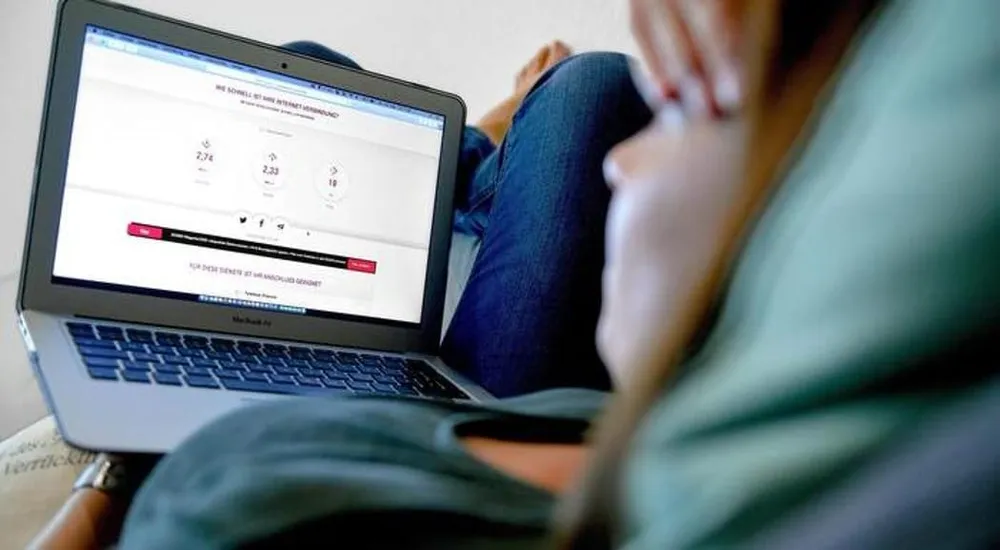
Leggo le email: ragazzi mi chiedono spiegazioni, mi avvertono che oggi non ci saranno, si scusano per compiti che mi consegneranno in ritardo, parlano di sé: vorrei rispondere, ma ci sono altre mail di genitori, colleghi, buone pratiche, pubblicità folli di sconti su vestiti, scarpe, mentre sono già le 7 e un quarto, ho acceso il cellulare, vedo notifiche, ma non ho tempo anche solo di leggere. Si è deciso che si devono iniziare le lezioni secondo l’orario “normale”, come se ci potesse essere normalità in quello che facciamo, oso una deroga minima per i miei ragazzi, cominceranno alle 8,30-9,00, finché potrò farlo, perché no, non è tutto come prima e, quando si tornerà alle lezioni in aula, allora pretenderò che siano presenti alle 8, ora no.
Rileggo gli appunti per ricordare che cosa spiegherò, approfitto di qualche minuto per cercare qualche documentario per loro ed è già arrivato il momento di inviare gli inviti: non sapevo come si gestisse una video-lezione, l’ho imparato dopo la riunione con colleghi e D.S., non saprei ridire come ho fatto, so che dovevo e ci sono riuscita.
Ieri mia sorella mi ha ricordato che è da neanche quindici giorni che tutto è cambiato, non riuscivo a crederle: il tempo si è dilatato, mi sembra siano trascorsi mesi.
All’inizio ho inviato compiti ai ragazzi, come abbiamo sempre fatto, ma è successo l’impensabile: li hanno eseguiti prima della consegna e ne hanno chiesto altri. È stato il vero segnale che niente più era come prima: il loro bisogno di un contatto, di scuola. Il primo compito assegnato era una riflessione, dopo una ricerca: scovare fake-news, annunci di profittatori sui siti di vendita online e, poi, parlare di come stessero vivendo questi primi giorni.
Ho avuto paura: quasi tutti si lamentavano di questa banale influenza che colpiva solo i vecchi e che veniva prospettata a loro, così tanto più intelligenti degli altri, come l’apocalisse, erano stufi e annoiati, contenti, certo, di non andare a scuola, ma persuasi a continuare la loro vita come prima. Non ho mai mentito ai miei ragazzi, non l’ho fatto neanche allora: ho detto che non sono un medico, che non ho conoscenze superiori all’italiano medio, ma ho precisato che quei “vecchi” potevano essere i loro nonni e che no, nessuno era immune dal contagio.
È trascorsa una vita da allora, non dieci giorni: li incontro quotidianamente e li ho visti crescere sotto i miei occhi: non sono dieci giorni. Ci connettiamo e la prima cosa che chiedo loro è come stanno, se sono usciti (ché scuola non è soltanto spiegare la grammatica o la Storia, Dante o Boccaccio: scuola è una comunità di persone che si sostengono, parlano, imparano reciprocamente) e no, mi rispondono seri, non sono usciti, se non, qualcuno, per portare fuori il cane. Li ringrazio, ricordo loro che stanno proteggendo non solo loro stessi, ma anche me e tutti gli altri.
Si fa lezione in un clima di partecipazione che non c’era in aula, non si minacciano note, sono diventati ragazzi che comprendono l’importanza di sapere; a far battute sono io, io a dire loro che possono mangiare, che se si stancano interrompiamo, che devono anche abbandonare questo schermo e muoversi, in casa, certo, ma muoversi. Per carità, c’è sempre chi ci prova a scansare l’interrogazione dicendo che il microfono non funziona o l’audio non va improvvisamente, ma quando sentono che interrogo via chat mollano, e ridiamo tutti insieme.
Il tempo è scorso via come vento: sono finite le nostre due-tre ore, dobbiamo salutarci, ripetendoci che ce la faremo, e tocca a un’altra classe. Indosso di nuovo la mia maschera a coprire ansie (perché manca Marco? Gabriella dov’è?) e si ricomincia. Le lezioni non riescono a durare quanto previsto: gli inviti non arrivano a tutti, aspettiamo venti minuti prima che ci sia la maggioranza, devi ripetere quattro-cinque volte le frasi perché non sempre l’audio funziona, rispettare gli orari è un’utopia. Così finisci per stare dinanzi al video anche fino alle 15, senza ancora aver potuto mangiare, per poi rispondere, finalmente, a chi ha continuato a scriverti mentre lavoravi, e correggere esercizi: non ce lo ordina nessuno, ci è stato chiesto di provare ad attivare lezioni a distanza, ma, sia chiaro, è una mia scelta tutto quello che faccio.
Penso talora a chi dice di considerare questo periodo come fossero ferie forzate e continuare, quando tutto sarà finito, fino ad agosto: be’, sorrido. Arrivo a sera stanca, esausta, ho scambiato poche parole con mio figlio, ma non ho il diritto di lamentarmi perché io non sono un medico o un infermiere, io non sto facendo nulla di eroico, potrei fermarmi se lo volessi, e lo farò quando non ce la farò più.
Ora non posso lasciare quei ragazzi, che non hanno il dovere di essere dotati di dispositivi per connettersi, a cui nessuno sta pagando la connessione, eppure sono lì, a cercarmi, a parlarmi, a voler imparare. Non so e non voglio sapere se anche altri hanno dimenticato il loro giorno libero, se hanno il mio stesso pensiero a ragazzi e famiglie, non giudico nessuno. Io rimango a Bergamo, nonostante le preoccupazioni dei miei familiari, ho i miei affetti saldi e solidi che mi sostengono, mio figlio che fa la spesa per me e prepara la cena per noi due, Samantha e i miei genitori che mi parlano delle loro vite, pochissimi amici, e loro, i ragazzi. Che sono stati costretti a diventare improvvisamente grandi nel peggiore dei modi, dal Carnevale al funerale. Raga’, ce la farete, ce la faremo.