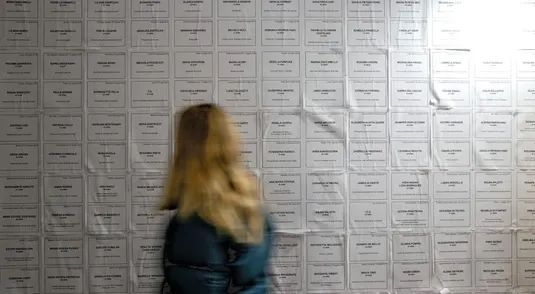La società nella quale i singoli sono chiamati a prendere decisioni personali, scriveva Karl Popper, (è chiamata) società aperta». La giovane Saman Abbas, probabilmente uccisa nel contesto familiare, una famiglia immigrata pakistana, voleva essere libera di assumere proprio quelle decisioni personali. Voleva uscire dalla «società chiusa» di provenienza per vivere con le libertà offerte dalle società aperte occidentali, non sottostare a un matrimonio combinato, essere una «Italian girl», come aveva scritto su Facebook.
La tragica vicenda di Saman, scomparsa, e probabilmente uccisa, alla fine di aprile, sta diventando un caso. Anche perché, a fronte delle scarse reazioni iniziali, donne di sinistra, come Ritanna Armeni e Giuliana Sgrena, si sono fatte sentire, denunciando la difficoltà della loro parte a trattare quel tipo di eventi; difficoltà che rischia di assumere la forma di un più o meno velato razzismo. Da destra, come già in analoghi casi, sono invece subito provenute accuse di colpevole silenzio. Quelle accuse sono fondate, anche se troppo spesso viziate non solo dal desiderio di stigmatizzare gli immigrati e la loro religione, l’Islam, ma da un errore non troppo diverso da quello che si compie sovente a sinistra: ipostatizzare la diversità. A sinistra, proprio il timore che illuminare le violenze che originano nei contesti di immigrazione, soprattutto islamici, dia spazio al razzismo, è proposto come giustificazione della «prudenza». Questa assomiglia però a un alibi, più o meno consapevole, che cela una ragione più profonda: un relativismo culturale che nel momento in cui porta a valorizzare tradizioni altre, spesso perché viste come vittime di un Occidente imperialista, conduce a tollerare comportamenti che non sono invece tollerati nella società in generale. Come se gli immigrati avessero meno diritti.
Vi è una via di uscita? Sì, anche se nulla è facile. La via di uscita è nelle potenzialità della società aperta, in quei valori universali sui quali poggia. E che non possono essere distrutti dalla pluralità delle visioni. I cittadini (e i residenti) condividono doveri e diritti. Il dovere di rispettare la legge e il diritto di essere tutelato dalle autorità pubbliche. Non vi possono essere recinti entro i quali immaginare altri diritti e doveri. Non sono dunque necessarie misure diverse, più o meno tolleranti, verso chicchessia. E non sono tollerabili arretramenti verso la tutela dei diritti di chiunque. Nei fatti questo, certo, porta a conseguenze diverse quando si affrontano casi collocati in contesti diversi: laddove l’individuo è inserito in ambiti più chiusi, la lacerazione necessaria, così come lo sforzo di educazione e socializzazione, sono inevitabilmente maggiori.
Per intenderci: il diritto di una giovane a non essere forzata a un matrimonio o a uno stile di vita va tutelato in nome di principi universali e in prima battuta con gli strumenti che si adottano per ogni cittadino; la realtà dell’immigrazione va affrontata con uno sforzo di socializzazione ed educazione (che sino ad oggi non appare soddisfacente) che prenda in considerazione lo iato tra culture. Questo comporterebbe una politica che per integrare in parte «assimila»? Sì, ed è inevitabile che una integrazione non conflittuale e che estenda agli immigrati i diritti liberali richieda un certo grado di assimilazione, quella ai valori e comportamenti fondamentali della società aperta occidentale.
La sempre più illiberale destra italiana sfrutta tragedie come quelle di Saman per stigmatizzare (e far apparire come immodificabile) la diversità altrui, ma ha gioco facile nel denunciare le contraddizioni di una sinistra che si perde nei particolarismi. L’una e l’altra hanno perso di vista la dimensione universale alla base del nostro vivere civile. La tragica vicenda di Saman Abbas potrebbe essere l’occasione per riscoprirla.