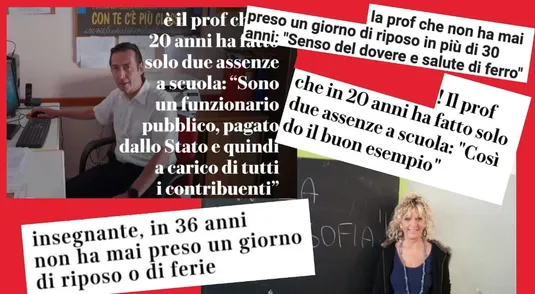«Poi le giornate sono tutte ripetitive: dormi, studia, lava, lavati, mangia, dormi... Le facce sempre uguali...». Le quarantene sono il passato, ma per alcuni giovani le ombre di quella insofferenza avranno conseguenze lunghe sul futuro. Sta già accadendo.
Le voci degli studenti raccolte dall’istituto comprensivo Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona, sono infatti quelle di decine di migliaia di studenti in tutto il Paese, per i quali la scuola è stata in questi mesi una zattera di salvataggio. Ma anche una zattera la cui direzione resta tutta da capire. Sono uscite le prime ricerche: un sondaggio Ipsos per Save the Children che parla di un adolescente su tre fra i 14 e i 18 anni che ha visto almeno un proprio compagno smettere di frequentare la scuola dall’inizio della pandemia.
Ci sono le segnalazioni in aumento alle procure minorili, a Napoli come in Lombardia, di alunni scomparsi dai registri, nel silenzio della famiglia, nella solitudine degli istituti di fronte alla continuazione dell’obbligo scolastico. C’è la preoccupazione di insegnanti e formatori davanti all’intermittenza delle presenze a distanza, con il loro corredo di incomprensioni da connessione, telecamera, wifi. Il rischio è quello di lasciare alla deriva migliaia di giovani.
Giovanni Del Bene ne è sicuro, ed è preoccupato: «Dopo tanti anni di miglioramento delle statistiche sulla dispersione scolastica, mi aspetto un aumento del dieci per cento di abbandoni nel prossimo anno». Uno studente su dieci ha già compromesso la propria fiducia nell’istruzione, rinunciando a iscriversi a un nuovo anno di studio. Psicologo, già preside dell’Istituto comprensivo Cadorna di Milano, Giovanni Del Bene è collaboratore dell’ufficio Scuole aperte del Comune di Milano; insieme ad Angelo Lucio Rossi e Rossella Viaconzi ha appena scritto “La comunità educante” per la Fabbrica dei Segni editore.

Nel libro, come nella chiacchierata con L’Espresso, Del Bene ripercorre i cardini che rendono le “scuole aperte”, a Milano ce ne sono 45, in rete con altri istituti dal Lazio alla Calabria, un modello potenzialmente cruciale per regalare futuro ai bambini e agli adolescenti, fuori dalle secche di questa pandemia. Le “scuole aperte” sono istituti che attraverso patti territoriali con associazioni dei familiari, realtà di volontariato, organizzazioni sportive e musicali, imprese e uffici, fanno sì che l’edificio-scuola non chiuda mai, mattina, pomeriggio estate, e fine settimana, e con l’edificio anche il suo ruolo educativo e soprattutto sociale. Bambini e ragazzi si trovano così al centro di una rete che possono navigare seguendo i propri interessi.
«Per questo parliamo di comunità educante. È fondamentale che i ragazzi siano motivati a mettersi in gioco, a trovare e valorizzare le loro qualità creative, di movimento, di fantasia, non solo a rispondere a prove di carattere teorico».
La scuola è infatti il primo luogo di socializzazione “obbligata” fuori dall’ambiente familiare, e quindi la prima porta dove decidere chi essere, e chi diventare. «Per andare in classe i ragazzi possono scegliere la propria immagine. Banalmente: si mettono in ghingheri, o meglio, indossano quello che gli piace per destare l’interesse del territorio. Adesso arrivano da un anno in cui sono rimasti per settimane a casa in ciabatte e pigiama. In questo modo un giovane si trova a contatto con la propria persona, senza più l’ancora dell’immagine. E non a tutti piace la propria persona. Senza confronto, depressione, autolesionismo e disturbi alimentari sono enormemente aumentati». Per cacciare questi fantasmi serve appunto il confronto. La possibilità di una relazione meno rigida con gli altri, con la cultura, con il divertimento. Una nuova modalità di scambio fra alunni e adulti.
Vivere insieme
Rossella Viaconzi è vicepreside dell’istituto Alda Merini di Milano. La pandemia «ci ha estenuati. Ha stancato tutti: studenti, genitori, professori e dirigenti», racconta: «Ci ha messo alla prova. Ma chi lavorava in rete con il territorio ha potuto in qualche modo contare su una forza in più». Sia nel bisogno, che nel rilancio della socialità. «L’anno scorso abbiamo iniziato la distribuzione dei pasti a trenta famiglie di nostri alunni, grazie a una catena di supermercati biologici e alle “brigate partigiane”».
Quest’anno l’esigenza è stata quella di non far perdere agli adolescenti il contatto con i compagni. All’Alda Merini, con le sue sedi sparpagliate in vari canti della periferia Nord Ovest della città, gli alunni hanno potuto continuare ad andare a scuola attraverso il calcio come laboratorio, ad esempio, oppure per le attività legate alla webradio, o ancora passare il pomeriggio con le mani nella ceramica, oppure a dipingere gli esterni nel laboratorio di pittura murale insieme allo street artist Pao.
«È stato possibile per la collaborazione con Fondazione Exodus di Don Mazzi», racconta Viaconzi: «Grazie alla quale abbiamo realizzato anche un’altra avventura, che mi ha colpita profondamente. Insieme a una classe di tempo prolungato che ho, dove su 18 studenti 17 sono stranieri, giovanissimi che hanno sofferto molto l’isolamento dei lockdown, e che rischiavamo di perdere, siamo stati per una settimana in barca a vela all’isola d’Elba, all’interno del progetto “Per educare ci vuole un villaggio”. È stata un’esperienza fortissima per tutti. Ho capito con un’intensità che non avevo conosciuto in tutti questi anni di esperienza come davvero la dispersione scolastica possa essere vinta solo se c’è condivisione di vita», racconta.

«Abbiamo avuto quattro giorni di mare mosso, forza 4 nello stretto di Piombino. Tutti con il mal di mare. Eppure tutti trasformati dall’esperienza comune. Dopo esser stati nella stessa classe per tre anni, li ho visti tutti sotto altri punti di vista. Nei momenti di convivialità, nei confini della convivenza, sono emersi aspetti dalla loro personalità che non conoscevo, risorse che non avevano mai mostrato. Appartenevano a nove etnie, con cinque fedi diverse, ognuno con le sue abitudini e i suoi progetti, e un effluvio di domande continuo. Sulla vita, le scelte, il domani». «Personalmente credo che la scuola sia un bivio», riflette Viaconzi. «Purtroppo irrigidirsi può portare a non comprendere più i ragazzi. Soffrono tantissimo il fatto di essere tornati in presenza e di essere valutati soltanto, come se nulla fosse stato, sottoposti a verifiche continue, quando in realtà andrebbe fatto un altro tipo di valutazione». Che parta da loro, per tornare a loro.
Tornare per i voti?
È andata diversamente. Se la prima volta è una sorpresa, la seconda è un macigno. Emersi dal doppio anno pandemico, doppia stagione di lezioni via zoom, mattinate davanti ad adulti che parlano dentro a uno schermo, migliaia di studenti italiani hanno terminato l’anno scolastico con un ritorno in presenza che sembrava segnato troppo spesso da una sola richiesta: verifiche, verifiche, verifiche. Priorità ai voti. «Lo temevo, e così è stato. Alcune scuole hanno capito l’importanza del rientro in presenza degli alunni. Altre hanno imbastito invece settimane di compiti in classe e interrogazioni a raffica. Non è questione di dibattere sull’opportunità o meno di bocciare in un anno così, ma di ricordarsi qual è il ruolo dell’istruzione. Se è una raccolta punti in vista del binomio promozione/bocciature, oppure se è un impegno per ascoltare e far crescere le competenze. Le competenze, più che le conoscenze».
Matteo Lancini è uno psicologo, psicoterapeuta, presidente della fondazione Minotauro e membro del gruppo di lavoro sulla dispersione scolastica della Regione Lombardia. E ha un’idea chiara: «In questi giorni di scrutini finali, verso la chiusura dell’anno l’8 giugno, tutti gli insegnanti dovrebbero ricordarsi cos’è una scuola inclusiva. E non gettarsi a recuperare un’autorevolezza perduta aggrappandosi a voti e bocciature, che mortificano i ragazzi e vanno ad aumentare le incertezze di quei due milioni e 400mila giovani che in Italia non risultano integrati né in un percorso formativo né lavorativo». Anche perché quell’autorevolezza di cui alcuni professori hanno nostalgia, dice Lancini, non è stata persa per un aumento indiscriminato di irriverenza casuale, quanto per i paradossi con cui gli adulti impongono ai ragazzi regole che nemmeno loro rispettano. «L’esempio principe per me è il cellulare. Gli unici che dovrebbero spegnerlo, nella nostra società, sono gli adolescenti. Per gli adulti è normale usarlo per ore, se lo fanno i ragazzi diventa dipendenza. Forse allora dovremmo partire da educare gli adulti, prima di parlare di internet come del male assoluto, e poi da un giorno all’altro obbligare i giovani ad accendere la telecamera nell’intimità della loro stanza per la videolezione». Insomma, «gli adulti perdono autorevolezza quando ripetono interventi stereotipati anziché insegnare a muoversi nella realtà contemporanea».
Territori e complessità
Da una parte quindi ci sono i fondamenti dell’esercizio di cittadinanza - socialità, capacità di esprimersi e capire, conoscere la storia - dall’altra la necessità di innovare gli insegnamenti per ascoltare di più le predisposizioni dei singoli ragazzi, i loro desideri. Se per questo obiettivo c’è ancora molta strada da fare, per il primo, anche. Secondo gli ultimi risultati Invalsi - che risalgono alle prove del 2019, l’anno scorso i test sono saltati, mentre a luglio usciranno gli esiti delle rilevazioni di quest’anno - in una regione come il Piemonte il 31 per cento degli studenti non raggiunge, in terza media, il livello base di italiano. Per matematica è il 35 per cento. Guardando al domani, le prospettive si allargano e distanziano ancora di più: fra i ragazzi dei licei l’11 per cento arriva al diploma con un italiano zoppicante secondo le griglie Invalsi, fra gli studenti dei professionali è il 54 per cento. Uno su due. A notare questi dati approfondendo i numeri della dispersione scolastica di Torino e dintorno è Luisa Donato, ricercatrice di Ires Piemonte, che ricorda come il problema dell’abbandono non sia drammatico solo nel Sud Italia, ma anche al Nord, soprattutto nella differenza fra centri e periferie.
Un esempio? «Gli Elet (Early leavers from education and training), nel 2020 il Piemonte saliranno al 12% rispetto al 10,8 del 2019, dopo esser diminuiti costantemente negli ultimi 15 anni», riflette Donato: «Considerando che l’obiettivo stabilito dalla strategia Europa 2020 è di uno su dieci, il Piemonte, già prima della pandemia, era in una situazione che definiamo di “oscillazione”. Significa che resta una parte di giovani fra i 18 e i 24 anni, con al massimo il titolo di licenza media e non più in formazione o in percorsi di istruzione, che andrebbe intercettata con interventi il più possibile precoci.
La Regione Piemonte sta provando a intervenire con un servizio di orientamento regionale. In questi due anni di scuola non in presenza, o alternata tra presenza e distanza, il numero di ragazzi e ragazze che si sono rivolti al servizio, per un supporto nella scelta dell’indirizzo di studi nel primo biennio delle superiori, è stato elevato. Questa è un’antenna sul territorio che fa capire il disagio dei giovani adolescenti nel vivere una situazione straordinaria che ha generato dubbi e insicurezze limitando di fatto anche il confronto tra pari, indispensabile nell’età in cui cambiano i gruppi di riferimento». Non solo. I dati mostrano un altro elemento: nelle province di Asti e di Alessandria la media degli abbandoni è più alta, arriva al 16 per cento, e in aumento rispetto a prima. «In genere la dispersione è sempre stata più elevata in quei contesti territoriali in cui i giovani avevano maggiori opportunità di entrare nel mercato del lavoro», riflette Donato. «Tuttavia, il sistema si fa sempre più complesso. Il lavoro diminuisce, in particolare per i più giovani, e cresce l’eterogeneità della popolazione. La presenza di persone con maggiori fragilità o difficoltà incide sui livelli di dispersione - persone con status socioeconomico basso e di origine straniera. Se anche nelle altre regioni italiane fossero disponibili dati disaggregati a livello territoriale inferiore alla regione, emergerebbe che non tutti i territori vanno alla stessa velocità né nella stessa direzione».
Il terzo salto
Orientamento, territorio, conoscenza. Pierpaolo Triani è professore ordinario di Pedagogia all’università Cattolica di Milano. Un mese fa ha commentato i risultati di una ricerca della consulta studentesca di Piacenza sull’impatto dell’orientamento nel prevenire (o causare) derive di abbandono scolastico. Fra gli studenti intervistati per il progetto «due su dieci hanno dichiarato di non essere particolarmente contenti del proprio percorso di studi, e quattro su dieci che l’orientamento in terza media non è stato utile».
«Per quanto concentrate soprattutto fra licei - quando la dispersione, sappiamo, è un problema che si aggrava soprattutto a cavallo del primo biennio negli istituti tecnici e professionali - sono risposte che evidenziano come l’azione di orientamento in terza media sia importantissimo per contrastare la dispersione. Dovrebbe essere però un coinvolgimento pratico, un modo per sperimentare sul campo attitudini e interessi, non solo valutando gli aspetti cognitivi, dando informazioni astratte, ma permettendo ai ragazzi di sperimentarsi, rispetto al loro futuro. L’esperienza concreta potrebbe aiutarli a capire meglio interessi e attitudini». Il passaggio fra la terza media e le superiori è quindi un ponte cruciale e delicato. «Ma è anche il momento in cui le direzioni si polverizzano, perché dopo il passaggio da elementari a medie che avviene nello stesso contesto urbano, o addirittura nello stesso istituto comprensivo, ci si trova a partire per una classe che si trova anche a 40 chilometri di distanza», spiega Triani.
Il problema non dovrebbero essere però i chilometri: «non è semplice organizzare un lavoro di rete che permetta di seguire le situazioni più difficili, o fragili, ma è necessario. Creando subito un legame fra scuola di partenza e d’accoglienza si può intervenire prima, e meglio, personalizzando l’azione didattica. Non basta sapersi approcciare, come molti insegnanti alle professionali già fanno, bisogna agire subito per fermare la deriva». Anche Triani condivide il timore di Del Bene: «Nei prossimi anni avremo i segnali statistici di quanto stiamo vivendo in questi mesi». Bisogna iniziare a prevenire. Irrobustendo le risorse migliori dei ragazzi, e dei territori dove vivono. Per una nuova presenza.