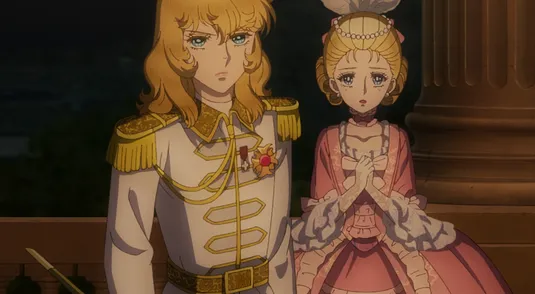Questa storia è la storia di un fantasma dentro un carcere, quello di San Gimignano: sovraffollato, senza rete fognaria e senza un direttore stabile. Il fantasma è un ragazzo tunisino di 31 anni lì detenuto per scontare una pena a un anno di reclusione. È la storia di un ragazzo senza nome per il quale altri detenuti in regime di sicurezza (camorristi e trafficanti di droga) hanno chiesto giustizia di fronte a un tribunale italiano. Delinquenti specializzati che si appellano allo Stato perché faccia giustizia contro se stesso, a favore di un delinquente. Parrebbe un cortocircuito e invece non lo è, si chiama diritto.
Questa è la storia di un ragazzo senza nome che suo malgrado si è infilato nella guerra senza fine che si combatte nelle nostre prigioni. «Il ragazzo gridava di dolore, sempre più forte», hanno scritto gli altri detenuti alla procura di Siena. «Lo picchiavano con pugni e calci» mentre era a terra, «una guardia gli ha messo un ginocchio alla gola», «gli hanno calato i calzoni» e hanno continuato a pestarlo. Poi il ragazzo sarebbe svenuto e sarebbe stato lasciato a terra. «Tornatene nel tuo paese», gli gridavano le guardie. Quindici sono indagate, quattro sono state sospese.
È la prima volta nella storia d’Italia che pubblici ufficiali vengono indagati per il reato di tortura, che fino a due anni fa neppure esisteva nel nostro ordinamento penale. La storia di questo ragazzo fantasma, che sarebbe stata solo una delle migliaia di storie invisibili di pestaggi e umiliazioni che si consumano dentro le carceri, è diventata pubblica grazie a quelle denunce ma soprattutto grazie all’esistenza di un video, ora nelle mani del pubblico ministero, che proverebbe le torture. «Senza quel video non se ne sarebbe fatto niente, in carcere la voce di un detenuto conta zero rispetto a quella di una guardia».
È Salvatore Striano a dirmelo, oggi attore di teatro e di film come “Gomorra” e “Cesare deve morire” dei Taviani, per più di dodici anni detenuto a Poggioreale e a Secondigliano per i reati commessi quando stava in strada tra i clan di camorra. Ma quando a muovere i meccanismi della giustizia sono necessari dei documenti filmati e non bastano le denunce circostanziate non è una buona notizia per nessuno. Cosa sarebbe stato del processo per la morte di Stefano Cucchi se non esistesse quel film straordinario che è “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini? Lì addirittura c’è un passaggio successivo: è il potere dell’arte di mettere nero su bianco la realtà, di mostrarla non soltanto nella sua singolare crudezza ma di farla vedere in filigrana, di esporne la radiografia, a portare il carabiniere Francesco Tedesco alla confessione e alla denuncia degli altri colleghi che ha ribaltato il processo, inchiodando i difensori dello Stato alla loro brutalità. Lì è stato un film, qui è l’asettico video di una telecamera di sorveglianza.
Cosa sarebbe stato di questo fantasma tunisino senza quel video? «Niente, nessuno se lo sarebbe cagato», mi dice Striano. «Devi capire che nelle carceri italiane c’è la guerra. È il sistema che non funziona, che rende il detenuto passivo, inattivo, rabbioso. È il sistema che lo fa uscire peggio di come è entrato. Quando io stavo a Poggioreale c’era la Cella zero. Arrivava la “squadretta”, cinque o sei agenti di polizia penitenziaria. Ti chiudevano là dentro e ti pestavano a sangue. Per vendicarsi di un’offesa, di una parola violenta, di un gesto d’ira. Ma non li condanno. Sono pochi, non hanno mezzi, sono abbandonati a se stessi. La maggior parte di loro è gente buona, poi c’è quello violento, e gli altri che non sanno opporsi. Davvero vogliamo lasciare le carceri nelle sole mani delle guardie? Così la guerra crescerà sempre di più. Noi andavamo da loro e dicevamo “Tu qua dentro ci starai fino alla pensione, io tra qualche anno esco”, e lo sapevamo che poi significava essere portati nella Cella zero. Ma era quello che volevamo. Picchiare, essere picchiati, sfogarci. Perché la galera così come è in Italia è il contrario della rieducazione, è abbrutimento».
Un abbrutimento che trova conferma in quello che è successo a Torino pochi giorni dopo i fatti di San Gimignano: sei agenti della polizia penitenziaria della casa circondariale “Lorusso e Cutugno” arrestati con l’accusa di aver commesso atti di violenza e tortura nei confronti dei detenuti. Sotto inchiesta dopo le denunce di gravi maltrattamenti è anche il carcere Mammagialla a Viterbo, dove l’anno scorso si sono uccisi due detenuti di 36 e 21 anni. L’ultimo sucidio è invece avvenuto nella prigione di Marassi, Genova, martedì 22 ottobre: un italiano di 53 anni, con problemi di alcolismo e in attesa di giudizio. A Marassi ci sono 730 detenuti che devono convivere in spazi per 525 posti e nel primo semestre del 2019 ci sono stati quasi cento atti di autolesionismo. A livello nazionale, nel 2018 ci sono stati 67 suicidi nelle carceri e 2.884 morti negli ultimi 19 anni.
Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni, diceva Dostoevskij, poiché è dal modo in cui una comunità tratta “il male” che si genera dal suo stesso seno che si vede la tempra del suo “bene”, del suo ordinamento civile. Le carceri italiane parlano chiaro della nostra attenzione per i diritti, come denuncia l’associazione Antigone: nel 2013 la Corte europea per i Diritti dell’uomo ha condannato il nostro Paese per i «trattamenti inumani e degradanti» subiti dai detenuti; il sovraffollamento è cronico (ci sono diecimila carcerati più dei letti disponibili), e in alcuni istituti (Taranto, Como) tocca il 200 per cento; mancano cinquemila agenti di polizia penitenziaria; nel 35,3 percento delle strutture non c’è acqua calda; il 7,1 percento non dispone di riscaldamento funzionante; nel 20 per cento non ci sono spazi per permettere ai detenuti di lavorare; nel 18,8 percento delle celle non si rispetta la soglia minima dei tre metri quadri per detenuto, e nel 54,1 per cento non c’è la doccia.
Le carceri italiane sfidano a uno dei più complicati esercizi privati di democrazia. Lì dentro ci finisce chi ha sbagliato, chi ha agito contro la società, ed è giusto che saldi il debito con la giustizia. Ma questo facilmente può portare chi sta fuori a non voler vedere ciò che accade nella fortezza. Chi ha sbagliato deve pagare, e se si calca un po’ la mano tanto male non farà, ci diciamo. Ma pensando così, o semplicemente scegliendo di non pensarci, siamo già ricaduti a nostra volta dentro l’illegalità. Perché in un carcere non può accadere qualunque cosa, e come dice l’articolo 27 della Costituzione «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e devono tendere alla rieducazione».
Ma la rieducazione, dentro le carceri italiane «purtroppo è lasciata al singolo caso», dice Sasà Striano, ora attivissimo in progetti di recupero e volontariato dietro le sbarre, amatissimo dai galeotti. «Quando stavo a Secondigliano c’era un detenuto che se non si metteva a cantare prima di andare a letto non riusciva a dormire. Lo chiamavano zio Alfonso e la sua voce rimbombava in tutta la sezione. Le guardie andavano, e ogni sera lo menavano, gliene davano tante finché non smetteva. Poi un giorno lo psicologo ha detto: zio Alfonso ogni sera può cantare due canzoni. Aveva pure una bella voce, e ci teneva compagnia, non faceva male a nessuno, a noi piaceva, portava allegria. Così ha smesso di prendere le botte. Basterebbe cercare di rompere il muro tra guardie e ladri, e questo si potrebbe fare facilmente. Ma nel momento in cui entri in galera sai che stai andando in guerra, che non potrai vivere pacificamente, che nessuno ti lascerà in pace, nemmeno volendo. Sono luoghi sovraffollati pieni di delinquenti e dall’altra parte di gente frustrata e malpagata, gente che a lavoro non può neanche guardare il telefono, gente che magari sta a 800 km da casa e dorme in caserma, gente che al di fuori della prigione non ha una vita vera. Comunque il peggio che ti possono fare non è gonfiarti di botte. Il peggio è se ti vietano il permesso di uscire quando hai un famigliare malato o in fin di vita. Quella è la peggiore vendetta».
Il giovane criminale di Genet ci fa riflettere. È lecito condannare a priori, senza un sussulto di possibile immedesimazione, chi per nascita è già stato condannato all’esclusione e alla crudeltà. Chi è più colpevole, ci porta a domandarci Genet, il giovane criminale fantasma spinto a seguire un destino contrario alle regole della società o chi, al riparo della propria condizione, chiude gli occhi di fronte all’inumanità che si consuma nelle carceri e stigmatizza l’errore senza domandarsi come sia possibile intraprendere la strada per estirparlo? È la famosa “rieducazione” che risuona nella Costituzione. Finché le carceri saranno abitate da guardie e ladri non accadrà. Occorre far entrare, 24 ore su 24, e in tutte le sezioni, i volontari della società civile, che già ci sono ma non hanno accesso alle sezioni, alle celle.
Io stesso più volte sono stato nelle carceri a parlare dei miei libri a detenuti che li avevano letti, e conservo ricordi di bellissime chiacchierate. Può apparire paradossale, ma esiste un’equazione tra la gravità del crimine e la sensibilità e la cultura di chi lo ha commesso. Nel carcere di Massa una volta mi sono sorpreso a parlare a lungo di letteratura e di filosofia con un assassino seriale. «Sì, ma quando sanno che devono venire da te, i detenuti cambiano come il giorno e la notte», mi dice Sasà. «Nel tragitto tra le celle e gli spazi comuni avviene il lavaggio del cervello e la trasformazione. Quando sappiamo che dobbiamo incontrare qualcuno di fuori ci trasformiamo, ci rendiamo di nuovo civili.»
Perché allora non lasciar entrare stabilmente la rete di volontari nelle sezioni, così da mediare il rapporto con gli agenti penitenziari, e convertire la passività in attività? Perché non creare presidi di umanità, gratuiti per lo Stato, all’interno delle sezioni? La potenza del film dei fratelli Taviani è ricavata proprio da questo: essere entrati per la prima volta dentro le celle, aver mostrato l’animale recluso, lì dove è tenuto lontano dagli occhi della comunità e dove può divenire soggetto non del diritto, ma della legge dell’arbitrio. «Alla vostra furbizia opporrò sempre la mia astuzia», dice Jean Genet, parlando di guardie e di ladri. Ma i due stratagemmi non sono del tutto simili?