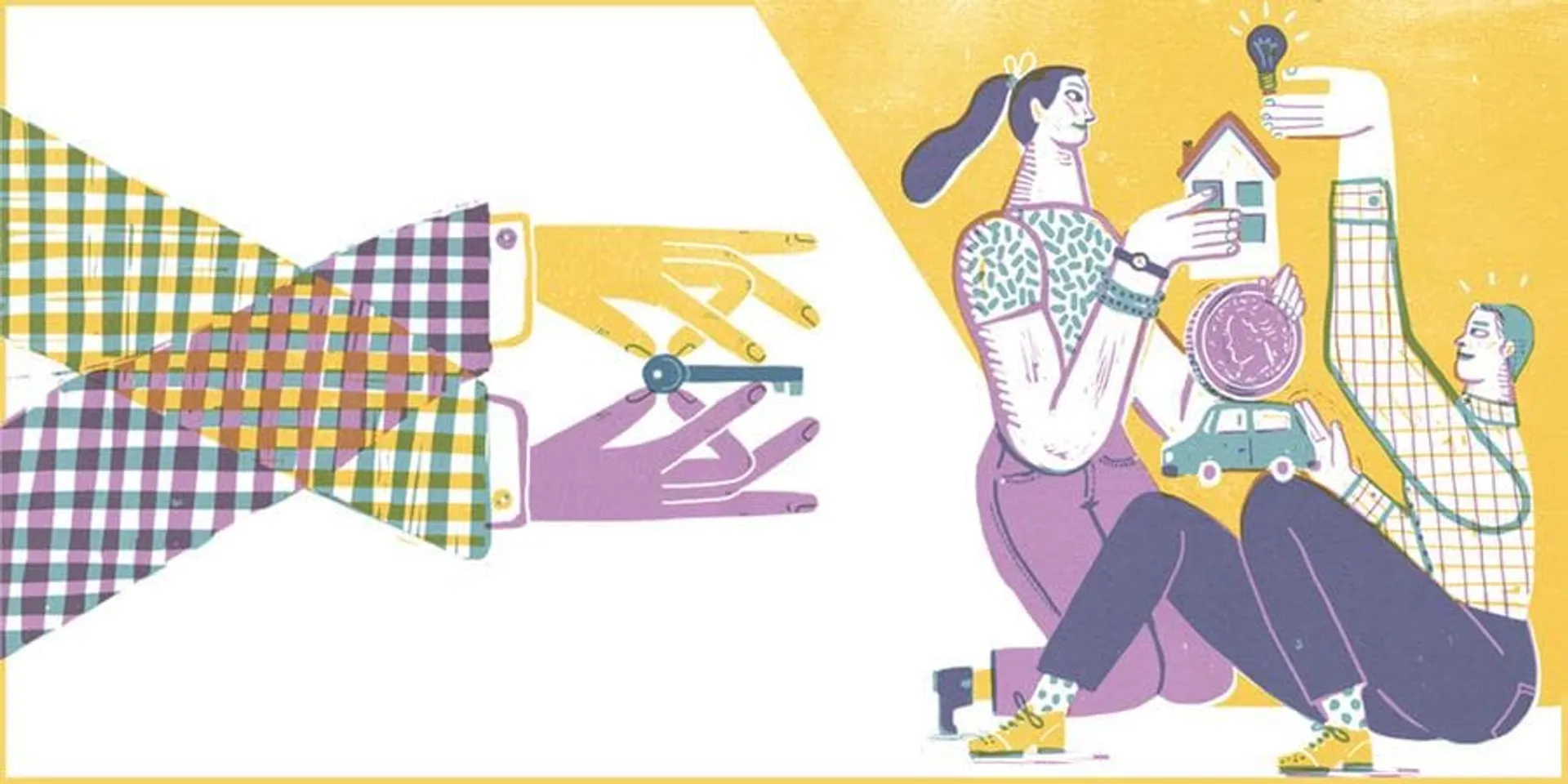Di gig economy, e dell’impetuoso sviluppo di piattaforme online come Uber ed Airbnb su cui le persone comprano e vendono servizi e lavori, ha parlato - male - Hillary Clinton un mese fa a New York, presentando il suo piano per l’economia Usa da candidata alla Casa Bianca: «Sicuramente sta creando opportunità economiche e d’innovazione eccitanti», ha detto, «ma solleva anche molte serie questioni sulla protezione dei posti di lavoro. E su cosa intenderemo per “buon lavoro” in futuro».
Le parole non mancano, per raccontare questo nuovo fenomeno che sta cambiando il mondo - sì, addirittura. Il problema è che sono parole in contraddizione tra loro: perché ne raccontano spicchi, e non potrebbe essere altrimenti. Il quadro d’insieme non ce l’ha nessuno. La sharing economy ha i suoi miti, i suoi eroi - e i suoi mostri. Ha sacerdoti e fedeli, ma anche esorcisti. Più rari gli agnostici: l’economia della condivisione in realtà è divisiva, perché incarna opposti. Evoca l’etica del condividere, così familiare a chi è di cultura cristiana (“Prendete e mangiatene tutti”), ma anche il liberismo più sfrenato; prelude alla possibile fine della proprietà privata, ma anche alla creazione di moloch monopolistici; rende ciascuno micro-imprenditore di se stesso, capace di far fruttare al meglio i suoi talenti e le sue risorse (un’auto, un oggetto, una casa), ma può anche farci tutti più poveri e insicuri.
Se è vero che questa, come sostiene l’economista Jeremy Rifkin, è la Terza Rivoluzione Industriale, ci siamo dentro fino al collo ed è difficile allungare più di tanto lo sguardo. Ma quando l’avremo attraversata tutta nulla, probabilmente, sarà più come prima: non il concetto di proprietà, non il lavoro, non le nostre città. Come saremo? Per ora possiamo ipotizzare scenari.
IL MIGLIORE DEI MONDI POSSIBILI. Secondo lo studioso americano, il capitalismo come lo conosciamo è sostanzialmente destinato a sparire, travolto dall’economia collaborativa. Nella quale - grazie alle nuove tecnologie e alle piattaforme social - ciascuno oggi può diventare produttore/fornitore di beni e servizi a costi irrisori (è la sua “società a costo marginale zero”). Esempi? Per trovarne a tonnellate, un ottimo lavoro sull’argomento l’ha fatto un’italiana, Gea Scancarello, che da Chiarelettere ha pubblicato “Mi fido di te. Lavorare, viaggiare, mangiare, divertirsi: un nuovo modo di vivere con gli altri e salvarsi”. Entusiasta del mondo sharing, del «collaborare e condividere per stare bene», Scancarello prova e racconta - in Italia e all’estero - moltissime piattaforme: da Sfinz.com (persone che si mettono a disposizione per lavoretti di casa) a BeWelcome (per couchsurfing, l’offerta di divani su cui dormire in viaggio); da MyndMyHouse (house-sitting, si bada a case di persone in vacanza) a BarattoBB.it (strutture per viaggiatori low cost: accettano di essere pagate con piccoli lavori invece che soldi); prova food sharing (contro lo spreco del cibo), carpooling, social eating, e via andare. Dimostrando che è ormai possibile lavorare, viaggiare, mangiare, divertirsi in modo assolutamente alternativo ed economicamente sostenibile - purché ci sia fiducia reciproca. Fidarsi degli altri, e meritarne la fiducia, è fondamentale in queste interazioni. La reputazione online diventa la vera carta d’identità di ciascuno. Per questo, scrive l’autrice, «i vantaggi economici non sono nemmeno i più importanti: al di là del denaro, ci si arricchisce di energia e consapevolezza».
È IL BELLO DELLA DISINTERMEDIAZIONE. Come ha scritto recentemente sul Sole 24 Ore Franco Debenedetti partendo dalle complicate vicende di Uber in Italia «l’esclusività di un servizio in cui il pubblico controlla e programma è irrimediabilmente finita, perché in piccolo riproduce un modello, l’economia di piano, che la storia ha, alla grande, seppellito». È il modello raccontato da siti come “Collaboriamo!” (animato tra gli altri da Marta Mainieri) o il convegno Sharitaly (prossima due giorni il 9 e 10 novembre), e con passione da personaggi come April Rinne, che al World Economic Forum guida lo Sharing Economy Working Group. Un modello così seducente che molte aziende tentano di spacciarsi per tali: prima facevano “greenwashing”, dandosi spruzzate di verde e sostenibilità, oggi molte fanno “sharewashing”.
E SE INVECE FOSSE UN INCUBO? Gli apocalittici del terzo millennio nella sharing economy vedono scenari più ansiogeni. «La Gig economy crea insicurezza e rischio», scrive il 5 agosto il Financial Times in un servizio della serie dedicata a “The new world of work”. E sottolinea l’irresistibile ascesa in Europa, dove la protezione dei diritti del lavoratori è sempre stata solida, del “Precariat”: quei giovani che, nel Vecchio continente, si arrabattano ora tra mille lavoretti precari. Tecnologia e globalizzazione stanno ridisegnando il mondo del lavoro, scrive Sarah O’Connor da Londra, e si sta aprendo una profonda frattura generazionale tra adulti iper garantiti e giovani senza certezze.
I francesi hanno creato una parola per descrivere il tutto, copyright Maurice Levy, patron di Publicis: “Uberisation”. Che suonerebbe la campana a morto per i lavoratori dipendenti e le loro tutele. Siamo all’invasione dei barbari, annuncia L’Expansion, riferendosi a Uber e ai suoi fratelli, che spaziano tra turismo e trasporti, ristorazione e servizi legali, immobiliare e offerte di lavoro. Sì, per ora i consumatori sono entusiasti dell’esplosione della concorrenza, avverte il giornale, ma la soddisfazione rischia di durare poco, perché un intero modello sociale viene messo a rischio. Di “Precariat” parla anche Derek Thompson su The Atlantic, in una recente splendida riflessione su “A World Without Work”, un mondo senza lavoro: la cui “evaporazione” starebbe creando un mondo di freelance che combattono tra loro e - non bastasse- con la “robottizzazione” del lavoro. Con un imprevisto effetto collaterale: a molti giovani questo mondo nuovo non dispiace, scrive Thompson, perché li fa sentire indipendenti e gli lascia il tempo di seguire le proprie passioni.
Forse, se si oscilla così tra apocalittici e integrati, accuse di neofeudalesimo ai signori della sharing economy e inni scespiriani al “Magnifico Mondo Nuovo”, è perché a questo fenomeno si ascrivono troppe cose, troppo diverse tra loro: giganti come Airbnb (che in Italia dal 2008 ha fatto soggiornare 2,7 milioni di viaggiatori, dispone di 150mila alloggi e vale già il 15 per cento del mercato delle camere) e la signora Maria che cucina una porzione di pasta in più e la offre su MamaU o Cucinaecondividi.
Vero è che una cosa in comune ce l’hanno: il bisogno di un orizzonte più vasto. Nella logica della sharing economy c’è il consumo consapevole, basato su riutilizzo invece che acquisto, accesso invece che proprietà. L’assunto? Si vive bene anche senza possedere, anzi: possedere può essere un freno al proprio miglioramento sociale ed economico. Una rivoluzione. Che nella pancia ha tematiche di ambiente e sostenibilità, del miglior uso delle risorse, della crescita sostenibile. In cui al centro si mettono le persone, e la qualità dell’esperienza più che la quantità del consumo. In cui si sceglie di appartenere a una community: per chi ci crede, lo scambio non è solo di beni e/o servizi ma umano; la convenienza non solo economica, ma relazionale.
UN NUOVO SENTIRE. Che anima anche le “shareable city” del mondo, Seul prima di tutte le altre, perché il sindaco l’ha voluta capitale mondiale delle città collaborative. Ma ci sono anche le esperienze sociali di Lille, in Francia, con “Les Fenêtres qui parlent” (in febbraio artisti espongono le loro opere alle finestre dei cittadini che le mettono a disposizione: l’arte si fa accessibile a tutti, interno ed esterno dialogano, pubblico e privato si mescolano); gli orti urbani collettivi gratuiti di “Incredible Edible”, nati in Inghilterra e diffusi ora in un centinaio di città nel mondo; l’esperimento del sito “Peuplade”, che usa la rete per creare incontri, scambi e condivisioni reali tra persone che abitano lo stesso quartiere.
In Italia la capitale della sharing economy è Milano. Palazzo Marino ha aperto in luglio un tavolo con 75 operatori ed esperti di sharing economy che porterà all’inaugurazione della Casa della Collaborazione, con uno sportello (in vicolo Calusca) di formazione e informazione sulla cultura collaborativa, e a una serie di accordi con operatori. Milano è capitale anche della mobilità sostenibile: il primo esperimento di car sharing è arrivato nel 2004, col servizio “GuidaMi” del comune (poi sono arrivati Enjoy, Car2go, twist, Share’n go); oggi si conta su una flotta di 4500 biciclette per bike sharing e a luglio sono arrivati anche i primi 150 scooter (Piaggio Mp3 a tre ruote) in condivisione.
Dietro la galassia della condivisione c’è voglia di un nuovo modello economico, virtuoso, capace di suscitare passione. Per questo oggi gli economisti, da Piketty allo stravagante Varoufakis, si stanno prendendo i riflettori prima puntati sugli archistar: perché sono loro a progettare utopie possibili. Condivisibili.
La sharing economy, qualunque cosa si rivelerà davvero essere, è un formidabile incubatore di storie. Porta dentro di sé speranze, sogni e incubi forse: la fine del lavoro, la fine della proprietà, perfino - vaticina Jacques Attali - la fine della coppia. La rivoluzione è cominciata, ed è qui per restare.