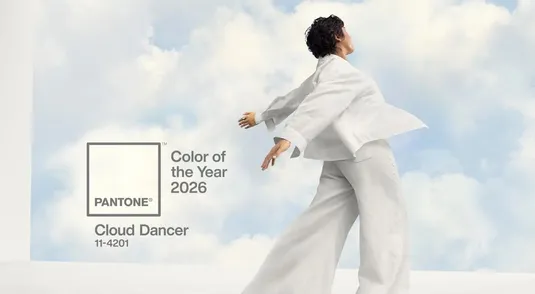Sei gay? Stenditi sul lettino. Anno 2019, è ancora questo l’invito rivolto ai giovani omosessuali che escono allo scoperto. Se prima lo sguardo della società nei confronti delle persone Lgbt era in via di trasformazione, oggi è obliquo. Si riflette in politica quasi come sulla psicoanalisi. Una sintonia che trova manforte in chi dentro il governo condanna l’omosessualità, nel ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana che sostiene processioni riparative dopo il passaggio di gay, lesbiche e trans durante i Pride. Oggi l’Italia sembra voler accelerare ogni tentativo di patologizzare quell’orientamento sessuale che l’American Psychological Association definisce una «variante naturale normale e positiva della sessualità umana» e l’Organizzazione mondiale della sanità una «variante naturale del comportamento umano».
Nonostante il movimento per i diritti Lgbt abbia fatto passi da gigante nei cinquant’anni dagli scontri di Stonewall, in Italia le persone gay e lesbiche vengono rispedite dai “curatori”. Malate, come cinquant’anni fa. Una macchina del tempo che riporta di moda le teorie di riparazione che per anni hanno violentato l’autostima delle persone Lgbt.
TU NON POTRAI AMARE
«Mia madre scopre che sono gay leggendo i miei diari. Non mi dice nulla, decide di mandarmi in seduta». Alessandro mentre racconta la storia dei suoi 17 anni in provincia di Foggia, si passa una mano nei capelli ricci. Lo fa spesso, tutte le volte che pronuncia il nome del suo ex psicologo: «Lei lo conosceva perché spesso partecipava a dei convegni organizzati dall’Azione Cattolica».
Questa è la storia di una madre che un giorno vede suo figlio per la prima volta. «Forse è confuso», pensa, «lo aiuto». Senza parlare. «Sicuramente soffre», dunque può portare al terapeuta il suo particolare affanno. È la reticenza dei padri e delle madri che non riescono a varcare la barriera del silenzio con i propri figli. Cosa accade nella cameretta dalla porta chiusa? Leggono di nascosto i suoi diari, decodificano atteggiamenti e giornate. Una comunicazione interrotta che questa madre cerca di ricostruire mandando il figlio da uno psicologo molto noto in città. Alessandro va in seduta per un anno intero: «Entro e inizio a raccontare le mie giornate. Gli dico che sono gay. Così mi sottopone a una serie di domande (il test Minnesota ndr). Imbarazzanti come quelle sul ruolo sessuale “attivo o passivo”. A fine seduta mi mette in mano un libro di Nicolosi, che per un anno ho nascosto sotto il materasso». Joseph Nicolosi, psicologo clinico americano che ha fondato il Narth, Associazione per la ricerca e la terapia dell’omosessualità. I suoi studi considerano i comportamenti omosessuali fallimenti nella corretta identificazione di genere. Così Alessandro inizia il percorso di “guarigione”.
«Diceva che l’omosessualità derivava da un complesso di inferiorità che ha una persona nei confronti di quelle dello stesso sesso. Questo complesso ti porta a provare delle attrazioni. Poi cercava di correggermi». “Riparazioni”, spiega Alessandro, che partivano dall’atteggiamento: «Diceva come dovevo camminare, gesticolare, parlare perché secondo il suo punto di vista ero troppo effeminato». E poi il sesso. «Quello gay lo definiva masturbatorio. Un sesso che non poteva portare a niente altro. L’amore omosessuale non esiste». Un anno lungo una vita per un ragazzo di 17 anni. «Avevo già difficoltà ad accettarmi. Lui mi raccontava ogni volta cose che hanno trasformato il mio percorso in una scalata. Ed era subdolo. Non poteva dire apertamente che correggeva le persone omosessuali, ma dai colloqui capivi qual era il suo obiettivo. Mi consigliava di giocare a calcio, fare cose che fanno i maschi. Una volta disse che la scelta di non ritenere l’omosessualità una malattia era stata una scelta puramente politica. “Non aiutiamo più le persone perché rischiamo che ci facciano un esposto”. Era consapevole». Si passa ancora la mano nei capelli Alessandro e poi spiega: «Insisteva dicendo che avrei dovuto tagliarmi i capelli. Erano lunghi, ricci e per lui avevo un viso efebico, non aiutava. Li tagliai. Quando mi guardai allo specchio capii che non era quello che volevo. Avevo fatto questo taglio perché avrebbe dovuto aiutarmi, farmi sentire più maschio. Non mi piacevo. Litigammo, compresi quanto mi aveva plagiato».
Alessandro però si salva. Si trasferisce a Roma per continuare gli studi, interrompe le sedute: «Ero pieno delle parole che mi aveva raccontato quello psicologo. Un represso con una visione squallida del mondo omosessuale: solo sesso e niente affetti». Poi attraverso i social si fa coraggio. «Ho conosciuto un ragazzo. Mi sono innamorato. Ho capito: non è vero che non c’è amore in questo mondo». Ci ha messo due anni, il sortilegio alla fine si è spezzato. «Un giorno i miei genitori mi hanno detto “Non abbiamo parlato per tutto questo tempo, ma ti abbiamo accettato. Abbiamo fatto un percorso per capire”».
RIVOGLIO I MIEI 14 ANNI
R. è stata mandata in terapia quando aveva 14 anni. Siamo nelle Marche, sono state approvate le unioni civili da poco tempo. «Vengo da una famiglia cattolica praticante. Mia madre è il punto di riferimento di tutti i parrocchiani. Un giorno ha scoperto che ero lesbica». Inizia così. Un rapporto conflittuale. Urla, pianti e anche schiaffi, tantissimi. Un giorno la madre le dice che avrebbe potuto aiutarla a farsi «mettere a posto». Si rivolge a un’amica di famiglia che la manda da «una psicologa di fiducia. Molto nota per la sua carriera decennale». R. cerca di ricordare quel giorno: paura e rabbia. Ansia. Tanta. «Ricordo le sensazioni, ricordo le frasi e lo studio che sembrava una soffitta. Eppure vedo quella ragazza con lo sguardo di un’altra. Come se fosse un film, una favola». È una favola nera che la getterà nel buio per anni. «Siamo saliti su questa soffitta piena di libri e con le luci soffuse. La seduta era iniziata con mia madre. La psicologa prendeva appunti. Io in un angolo. Mia madre le chiedeva di “sistemarmi”, la psicologa annuiva».
«Poi mi sono ritrovata da sola. Sono arrivate una serie di domande strane: se avevo fatto sesso con una lei. Se mi era piaciuto. Ma una frase mi sconvolse: disse che era una malattia. “Stai tranquilla”, diceva, “è una malattia curabile. Basta lavorare sul pensiero”. Il problema, diceva, era il rapporto difficile con mio padre. Litigavamo. Per questo, mi spiegava, ho sviluppato un odio verso gli uomini». Il fermo immagine di lei che pronuncia «curabile», R. non lo scorderà mai. «Avevo 14 anni. Quella seduta mi ha uccisa».
R. non torna più dalla psicologa. Soffre, si chiude in un silenzio totale per un anno intero («Ero in blackout»). Una ragazza di 14 anni è una persona a cui la vita deve ancora succedere e non lo sa. Non riesce a vederla attraverso la lente della saggezza che arriva con gli anni che passano, della resilienza, delle cose che possono cambiare. «Non vedevo via d’uscita. Mi trovavo in questo angolo buio e pensavo a cose orribili. Forse aveva ragione la psicologa: ero malata».
La madre approva questo stato di isolamento. «Uscivo soltanto per andare a scuola. Mi veniva a prendere, parlava con le mie compagne per capire la mia giornata. Controllava ogni movimento. Non ho avuto altri contatti se non con le persone della chiesa. Io, del resto, sono cresciuta lì, in un modo o nell’altro ci ricadevo». I social, la sponda tranquilla di una generazione non aiutano: «Mia madre controllava la cronologia, i miei messaggi. Se penso a quella ragazza vedo una storia diversa dalla mia», ripete. «Invece no. Ero io. Ero fragile ed ero sola».
Dopo un anno la madre affida R. a un altro terapeuta. A 15 anni aveva sviluppato attacchi di panico, ansia. «Con lui non abbiamo mai affrontato il discorso sulla mia sessualità. Poi ho deciso di non fare terapia». È il tempo a liberarla: «Mia madre ha capito. Ci ha messo un po’. Si è informata, ha fatto un percorso da sola. Ha detto che ha dovuto metabolizzare anche lei questa cosa per il background che ha. È successo dopo una litigata in treno. Delle signore criticavano le unioni civili usando termini non proprio amichevoli, non ce l’ho fatta e mi sono inserita nella conversazione. Sono tornata a casa piena di rabbia, mi sono sfogata su mia madre. Mi sono ribellata dopo anni. Mi ha ascoltato, in silenzio, poi mi ha detto che in me non c’è nulla di sbagliato, sono sua figlia». La psicologa? «Lavora ancora, in quello studio che ricorda una soffitta».
IL DENTISTA RIPARATORE
Un ex tossicodipendente, un padre di famiglia, un collaboratore della curia, un dentista. Andrea, ragazzo di 19 anni della provincia di Arezzo, si trova davanti un “riparatore” con un curriculum particolare. Non è intimorito, né insicuro. Ci va perché sua madre lo implora. «Facevo parte di Arcigay, vivevo un periodo anche tranquillo in casa», racconta. «Mio padre vuole conoscere anche il mio ragazzo. Mia madre invece ha paura. Degli altri soprattutto. Proprio per questo mi chiede di andare con lei da un amico di famiglia».
«Voglio essere convinta delle tue scelte», insiste la madre. Un invito che raccoglie con il senso di una sfida. «Mi trovo in questa casa con un 50enne che non avevo mai visto, nonostante conoscessi tutti gli amici di mia madre». «Sei consapevole che potresti cambiare idea?», gli chiede. Andrea lo sa. Non è un’idea. Ma vuole capire dove questo signore “amico” di famiglia vuole arrivare. Parte la messinscena: dice quel che ha da dire, quel che deve dire, fissando un punto davanti a sé. «Sì». «Ti posso indirizzare a un corso. Per capire meglio te stesso». «In che senso? ». «La Chiesa organizza questo corso dove si dialoga per arrivare a capire cosa si vuole dalla propria vita. Conoscendo la Bibbia, indirizzandoti verso lo giusto stile di vita. Essere gay non è corretto. Un uomo è nato per procreare con una donna. Fissiamo un incontro?», dice. «Ti parlo da padre di famiglia, ex dipendente, collaboratore della Chiesa e anche dentista. La chiesa mi ha fatto fare un corso per aiutare le persone, sono un consulente. Non sei il primo, non sarai l’ultimo. Non sei malato. Non sei effeminato, non ti senti intrappolato in un corpo da uomo. Non hai una patologia, sei solo sbandato». Termina così il colloquio. In macchina la madre di Andrea sospira. «Chi me l’ha fatto fare?». Si scusa tra le lacrime. «Non importa, non lo sapevi». Due frasi e si ribaltano i ruoli. I figli di questo tempo trovano le parole per una battaglia che non è solo virtuale. Se una generazione si è perduta, la successiva resiste. I figli si ribellano, poi spiegano la vita vera com’è. Attraversano i tabù, danno un nome alle cose, raccontano quel che accade nella mente e nel cuore. I genitori, confusi, si fanno aiutare.
Un percorso difficile, lungo. La comunità Lgbt lo sa. La realtà vince sulla sua rappresentazione, sulla mistificazione di chi ne fa solo uno show da like e post su Facebook.