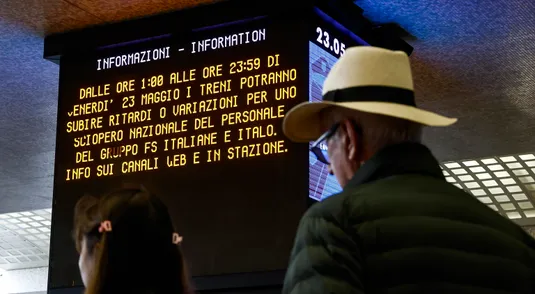Nelle parole c’è la volontà di denunciare le mancanze - dal personale che scarseggia, alle introvabili mascherine -, e l’urgenza di condividere il peso della sofferenza, che è enorme. «Qui, nel nostro ospedale, abbiamo trascorso le prime due settimane a vincere la resistenza della direzione sanitaria, contraria a creare percorsi di isolamento, dal triage alle rianimazioni. Siamo riusciti a spuntarla e a mettere a punto il sistema appena in tempo, perché il giorno successivo i letti sono stati tutti riempiti, al ritmo di un nuovo paziente ogni quindici minuti. Eravamo già sotto organico prima che tutto questo cominciasse, figuriamoci adesso».
L’aiuto viene dai colleghi specialisti di altri reparti: chirurghi, fisiatri, dermatologi, persino gli anatomopatologi si fanno avanti, «perché di pneumologi, rianimatori e anestesisti ce ne sono pochi e sappiamo che le aziende sanitarie non riusciranno ad assumerne di nuovi. Non per cattiva volontà, semplicemente perché non ce ne sono. Quelli in pensione non hanno risposto alla “chiamata alle armi” (se non in minima parte), spaventati dall’elevata contagiosità del virus. Ed è impossibile fargliene una colpa».
I tentativi della Regione Lombardia di assumere nuovo personale hanno dato scarsi risultati, se non altro perché i contratti offerti sono temporanei, occasionali e non danno garanzie. Hanno risposto pochi specializzandi, perché le graduatorie erano già state esaurite mesi fa, ma molti giovani medici neolaureati disposti a entrare subito in corsia, benché privi di formazione. Nelle aree più colpite di Bergamo e Brescia sono stati arruolati una ventina di medici dell’esercito. Una boccata d’ossigeno. L’assessore lombardo alla Sanità, Giulio Gallera, ha promesso che nuovi medici arriveranno dall’estero. Forse dalla Cina. Chissà.
Nel frattempo, chi sta in prima linea, non si illude. Combatte consapevole che i rinforzi potrebbero non arrivare mai: «Qui siamo rimasti in due, ma servirebbero almeno tre pneumologi e altrettanti rianimatori», dice un medico bresciano. «Qualche speranza viene dai colleghi di altre specialità che si rendono disponibili. Li stiamo formando. Il che implica una doppia fatica: da un lato siamo chiamati a curare i pazienti affetti da Coronavirus, bisognosi di moltissima attenzione, e dall’altro dobbiamo insegnare le manovre ai colleghi. Oggi è arrivato uno specializzando in ortopedia e una fisioterapista, per dare una mano: ci vorrà un mese per renderli autonomi, ma ogni aiuto è prezioso e speriamo arrivino altri camici bianchi in nostro soccorso».
Il ruolo della pneumologia e dell’infettivologia è fondamentale per ritardare il ricorso all’intubazione e l’ingresso in rianimazione: «Quello è il vero collo di bottiglia. Non ci sono più letti e dobbiamo fare il possibile per rallentare le crisi respiratorie: sono in fase di sperimentazione alcuni farmaci che sembrano avere una certa efficacia, ma nel complesso siamo impotenti di fronte a polmoniti spaventose che si sviluppano e peggiorano in pochissime ore», racconta un internista di Varese.
Si tampona, insomma, mentre Regione Lombardia fa il possibile per reperire i respiratori e le macchine che consentirebbero di attrezzare un ospedale di emergenza da 500 posti letto nei padiglioni della Fiera di Milano: «Premesso che la Regione si sta muovendo bene, ci domandiamo come intendano poi reperire il personale medico e gli infermieri per far funzionare quei macchinari», si domanda un anestesista del San Gerardo di Monza. Che continua: «Nel nostro ospedale i turni sono già massacranti e il lavoro è reso ancora più complicato dal delirio della vestizione per entrare nei reparti Covid-19, nonché dalla paura di infettarsi. I pazienti Covid stanno mangiando tutto lo spazio disponibile dell’ospedale, ti giri e vedi che le zone da coprire diventano sempre più estese, i malati da assistere non finiscono mai. Le chiamate dai reparti di infettivologia sono sempre più frequenti, chiedono a noi anestesisti di decidere quando è grave ogni singolo paziente: dobbiamo valutare se è sufficiente un casco respiratorio o se è necessario eseguire l’intubazione e attaccare il respiratore. Poi ogni paziente deve costantemente essere monitorato, per almeno due settimane. Di nuovi medici non ce n’è, se non qualche giovanissimo agli ultimi anni della specializzazione. Continuo a domandarmi come faranno a gestire un nuovo ospedale, forse sposteranno lì qualche primario da altre zone: sarà comunque molto complicato».
La sofferenza psicologica degli operatori in prima linea è fortissima, come racconta Francesca Baitani, infermiera in un reparto di Infettivologia Covid 19 dell’Emilia Romagna e referente del sindacato Nursing Up: «Soffocano e muoiono soli. L’impatto psicologico su noi infermieri è devastante, restiamo bloccati nella tuta protettiva e non c’è il tempo e il modo di offrire un gesto, una carezza umana, viene meno persino l’atto caritatevole di accompagnare queste persone verso la fine. È l’apocalisse, manca totalmente un supporto psicologico per noi infermieri e medici, per aiutarci ad affrontare l’enorme livello di tensione. Non oso pensare a cosa succederà da qui alla fine del mese, quando il picco arriverà e ci troverà sfiniti e senza una seconda linea che possa sostituirci. Per ora reggiamo, abbiamo ancora livelli alti di adrenalina e siamo abbastanza forti per dare assistenza a tutti, ma come faremo a sostenere questo ritmo sul lungo periodo? Sono preoccupata dell’effetto “burnout” che potrebbe piombarci addosso proprio quando dovremo dare il massimo per salvare centinaia di vite umane».
Il burnout, l’esaurimento emotivo, è una reazione della mente e del corpo a un sovraccarico da lavoro, che porta a un improvviso spegnimento energetico, riduzione della lucidità, della capacità d’attenzione e dell’efficienza nella cura dei pazienti. «Continuano a girare voci sull’arrivo di nuovi infermieri, ma qui non abbiamo ancora visto nessuno e temiamo che, anche se dovessero arrivare, non avranno l’esperienza per lavorare in autonomia», racconta Francesca, che lavora da 18 anni in un reparto di infettivologia.
C’è poi il rischio contagi per medici e infermieri, tutti lamentano l’assenza di dispositivi di sicurezza. Chi non li ha già terminati, li utilizza con enorme parsimonia: «Il 12 per cento degli infettati in Lombardia sono proprio sanitari: significa 700 professionisti sono fuori gioco, su un organico di 14mila lavoratori. Io stesso ho contratto il virus pochi giorni dopo essere arrivato in corsia a dare una mano», spiega Stefano Magnone, sindacalista dei medici iscritti all’Anaao e chirurgo all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, epicentro dell’emergenza. Proprio lì, in tempi record, sono state liberate persino le sale operatorie per fare spazio agli infettati. I pazienti con altre patologie sono stati trasportati a bordo di ambulanze in ospedali lontani. Tutto il personale è stato velocemente addestrato ad affrontare l’emergenza: «Con i pazienti ho sempre indossato i dispositivi di sicurezza, ma non con i colleghi medici, da cui probabilmente ho contratto il virus. Così ci siamo ammalati e siamo stati messi in quarantena. Sto abbastanza bene, non sono preoccupato per la mia salute, piuttosto sono angosciato perché non posso essere utile in corsia, dove la situazione sta diventando insostenibile».
Le mascherine protettive sono esaurite e questo sta provocando un aumento esponenziale dei contagi fra i sanitari, che non vengono neppure testati. È questo il problema maggiore, a cui le centrali di comando, il governo, la protezione civile, le Regioni, non sanno rispondere. Racconta un operatore socio-sanitario della Brianza, responsabile della cura domiciliare agli anziani, che le Asl hanno fornito a tutti un kit protettivo con una sola mascherina chirurgica: «La sto riusando di giorno in giorno. La indosso da oltre una settimana, ormai non credo serva a qualcosa e non so neanche perché continuo a indossarla. Forse la metto per non allarmare ulteriormente gli anziani allettati, di cui mi occupo quotidianamente. Anche il camice non è adeguato e ho il timore che il mancato ricambio dei dispositivi di protezione possa contribuire a infettare i miei pazienti: alcuni sono già stati ricoverati per Covid 19, così come alcune colleghe. Il tampone? A me non l’hanno fatto e neanche ad altre colleghe che lamentano febbre alta».
Stessa situazione per gli infermieri addetti al prelievo e per tutti quelli non direttamente a contatto con gli allettati da Covid-19: «Le commesse dei supermercati hanno molte più protezioni di noi. La mascherina chirurgica non ci protegge e neppure il camice. Ogni giorno andiamo a lavorare terrorizzati, perché tutti ci stiamo ammalando. Scarseggiano anche i tamponi: non sappiamo neppure se siamo positivi. Io ho portato mia figlia a casa dei nonni, perché il rischio di contrarre il virus per me è altissimo», racconta un’infermiera del Veneto. Mentre le sue colleghe di Monza hanno fatto una raccolta fondi e sono andate a recuperare delle nuove mascherine in un negozio della città, che ha chiuso poche ore dopo per esaurimento scorte. Uscite dal negozio hanno commentato: «È come se ci avessero mandato in guerra con arco e frecce, contro un nemico che imbraccia il fucile».