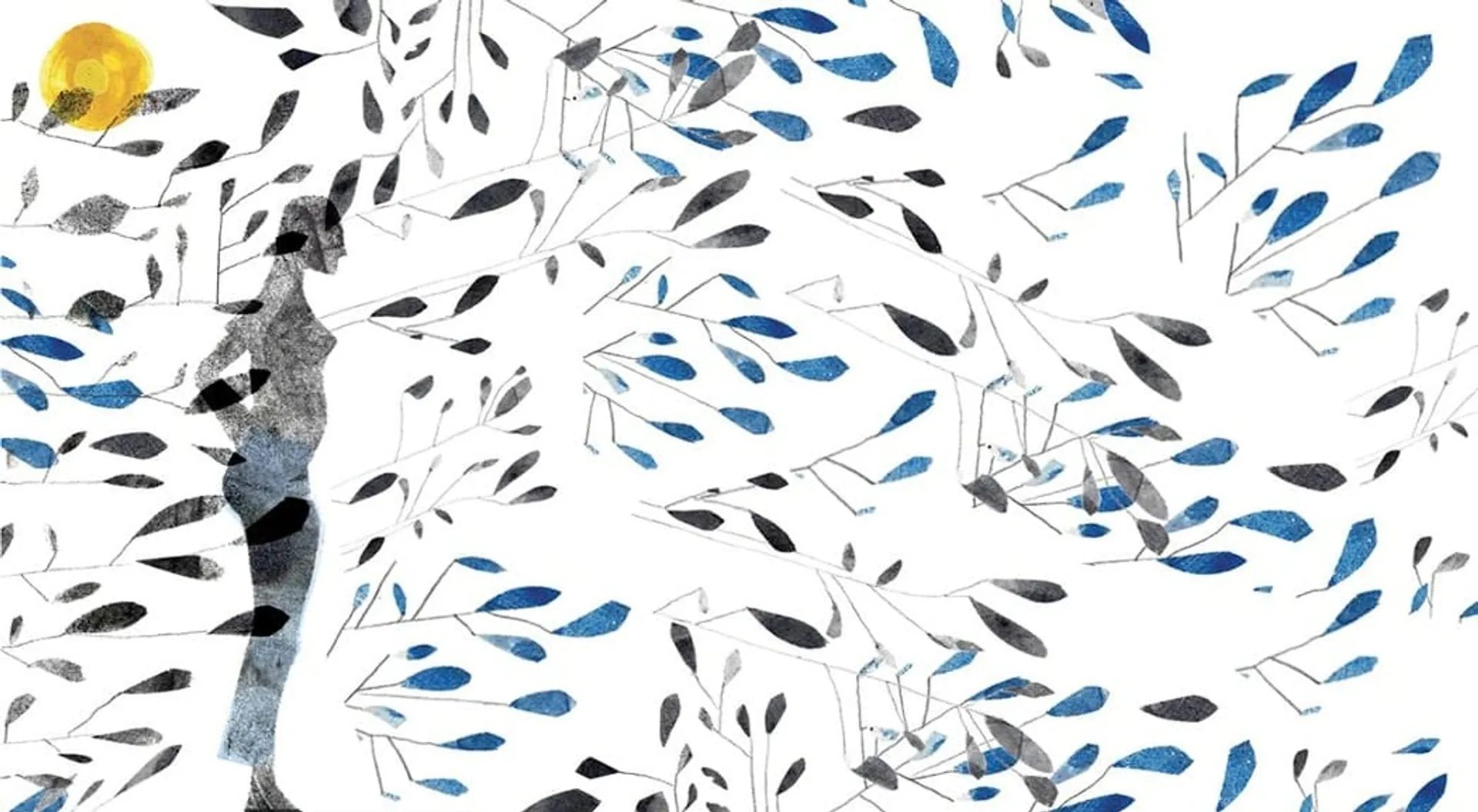Un altro giorno da sopravvissuta, esco di rado, il Covid non si accorgerà di me, come in quest’anno. Non posso insegnare, mi sento un po’ inutile, ma come lamentarmi se lo Stato mi sta proteggendo? Non ci penso, non voglio pensarci ma sono un soggetto fragile. Da quattro anni si è aggiunto un ospite non gradito in casa, il cancro; nessuno direbbe che sono malata tra chi non mi conosceva: non mi lamento, sorrido e scherzo, svolgo (svolgevi, Lara) il mio lavoro con entusiasmo, alle visite di controllo mi presento puntuale, è tutto come prima.
Niente è come prima: sempre meglio rispetto a quando non mi potevo muovere, impossibilitata a lavarmi per otto mesi (ho tagliato i capelli appena sono potuta uscire senza sobbalzare a ogni minimo movimento della macchina: li porto corti adesso, mi è dispiaciuto vedere lunghe ciocche sul pavimento, ma dicono che siano più indicati dopo i quaranta), mettermi a letto e rialzarmi erano torture, non potevo occuparmi delle pulizie di casa, nonostante mi fosse stato raccomandato di vivere in un ambiente senza un soffio di polvere, ma come, se non potevo tenere nulla in mano, come? Non si invita nessuno, si chiede scusa, ma l’impotenza ti assale: disordine, le camicie che non puoi più stirare, casa tua diventata invivibile.
Lo sapevo, dite? Be’, no, nessuno mi aveva detto che un intervento che toglie buona parte di un polmone e quattro costole mi avrebbe ridotta a una mancanza di autonomia quasi totale, a non essere più riconoscibile, a fuggire dagli specchi. Fine aprile: avevo male alla schiena da mesi, prendevo antidolorifici come fossero mentine, non ne ho potuto più e sono andata al Pronto Soccorso certa di dover prenotare una visita da un ortopedico: la dottoressa era impallidita, guardando la radiografia, non ci feci caso; ma insistevo per tornare subito al lavoro, non volevo ricoverarmi assolutamente, così fu brutale: «Signora, o è una brutta polmonite, e io glielo auguro, o è cancro. Lei “si deve” ricoverare», e lo ripeté davanti a mio figlio; furono le sue lacrime a convincermi. Rimasi una settimana lì, un ospedale in un paese vicino Bergamo: incontravo una persona, due chiacchiere, e il giorno dopo il suo letto ospitava un altro paziente. Uscii senza sapere che avessi, nessuno me lo disse, soltanto finalmente non sentivo più dolore: mi davano farmaci che mi stordivano, ma il dolore era scomparso. Me ne lasciarono una confezione, assieme ad altre medicine, e le dosi, ma non c’era una diagnosi: mi spiegarono che, senza una certezza, non potevano affermare nulla.
Capivo; avrei preferito mi si dicesse qualcosa ufficiosamente, ma se non si poteva. Avrei incontrato presto una chirurga, finalmente avrei saputo quando sarei tornata a scuola, a questo pensavo: tornare dai miei ragazzi. A casa, intanto, guardai quelle confezioni: il prezzo era sbalorditivo, quasi novanta euro per un farmaco che avrei dovuto assumere due volte al giorno, ed era soltanto uno dei molti prescritti. E io non avevo alcuna esenzione, poiché non c’era diagnosi: la prima volta il costo si aggirò sui duecentocinquanta euro, non tenendo conto di altre spese legate alla degenza, e intanto lessi sul bugiardino (ironico chiamarlo così, nevvero?) che erano farmaci prescritti per la cura del tumore. Non era polmonite? Come parlare a mio figlio di quest’eventualità? Mai gli ho mentito in vita mia, per una settimana lo feci; poi, arrivò il giorno dell’appuntamento con la chirurga e dovetti prepararlo. Con dolcezza, insistendo sull’alto tasso di guarigioni, e fortuna che parlai.
La chirurga mi piacque subito, continua a essere il mio faro: pragmatica, di poche parole, sempre disponibile. Ma non sapeva quello che avevo chiesto a tutti i medici e perfino alla psicologa con cui in ospedale mi fecero parlare (con la suora no, mi rifiutai, che c’entrava una suora con la malattia? Sì, forse avrei dovuto capire da questi dettagli, ma mi avevano detto che mi avevano ricoverata in oncologia perché non c’era disponibilità da nessun’altra parte e dai medici volevo chiarezza): di parlare prima con me, poi io avrei spiegato a mio figlio fu sempre questa la mia unica richiesta. Esordì così: «Voi sapete qual è la situazione, vero?», la guardammo confusi e dicemmo «No», la verità; la risposta fu: «Ah, tocca a me darvi la brutta notizia», ribattei prontamente: «Be’, ce l’ha già data». Così sapemmo finalmente, insieme. Ci spiegò che bisognava intervenire subito, una biopsia avrebbe rallentato i tempi, era certamente cancro.
Mio figlio chiese particolari sull’intervento cacciando indietro le lacrime, era diventato un uomo in dieci giorni, io domandai se sarei potuta rientrare a scuola dopo qualche giorno e se il dolore sarebbe continuato: sorrise e rispose che le cure sarebbero state un po’ più lunghe, un mese, forse due, e che, se l’intervento fosse riuscito, non avrei sofferto mai più per quei dolori. Sollevata, acconsentii a non effettuare la biopsia, mi fidavo di lei, mi fido, a ragione, di chi ha studiato ed è competente; chiesi di poter attendere due giorni per partecipare al concorso per docenti e, dopo molte pressioni, mi diede il consenso (non lo superai ovviamente, mi presentai rintontita dai farmaci e neanche avrei potuto documentarlo: ufficialmente, ero sana).
L’intervento durò a lungo, mi riferì mio figlio, che rimase tutta la giornata lì, roso dall’angoscia; infine, dissero che era perfettamente riuscito, ricordo la loro soddisfazione, si congratulavano tra di loro, mi diedero serenità. Dal giorno successivo, però, compresi che qualcosa non quadrava: suonavo ripetutamente il campanello perché i dolori erano atroci; non riuscivo a muovermi dal letto, solo con sforzi enormi mi fecero sedere su una poltrona, ma ero immobile, parlavo a fatica. Con il tempo tutto si aggiusterà, mi ripetevano. E io mi affidavo a loro, nulla sapevo di cancro, non avevo intenzione di trasformarmi in una maniaca di Wikipedia: è il medico che deve informarmi, che deve spiegare, e in modo chiaro.
Non mi fu mai detto che il braccio destro non sarebbe tornato ad alzarsi come prima, non mi fu nemmeno prescritta almeno qualche seduta di fisioterapia: gli esercizi per recuperare l’uso della mano sono stati decisi da me e se posso guidare e alzare, anche se non del tutto il braccio, il merito non è di alcun medico né fisioterapista: convivo con un dolore costante, costretta a cercare di equilibrare la mia lucidità al volante e in classe con il mal di schiena lancinante: l’uso del Fentanil, oppioideo per la fase acuta, ci obbliga a ricorrere al medico di base quasi quotidianamente, poiché la confezione contiene quattro compresse, bastanti per un giorno (da prendersi a distanza di almeno cinque ore l’una dall’altra: prendo un foglio e appunto gli orari, memore della volta in cui ancora non lo sapevo e finii preda di allucinazioni: volti deformati erano pronti ad aggredirmi, confondevo la realtà con incubi, parlavo e mi accorgevo solo dopo che avevo detto parole insensate, mi sembrava di precipitare da un palazzo altissimo e il cuore ogni volta aveva un sussulto che sapeva di morte, l’orrore di non poter controllare più il tuo cervello), non posso allontanarmi troppo da casa, programmo perfino quando andare a fare la spesa, e gli altri non capiscono, si offendono ma non puoi ogni volta ripetere tutte le tue difficoltà, ti scusi e cerchi un nuovo pretesto; no, non mi era stato detto che sarei saltata in aria ogni volta che qualcuno mi avesse abbracciato o sfiorato la schiena: aspetto da mesi di sapere se potrò effettuare l’intervento che chiuderebbe quelle terminazioni nervose, a quanto ho capito, l’unica soluzione definitiva: so di non essere l’unica paziente, ma vivo da drogata, scusate, io che non ho mai avuto una dipendenza che fosse una; no, non sapevo che si sarebbero aggiunti problemi motori e che con difficoltà salgo le scale e mi stanco a percorrere anche solo poche centinaia di metri (prendo appuntamenti che, se non fosse per la richiesta di urgenza pietosamente aggiunta da qualche medico che mi vede peregrinare da anni, con il servizio sanitario nazionale sarebbero fissati almeno l’anno dopo: se vuoi una visita in tempi decenti, paga, e sarebbe uguale in ogni altra città d’Italia) e fatalmente ho rinunciato;
e no, non sapevo che la radioterapia mi avrebbe fatto cadere, a uno a uno, i denti: l’ho scoperto quando sono andata per la pulizia e mi sono sentita dire: «Ma che senso ha se, entro massimo un anno, le cadranno tutti?», sbigottita chiedevo spiegazioni e mi veniva presentata una lastra, evidenziati due-tre impavidi che non volevano desistere, ma che nel piano ideale sloggeranno: ci sarebbe da fare prima una bonifica (=li togliamo noi tutti prima che, distratta come sei, li perdi), mettiamo una dentiera temporanea, aspettiamo qualche mese e abbiamo pronti i tuoi bianchissimi nuovi denti, per una cifra che “inizialmente” si aggira sui ventimila euro, metà in contanti, gli altri a rate, eh, no, nessuno mi aveva prospettato un mutuo per i denti, io che non sopporto debiti, così ringrazio di dover indossare la mascherina e continuo a raccogliere e buttare pezzi di me, già scuri, che mi lasciano, a volte educatamente nel piatto; e no, non ci era stato detto che l’opera di totale devozione di mio figlio, anni persi a non poter lavorare per accompagnarmi ovunque, sarebbe stata considerata un hobby, non ricevendo nessun tipo di sussidio (e le spese per le medicine le sostengo io: tutte le malattie legate alle mie condizioni, quali il raffreddore, è solo uno degli esempi, almeno una volta al mese, le curo con farmaci pagati da me, eliminando quelli non indispensabili, ma quali sono, chi lo stabilisce? ) perché con lo stipendio da docente che ho, lo sapete, decine di migliaia di euro, non ne abbiamo diritto, si mangia pane e dignità, più spesso solo dignità, ché la mia professione impedisce di affiancare altri lavori se non in nero, restano i libri che ho scritto stando a casa quest’anno, che, se usciranno postumi, magari i critici saranno meno impietosi (confessatelo, vi state chiedendo come faccia a campare, e la risposta è che non lo so neanch’io);
e neanche mi era stato detto che avrei perso più di venti chili, sarebbe arrivata la menopausa d’un tratto, una scapola sarebbe sporta dal lavoro di ricostruzione e sarei caduta e ricaduta, senza sentire dolore, a causa dell’equilibrio precario, con un dimagrimento di questa portata, e intanto spuntava un aneurisma al cervello, operato e lasciato a sé, che mi può causare danni cerebrali fino alla morte, ma non sono mai stata visitata dopo l’intervento; non mi avevano detto che avrei dovuto mostrarla la mia fragilità per pagare affitto e bollette, chiedere aiuto, per scoprire che chi ti aiuta, poi vuole il dettaglio di come hai speso ogni centesimo, e non ti crede neanche allora, pensa che vuoi approfittare, magari per la piscina della tua villa, e allora rinunci: non chiedi più niente a chi dice di conoscerti, meglio il silenzio che l’ennesimo sputo in faccia, ché la miseria è vergognosa se è morale; e, infine, no, non mi era stato detto che avrei dovuto chiedere almeno un sostegno psicologico, ché neanche questo mi è stato dato né ricevo tuttora, perché può prenderti a un certo punto la disperazione, in attesa del prossimo controllo tra qualche giorno e con l’ansia che quei noduli maledetti abbiano smesso d’ingrandirsi, o la stanchezza o il chiedersi il senso dello svegliarsi ogni giorno per prendere farmaci; può accadere che la più forte delle persone dica ora basta, lasci un biglietto di scuse, le uniche vere, a una persona (la sola che c’è sempre stata, che sa che sei malata anche se taci, non ha bisogno di esibizioni, non si stanca perché sono trascorsi quattro anni, ché amore è questo, il resto è farsa vergognosa) e tolga il disturbo (a sé, principalmente), ché tanto il testamento è stata la prima cosa che ha fatto. E anche questo senza che nessuno glielo dicesse.