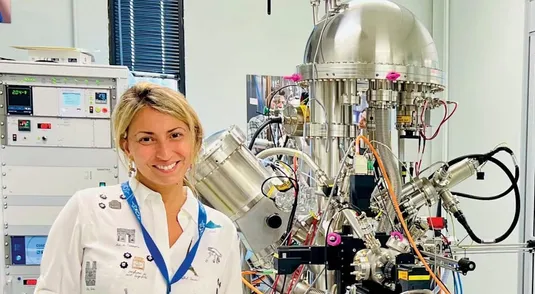Il sito di orientamento progressista Salon, spesso critico con le promesse della Valley, si è spinto oltre: «Se ne studiate i percorsi», scrive, «si vede chiaramente che gli shuttle sono pensati per trasportare chi abita nelle zone più ricche della città verso il SoMa e il distretto finanziario, dove si concentra il grosso delle attività professionali». Insomma, non solo è un bus privato, in concorrenza col servizio pubblico: è anche un modo «per evitare di viaggiare accanto ai poveri».
Casi come quello di “Lyft Shuttle” rinchiudono tutta l’ipocrisia del marketing della Valley, e delle sue parole d’ordine: efficienza, risparmio - se non gratuità - e interesse esclusivo dell’utente. Un catalogo che, a ben vedere, cela spesso l’opposto. Ma che seduce, e spesso inganna, con la sua promessa di trasformare l’esistente in una sorta di luna park tecnologico, dove a lavorare sono sempre più algoritmi e intelligenze artificiali, finché noi umani potremo finalmente - in una perversa riedizione di un sogno socialista - dedicarci a ciò che ci attende nell’era della fine del lavoro.
Per esempio, a ottimizzare le nostre abitudini e la nostra salute, grazie alla pletora infinita di device e oggetti connessi prodotti, guarda caso, sempre in Silicon Valley. A partire dalle funzioni corporee di base, che dopo millenni di esistenza umana sembrano improvvisamente necessitare di supporti tecnologici per perpetuarsi. Bere, per esempio.
Come ricordarsene senza Hydrate Spank, la bottiglia “intelligente” che per soli 47 dollari «traccia il vostro consumo d’acqua e brilla per assicurarvi che non dimenticherete più di berne»? O mangiare, che secondo la startup da oltre 75 milioni di dollari Soylent «non è facile», e necessita dunque di una polvere o barretta che riassuma in un unico - a detta di chi l’ha provato, insapore - composto l’intero apporto di sostanze nutritizie di cui ha bisogno il corpo umano.
Poco importa che diversi esperti dubitino dell’evidenza scientifica dell’affermazione, o che alcuni consumatori abbiano prodotto getti di vomito dopo averne ingerito la versione “1.6” - sì, il cibo ha gli “aggiornamenti”, come il software - quando il marketing ricorda che l’obiettivo è «estendere l’accesso a nutrizione di qualità attraverso l’innovazione del cibo», fornendo peraltro anche un milione di pasti a bisognosi negli Stati Uniti e nel mondo. Ma non può bastare.
Per la startup MySmalt «questa è l’era in cui quando ci svegliamo la nostra caffettiera si accende da sola» o, meglio ancora, «sa che qualità di caffè vogliamo ogni giorno della settimana». E allora, nella “cucina smart”, perché non trasformare la solita, vecchia saliera in «una esperienza divertente» - ovvero, in un oggetto anch’esso capace, proprio come un telefonino o un pc, di «monitorare, tracciare e controllare» ciò che facciamo? Perché non sfruttarla per impreziosire una cena tra amici, definita nel sito aziendale una «tonificante bizzarria» per spezzare il consueto flusso di tweet e messaggi di gruppo? Nel caso poi ci fosse qualcosa di unico e segreto da dire proprio a un’altra persona, si potrebbe usare “Toasteroid”, il tostapane connesso che ha raccolto quasi 190 mila dollari dal pubblico in rete e che, consentendo di scaldare la superficie del pane con brevi messaggi scritti via app e condivisibili con chiunque possegga il device, avrebbe «reinventato il modo in cui relazionarsi con la famiglia e gli amici».

Proprio come nel nuovo motto di Facebook, o nella filosofia aziendale di Airbnb, si tratta di «avvicinare» il mondo: e se un promemoria sul meteo o pagare le bollette sul pane tostato è sufficiente, beh, perché non approfittarne subito. In fondo Silicon Valley ci vuole bene, e dunque ha un gadget per correggere ogni nostro “bug”. Mangiamo troppo in fretta? Per soli 65 dollari la forchetta intelligente HapiFork comincerà a vibrare per ricordarcelo, ogni volta che ci faremo travolgere dall’appetito. Stiamo troppo seduti? Ecco la cintura “smart” BeltyGoodVibes della francese Emiota attivarsi per segnalarcelo.
Difficile trovare, tra le mirabolanti vision dei nuovi piazzisti dell’iperconnesso, analisi delle conseguenze di un simile mondo, in cui ogni nostro singolo gesto diventa tracciabile, archiviabile e sfruttabile per costruire offerte pubblicitarie personalizzate, o giudizi da dare in pasto agli algoritmi che sempre più regolano affidabilità creditizia, tassi assicurativi, adeguatezza a un posto di lavoro.
Perché curarsene, del resto, quando strumenti come Furbo consentono di tenere d’occhio il proprio cane comodamente dall’ufficio, e ordinare al device perfino di dargli un biscotto — “per dimostrargli che lo avete a cuore” — quando si annoia? I rischi, tuttavia, vanno ben oltre il semplice affezionarsi del quadrupede alla macchina più che al padrone.
I colossi del digitale si sono impadroniti della lingua degli affetti. Si pensi a Facebook, che per contestare l’idea di essere un luogo di odio e abusi verbali si è messo a ringraziare ogni singolo utente metta un cuore a un post altrui con un messaggio che sembra uscire dritto dritto da una distopia novecentesca: “Grazie di aver condiviso un po’ di amore oggi. Ogni volta che aggiungi una reazione Love, rendi la nostra comunità più accogliente”.
O ad Airbnb, che quando nel 2014 ha cambiato logo, coniando l’attuale “Belò”, si è spinta a sostenere di avere inventato niente meno che “il simbolo universale dell’appartenenza”. Perché così si dipinge il gigante che, a suon di cartelloni di propaganda e lobbying stimato in 115 dollari a voto, è riuscito a far bocciare una norma che ne avrebbe limitato l’utilizzo a San Francisco: un sinonimo insieme di «persone, luoghi, amore», scriveva il Ceo Brian Chesky.
E che dire di Google, partita dal celebre “Do no evil” e giunta all’attuale “Fai la cosa giusta”? Torna alla mente il teorico dei media Neil Postman, quando nell’introduzione al suo capolavoro del 1985, intitolato non a caso “Amusing ourselves to death” parlando degli incubi sociali di George Orwell e Aldous Huxley scriveva: «Orwell temeva che a rovinarci sarebbe stato ciò che odiamo, Huxley ciò che amiamo». E tutti gli indici di soddisfazione mostrano che sì, i servizi della sharing economy e dei colossi web piacciono.
Il punto è: quanto ne cogliamo le implicazioni? Quanti riescono a scorgere, dietro l’intento di Google di «organizzare tutta l’informazione del mondo» in modo gratuito e oggettivo, il fatto che l’azienda tenti di influenzare l’opinione pubblica finanziando - come rivelato recentemente dal Wall Street Journal - ricercatori che promuovono idee congruenti con la sua visione del mondo? Ed è davvero “fare la cosa giusta” lasciare che questi ultimi dimentichino di menzionare la fonte di finanziamento, una volta prodotta la ricerca? Perfino la Commissione Europea ha impiegato anni per sanzionare il suo uso illecito dei servizi di comparazione degli acquisti. Davvero serviva quella multa per suggerire all’azienda che, forse, era lei stessa a violare i propri valori?

L’ipocrisia nei codici di comportamento e nelle mission aziendali non nasce certo con il digitale, ma oggi - nell’era del dominio huxleiano - sembra più difficile che mai da scorgere. Mark Zuckerberg che promuove il reddito universale di base - nella sua versione libertaria, cioè per rimpiazzare più che integrare lo stato sociale - e insieme sfrutta ogni scappatoia fiscale per eludere il fisco.
Uber che proclama sul suo sito di fornire una esperienza «gratificante, poiché permette agli autisti di raggiungere i propri obiettivi professionali e finanziari» e insieme prevede di rimpiazzarli con vetture che si autoguidano perché, come dice l’ormai ex Ceo, Travis Kalanick, il servizio costa «perché non stai pagando solo la vettura ma anche l’altro tizio nella vettura. Quando lui scompare, il costo di prendere un Uber diventa più economico di possedere un veicolo». Elon Musk che progetta di portare l’uomo su Marte nel 2023, e insieme dimentica che così facendo inquinerebbe irrimediabilmente le opportunità della scienza di studiare possibili forme di vita sul pianeta.
Mentre la Silicon Valley ci culla con la promessa di ogni sorta di meraviglia, spingendosi fino al proposito di curare tutte le malattie del mondo e perfino sconfiggere la morte, ciò che otteniamo sono monopolisti di dati che ammassano ricchezze e producono disuguaglianze senza precedenti. E, insieme, l’idea che sia normale avere in casa un device che ci ascolta, come Alexa di Amazon o Home di Google, così che ogni conversazione possa diventare all’occorrenza prova processuale a nostro carico - è già accaduto per le indagini su un omicidio in Arkansas - e che ogni più selvaggia fantasia di marketing diventi realtà.
Un esempio? La pubblicità televisiva di Burger King in cui l’attore pronuncia di proposito una frase che attiva le funzioni di riconoscimento vocale dei device Google, costringendoli a proporre all’ignaro telespettatore la pagina Wikipedia del panino, peraltro precedentemente ritoccata all’occorrenza.
C’è insomma un altro modo di sfogliare il dépliant della Valley, più cinico ma forse realistico: una schiera di lavoratori uberizzati, privati di diritti e stato sociale, sempre monitorati ma completamente assorbiti da notifiche, pubblicità personalizzate e buoni sentimenti. Sì, Aldous Huxley ne sarebbe fiero.