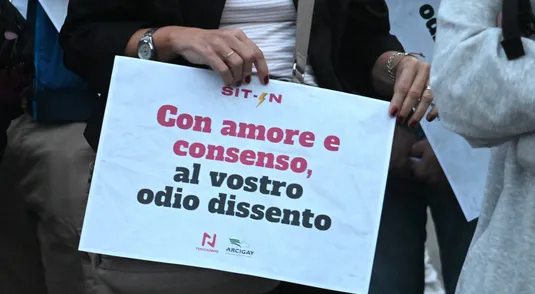Un dolore presente ovunque. E così, come allora, la montagna restituisce la protesta. Contro le autorità che non hanno dichiarato la zona rossa. Contro le decisioni della Protezione civile nazionale che hanno fatto perdere tempo, lasciando sguarnita di mascherine la prima linea di medici, infermieri, ospedali e case di riposo. Contro i politici del partito trasversale Lega-Pd: quelli che all’inizio della catastrofe invitavano i cittadini a uscire come sempre, in nome dell’economia e dell’industria. Quando si svuoteranno le terapie intensive, toccherà al ministero della Giustizia rinforzare i propri uffici: perché gli esposti che arriveranno da tutta la Lombardia saranno probabilmente migliaia.
Fino a oggi non c’era tempo per pensare. Chi ha già seppellito i suoi cari, però, ora si guarda intorno e si chiede il perché dell’ecatombe. Allora toccò a una giornalista veneta e coraggiosa, Tina Merlin, raccontare sull’Unità l’altra versione del Vajoint. Oggi la testimonianza è collettiva e parte su Facebook dalla pagina pubblica “Noi denunceremo”. Davanti a un’Italia obbligata a stare in casa, Luca Fusco, 59 anni, uno dei tanti bergamaschi che stanno vivendo nel lutto, ha aperto una piazza digitale dove raccontare, segnalare, ricordare i propri cari: «Questo gruppo», spiega Fusco, «nasce per un bisogno di giustizia e di verità, per dare pace ai nostri morti che non hanno potuto avere nemmeno una degna sepoltura. Quando tutto sarà finito, chi ha sbagliato e girato la testa dall’altra parte dovrà pagare. Denunceremo e chiederemo giustizia. In memoria di mio padre e di tutti quelli che, insieme a lui, sono morti (e moriranno)». Ventimila iscritti in pochi giorni. E una regola: non si fa propaganda, soprattutto quella banale dei videoselfie politici che, puntualmente, vengono cancellati. Anche lo slogan che inizialmente apriva la pagina, “dovranno pagare”, è stato poi tolto. Così lo spazio rimasto bianco potrebbe contenere le parole che Tina Merlin ha dedicato alla gente del Vajont: «Oggi tuttavia non si può soltanto piangere, è tempo di imparare qualcosa».
Ecco, Matteo Renzi potrebbe fare un giro qui e vedere cosa accadrebbe se questo virus Sars-Cov-19 venisse lasciato correre per l’Italia con la sua proposta di riaprire prima del tempo fabbriche, scuole e la vita di sempre.
Perché qui, tra Bergamo, Nembro, Albino e tutt’intorno il coronavirus ha avuto davvero la libertà di correre. E per questo continua a uccidere: ora è dentro le case di riposo e nei paesi delle valli fin giù nelle campagne della pianura, dove la conta della strage ogni giorno aggiunge numeri. Davanti a 1969 morti al mese e chissà quanti altri ancora sfuggiti alla versione ufficiale, come potrebbe funzionare l’economia fingendo che non sia successo nulla?
Lo stesso killer silenzioso lascia tracce del passaggio anche verso Brescia e le sue montagne. «Qualche timido segnale di minor pressione sul pronto soccorso lo vediamo», racconta un medico che lavora nell’epicentro bresciano degli Spedali Civili, «ma l’impressione è che l’infezione sia diffusa sul territorio. E lì penso che durerà ancora molto».
Torniamo così alla prima questione: stare chiusi in casa è l’unico rimedio, ma quando si è costretti a uscire per la spesa e altre necessità urgenti, come si può garantire la protezione propria e altrui senza quel banalissimo ma fondamentale accessorio dell’abbigliamento antivirus che è la mascherina? La Svizzera si è preparata al peggio con una scorta nazionale di diciassette milioni di pezzi. La Francia, alle prese con la stessa penuria italiana, ha annunciato l’importazione di un miliardo di maschere protettive dalla Cina. Da noi, nel mese di vantaggio che avevamo, dalla delibera del premier Giuseppe Conte che dichiarava lo stato di emergenza il 31 gennaio, non si è ancora capito cosa sia successo. Scoppiato il focolaio di Codogno, la Regione Lombardia è intervenuta tempestivamente. Ma poi in provincia di Bergamo ha lasciato le porte aperte all’infezione. Mentre a inizio epidemia il dipartimento nazionale della Protezione civile firmava provvedimenti che hanno fatto perdere giorni e contatti preziosi: come la scelta, scoperta e raccontata dal sito dell’Espresso la settimana scorsa, di incaricare per il pagamento dei fornitori all’estero una società a responsabilità limitata specializzata nell’importazione di gadget, come tapiri in plastica, statuine di Batman, ombrelli e cavatappi. Una decisione voluta dall’Ufficio VI-Amministrazione e bilancio. Così il rapporto privilegiato che lo Stato italiano stava avviando direttamente con importanti produttori cinesi si è interrotto. Provate a ribaltare le posizioni: voi vi fidereste di una sconosciuta srl cinese?
Il premier Conte ha poi chiamato Domenico Arcuri, il secondo commissario dopo Angelo Borrelli. E il caos è scoppiato nelle dogane. Prima il blocco anti speculatori e il sequestro di tutte le forniture sanitarie perché fossero affidate alla Protezione civile. Poi il via libera parziale di quanto è destinato a ospedali e aziende. Così perfino le grosse donazioni della comunità cinese in Italia vengono requisite. E all’estero nessuno ci fa più credito: grazie al rischio della confisca della merce, ora si importa solo con pagamento anticipato. La Guardia di finanza non potrebbe colpire gli speculatori partendo dalla loro rete di vendita? Molti comandi, dopo la chiusura di aziende e negozi, hanno invece messo il personale in ferie.
Il risultato lo si vede lungo la prima linea: decine di medici morti, novemila colleghi e infermieri contagiati. Anche la strage di nonni nei reparti e nelle case di riposo sarebbe stata favorita dalla mancanza di protezioni per il personale sanitario. E a volte dalle loro scelte. Come ad Alzano Lombardo, proprio in bassa Val Seriana, dove l’ospedale è stato chiuso e riaperto in poche ore, mentre a Codogno scattava la zona rossa: «Nessuno ci ha avvertito che nei reparti c’erano pazienti positivi», racconta alle cronache locali Francesco Zambonelli, 55 anni, di Villa Serio, che in pochi giorni ha perso il padre, la madre e una zia. Decine di persone rivelano storie identiche.
Solo la reiterata minaccia della Regione Lombardia di licenziare chiunque parli, mantiene il tappo sulla protesta che monta tra medici e infermieri. Il sindacato Nursind sta ricevendo decine di segnalazioni. Questo è quanto accade in uno dei più importanti ospedali di Milano: agli infermieri viene chiesto di riutilizzare camici e protezioni monouso, il loro impiego è comunque prolungato a dodici ore quando i filtri sono garantiti per otto, i pazienti non-Covid non vengono riforniti nemmeno di mascherina chirurgica, per non spogliarsi e dover sostituire la tuta il personale delle aree infettive rinuncia ai pasti e ai bisogni fisiologici per tutte le dodici ore del turno.
«Da noi», dice un’infermiera di un altro grande ospedale milanese, «anche se hai i sintomi dell’infezione, puoi lasciare il reparto solo se la febbre sale sopra i 37,6. E il tampone comunque non ce lo fanno, lo eseguono solo al rientro dalla malattia. Con il rischio di infettare tutta la famiglia. Alla nostra richiesta di avere a disposizione le corrette protezioni previste, la risposta dell’azienda è stata pressoché negativa. Il risultato è che in psichiatria, dove secondo la direzione non esisteva alcun rischio, a oggi si contano dieci pazienti positivi su diciotto e dieci infermieri contagiati: di loro, quattro sono stati ricoverati. Siamo professionisti laureati, che prestano il proprio servizio al bene della comunità. Non dobbiamo essere per forza eroi».