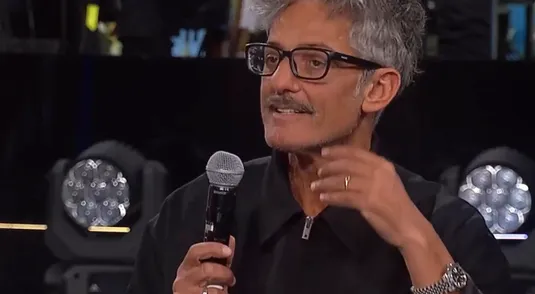Di queste domande vorrei dar conto parlando di Bella ciao e della sua diffusione planetaria come inno popolare per le lotte sociali (Carlo Pestelli “Bella ciao, la canzone della libertà”, 2016). Perché poi le risposte più interessanti credo di averle trovate proprio in certi paradossi apparenti che accompagnano l’origine controversa e la storia di questo canto.
Una premessa però. Non è stata una multinazionale dell’intrattenimento come Netflix con il lancio della serie spagnola “La casa di Carta” (2017) e i suoi banditi trasformati in rivoluzionari sulle note di “Bella ciao” a farla cantare lì dove c’era un diritto da difendere, un’oppressione da combattere, un sopruso contro cui lottare e resistere.
Perché, se oggi la cantano a squarciagola ragazzi ignari o diventa tifo da stadio come ai Mondiali di Russia 2018, è anche vero che, prima ancora che tornassero a intonarla in un contesto nazionale gli operai della Whirlpool di Napoli o migliaia di manifestanti all’aeroporto di Barcellona dopo le condanne dei leader catalani indipendentisti, “Bella ciao” è stato uno dei canti che nel ’69 costò la censura al cantautore Adolfo Celdrán nella Spagna franchista. È stato uno dei canti di resistenza più intonati dai giovani del Leftist Jordanian Movement, nipoti di quei nonni palestinesi rifugiatisi in Giordania nel ’48 e nel ’67. È stata una delle canzoni più conosciute e tradotte dai giovani mediorientali di sinistra nelle rivolte arabe del 2011, e ancora oggi, proprio qualche giorno fa in Libano, la tv Al-Manar (Il Faro) di Hezbollah (Partito di Dio libanese a favore del governo in cui ricopre tre ministeri) - durante un collegamento - si è trovata nell’imbarazzo di trasmetterla perché intonata dai manifestanti in piazza contro la corruzione della classe dirigente e il carovita.
L’hanno cantata nel 2013 i giovani del Parco di Gezi a Istanbul contro l’abbattimento di centinaia di alberi per costruire un centro commerciale, inaugurando una mobilitazione in difesa dei diritti civili dilagata in tutto il Paese e repressa ferocemente da Erdogan. Lo stesso anno dell’esecuzione gitana dirompente di Bregovic a Parigi, incubo di ogni sovranismo. È stata cantata ai funerali di Tignous trucidato nell’assalto a “Chalie Hebdo” del 2015 (stesso anno dell’Accordo di Parigi sul clima e dell’enciclica Laudato si’) e, sempre in Francia, nel 2016 l’ha eseguita l’orchestra Debout in omaggio ai manifestanti contro la riforma del mercato del lavoro di Hollande.
Oggi, non diversamente da ieri ma con un senso amaro di tradimento, la cantano alcune formazioni della quarta etnia più grande del Medio Oriente: i curdi turchi, iracheni, siriani, che con le sigle Pkk (Partito dei Lavoratori del Kurdistan di Turchia e Iraq), Ypj (Unità di protezione delle donne del Rojava siriano) e Ypg (Unità di protezione del popolo) hanno combattuto l’Isis, lo spettro del più feroce fondamentalismo jihadista, a fianco della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti. Bella ciao continuano a intonare, evocando quei partisan italiani delle montagne cui traggono ispirazione da popolo che «ha un solo amico, le montagne», appunto. E vorrebbe che la propria resistenza fosse riconosciuta in una Storia più grande, come lotta anche per la difesa di una concezione democratica radicalmente egualitaria: la democrazia del Rojava siriano (sotto attacco turco) dove uguaglianza di genere, economia sostenibile, rispetto dell’ambiente, pluralismo sono facce della stessa medaglia. Né sarà un caso che in questi giorni in Rojava, mentre in Cile torna a imperversare una violenza inaudita e anche a Santiago si canta “Bella ciao”, è apparso un cartello che recita: «Dal Rojava al Chile: El Pueblo Unido Jamas sera Vencido». Come a dire quanto sia cieco dividere lotte e rivendicazioni di diritti, e dividerli da un capo all’altro del mondo.
Ma torniamo all’origine incerta di “Bella ciao”, a tutto quel che può contenere una canzone semplice orecchiabile sentimentale, declinata in mille versioni o contesti, e oggetto delle più svariate appropriazioni.
Canto di trovatori provenzali, di mondine italiane, canzone popolare del nord Italia d’amori abbandonati, canto di protesta, melodia Klezmer-Yddish molto simile a un 78 giri del 1919 del musicista zigano Mishka Ziganoff, canto della nostra Resistenza… nonostante non vi siano indizi della sua rilevanza tra le brigate partigiane. Nessuna traccia nei documenti dell’immediato dopoguerra né in vari canzonieri. Non c’è, ad esempio, nel “Canzoniere Italiano” di Pasolini e nemmeno nei “Canti Politici” di Editori Riuniti del ’62. C’è piuttosto evidenza di una sua consacrazione popolare e pop tra il ’63 e il ’64, con la versione di Yves Montand e il festival di Spoleto, quando il Nuovo Canzoniere Italiano la presentò al Festival dei Due Mondi sia come canto delle mondine sia come inno partigiano. Una canzone duttile, dunque, e talmente “inclusiva” da poter tenere insieme le varie anime politiche della lotta di liberazione nazionale (cattoliche, comuniste, socialiste, liberali...) ed esser cantata sia a conclusione del congresso DC che elesse come segretario l’ex partigiano Zaccagnini sia durante i funerali di Giorgio Bocca, che, da partigiano, diceva di non averla mai sentita intonare.
Una canzone per la quale si è dovuta edificare una tradizione, un immaginario, facendola diventare simbolo della Resistenza (Bermani, “La vera storia di Bella ciao”) e molto di più: lotta patriottica di liberazione dall’invasore; lotta civile contro una dittatura; lotta per l’emancipazione sociale. Un mito insomma che, come tutti i miti, può contenere un universo più vasto di significati rispetto a quelli per cui è stato tramandato. E può vivere molte vite nuove.
E una delle nuove vite ha proprio a che vedere con l’imperativo per uno sviluppo sostenibile rivendicato dai giovani dei Fridays for Future che trae diretta ispirazione dal “Bella ciao” intonato da centinaia di ragazzini belgi nel 2012: «Dobbiamo svegliarci, dobbiamo aprire gli occhi, dobbiamo farlo ora. Dobbiamo costruire un futuro migliore». Non un inno solo per l’ambiente, dunque, ma per un cambiamento all’altezza dei tempi, che è una scelta di campo.

Se le istituzioni politiche sono incapaci di affrontare questa crisi, la ragione sta nel fatto che «il pilastro di queste strutture è lo stato-nazione che per propria natura è tenuto a tutelare gli interessi di un unico gruppo di persone», spiega Amitav Gosh ne “La grande cecità”.
Che la questione ambientalista sia questione politica contro ogni nazionalismo, nazifascismo, fondamentalismo jihadista, suprematismo, sovranismo così come contro ogni forma di economia rapace indifferente al «debito ecologico soprattutto tra il Nord e il Sud» è evidente nella chiarezza di queste parole dell’enciclica papale che, come nota Gosh, deve anche la sua forza alla schiettezza pragmatica dello stile contro i tecnicismi fideistici dell’Accordo di Parigi. E in quell’enciclica si dice che è impossibile separare «conversione ecologica», «giustizia sociale», squilibrio economico, deterioramento di ambiente e società, e migrazioni anche, visto che «a sostenere l’onere del cambiamento climatico saranno i poveri e gli indifesi», quell’umanità in fuga che fa tanta paura all’Occidente.
«Lassù, per la prima volta in vita nostra, ci siamo sentiti veramente liberi e quel paesaggio si è associato per sempre con la nostra idea di libertà», scrive Luigi Meneghello in un passaggio de “I piccoli maestri”, evocando l’altopiano di Asiago dove gli studenti vicentini si spingono con l’entusiasmo di cambiare il mondo unendosi alla lotta partigiana.
Ecco, il paesaggio, la fisionomia del pianeta e il suo destino sono fatti politici, luoghi in cui prendono forma idee di libertà, speranze condivise, giustizia sociale o, al contrario, concezioni fondate sul predominio, la sopraffazione, l’esercizio illimitato del potere umano sulla natura, di cui l’uomo stesso è parte.
Viviamo in un mondo che ha bisogno di miti, nuove speranze, e dunque pure di questa rinnovata versione universalistica di Bella ciao: bisogna essere partigiani e scegliere dove collocarsi nella Storia planetaria, contro ogni retorica ipocrita della legittimità di tutte le parti.